“Um” di Helen Phillips: la distopia (troppo) plausibile acclamata dalla critica
Hum di Helen Phillips: una distopia “di casa” su lavoro, maternità e AI. Ipnotico e inquietante, acclamato da Guardian, New Yorker, TIME, Kirkus.
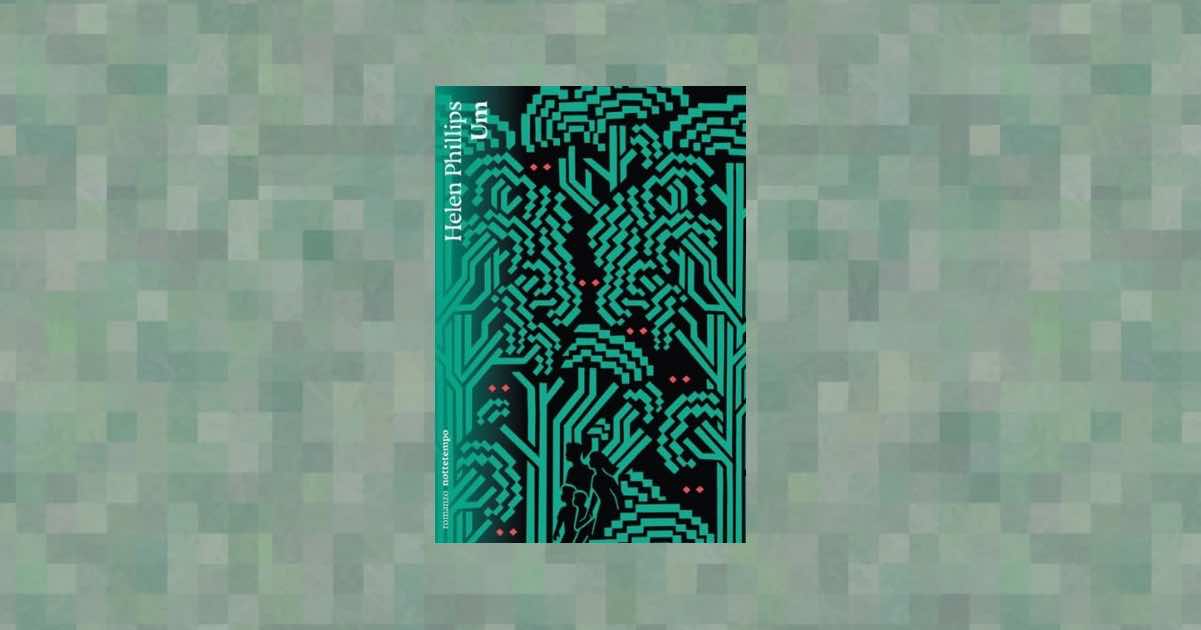
Con “Um” — titolo originale “Hum” — Helen Phillips firma una speculative fiction di prossimità che ha messo d’accordo gran parte della critica anglofona e fatto già tremare la terra sotto i piedi di noi italiani: una storia tesa, “domestica” più che apocalittica, che interroga il presente su automazione del lavoro, sorveglianza, clima e cura.
The Guardian la definisce “an all-too-plausible vision of the future”, una visione del futuro fin troppo plausibile che “ipnotizza e spaventa” perché somiglia al nostro quotidiano; e se tanto assomiglia al quotidiano, il rischio è che faccia la fine di “1984” e che diventi un romanzo “profetico”.
“Um”: una settimana che può cambiare tutto
Siamo a East Gladness, una città post-industriale del Connecticut dove May, poco più che trentenne, ha perso il lavoro a causa della diffusione dei robot-AI chiamati “um”. Per andare avanti e tirare su qualche soldo, accetta di sottoporsi a una procedura sperimentale: un’iniezione che le altera i tratti per renderla irriconoscibile ai sistemi di visione artificiale.
Il marito Jem vive di “gig”, i bambini sono cresciuti tra dispositivi e ansia climatica, la città tossisce aria avvelenata e May cede alla tentazione di acquistare dei biglietti per una giornata “normale” da trascorrere in compagnia della famiglia all’ultimo giardino botanico rimasto…
Nel parco, però, il tentativo di “staccare la spina” precipita in una spirale di incidenti, dilemmi morali, scelte irrevocabili.
Cosa racconta davvero Um
The Time lo presenta come un “disturbing thriller” su clima e bot AI, con la svolta narrativa al giardino botanico.
Lavoro e precarietà nell’era dell’AI
Non è sci-fi “hard”: Phillips punta l’inquadratura sui corpi – turni, debiti, figli, insonnia. L’AI è infrastruttura sociale, non solo gadget: rimpiazza mansioni, ridefinisce la dignità, mercifica persino i volti — il “trattamento” di May è un secondo lavoro pagato sulla sua fisionomia. Kirkus parla di “a perceptive page-turner” sulla maternità, l’identità e le trappole del “progresso”. (“Un page-turner acuto, generoso con la maternità e l’identità, e critico verso le trappole del “progresso”).
Maternità, colpa e controllo
Il romanzo interroga la cura nel capitalismo degli algoritmi. In un saggio/recensione, The New Yorker formula la domanda chiave: “Is A.I. making mothers obsolete?” (“l’AI rende obsolete le madri?”) L’articolo osserva come il libro sposti il fuoco dai meccanismi distopici al lavoro emotivo della genitorialità e alla performance materna sotto lo sguardo sociale.
Quando May sottrae ai figli i device durante la visita al giardino, ne nasce una reazione pubblica che mette in crisi il suo ruolo.
“The book’s chief interest is not Armageddon… but the maternal quest for validation.”
“Il vero interesse del libro non è l’Armageddon, ma la ricerca materna di legittimazione.”
Ambiente
La città di Phillips è un organismo asmatico: polveri nell’aria, acqua incerta, rifiuti sonori. Non c’è cataclisma spettacolare: c’è la stanchezza del mondo.
The Guardian sottolinea i “dark news headlines” innestati nel testo – titoli di cronaca reali dispersi come rumore di fondo – che “blur the line between speculation and reality”. (“Confondono il confine tra speculazione e realtà”).
Stile e scelte formali
Una distopia “di prossimità”
Phillips restringe l’epica allo spazio domestico: una settimana, pochi luoghi, prosa asciutta con improvvise accensioni liriche e humour nerissimo. È una scelta consapevole, spiegata anche in un intervento su LitHub: i “um” sono il paesaggio di sfondo; il centro sono gli esseri umani che tentano di restare tali.
Il dispositivo del “trattamento”
L’idea di un volto reso anonimo agli algoritmi concentra i temi: identità (che cosa resta di me?), economia dell’attenzione (quanto costa smettere di essere identificabili?), mercificazione del corpo (vendere un rischio sanitario in cambio di denaro). È la molla che trasforma una madre qualunque in eroina riluttante.
Il giardino botanico come mito del “naturale”
Il botanical garden è un refugium immaginario, ultimo “fuori” in un mondo totale: non è Eden, è un parco a gestione digitale. Qui la promessa di normalità implode: è dove “Um” passa da osservazione sociale a thriller psicologico.
Che cosa dice la critica
The Guardian: “an all-too-plausible vision of the future” (una visione del futuro fin troppo plausibile); “mesmerising and scary” (ipnotico e spaventoso).
The New Yorker: “The book’s chief interest is not Armageddon but the maternal quest for validation” (Il vero interesse del libro non è l’Armageddon, ma la ricerca materna di legittimazione).
The Time: “a disturbing thriller set in a future plagued by climate change and dominated by AI bots” (un thriller inquietante ambientato in un futuro segnato dal clima e dominato da bot di AI).
Kirkus Reviews: “A perceptive page-turner… and the pitfalls of “progress” (Un page-turner acuto… sulle trappole del “progresso”)