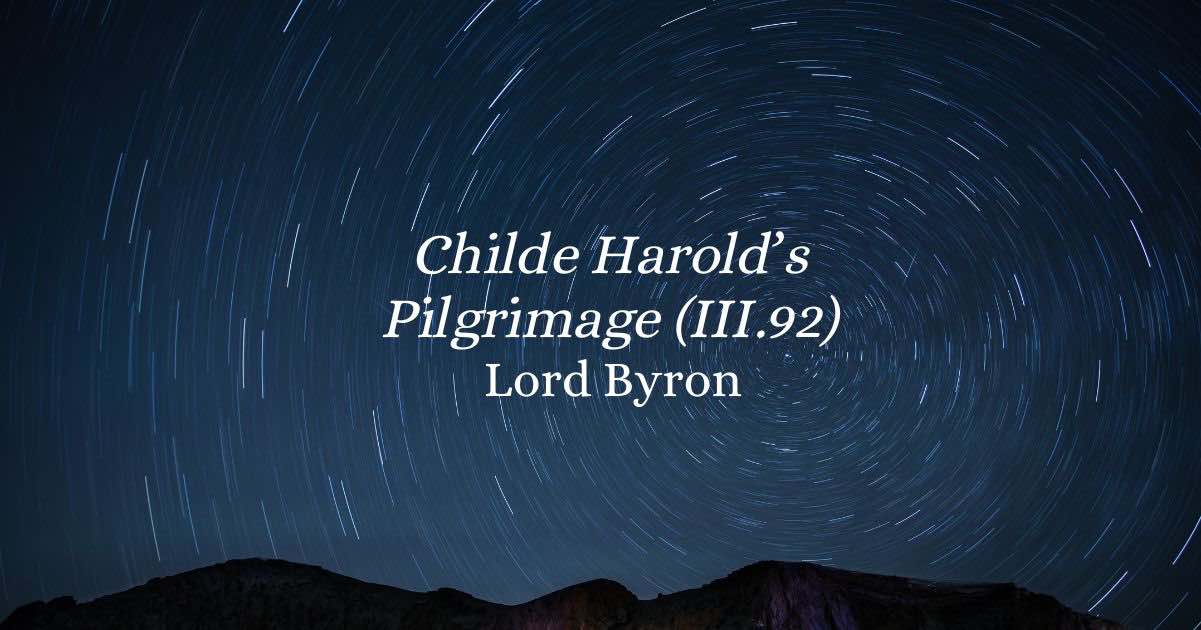C’è un passaggio, nel terzo canto del Childe Harold’s Pilgrimage, in cui Lord Byron riesce a fare quello che la poesia romantica ha sempre cercato: dissolvere i confini tra uomo e universo. Non con parole complicate o dotte citazioni, ma con immagini limpide, essenziali, che sembrano illuminate dalla stessa luce delle stelle di cui parla.
Childe Harold’s Pilgrimage (III.92) di Lord Byron
(Inglese)
There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore,
There is society, where none intrudes,
By the deep Sea, and music in its roar:
I love not Man the less, but Nature more,
From these our interviews, in which I steal
From all I may be, or have been before,
To mingle with the Universe, and feel
What I can ne’er express, yet cannot all conceal.Roll on, thou deep and dark blue Ocean – roll!
Ten thousand fleets sweep over thee in vain;
Man marks the earth with ruin – his control
Stops with the shore;—upon the watery plain
The wrecks are all thy deed, nor doth remain
A shadow of man’s ravage, save his own,
When for a moment, like a drop of rain,
He sinks into thy depths with bubbling groan,
Without a grave, unknelled, uncoffined, and
unknown.(Italiano)
C’è un piacere nei boschi senza sentieri,
un rapimento sulla riva solitaria,
c’è compagnia dove nessuno disturba,
presso il mare profondo, e musica nel suo fragore.
Non amo meno l’uomo, ma amo di più la Natura,
in questi nostri incontri, in cui mi sottraggo
a tutto ciò che sono o che potrei essere stato,
per confondermi nell’Universo e sentire
ciò che non potrò mai esprimere, eppure non riesco
a celare del tutto.Avanza, o Oceano profondo e d’oscuro blu — avanza!
Diecimila flotte solcano invano le tue acque;
l’uomo segna la terra con la rovina — il suo dominio
si ferma alla riva; — sulla tua distesa liquida
i relitti sono opera tua, e non resta
ombra del saccheggio umano, se non la sua,
quando per un attimo, come goccia di pioggia,
sprofonda nelle tue profondità con un gemito gorgogliante,
senza tomba, senza campane, senza bara, e sconosciuto.
Una fuga romantica (nel senso più autentico)
È da qui che si apre uno dei brani più intensi della produzione byroniana: un’ode all’isolamento volontario, alla bellezza selvaggia, al silenzio delle cose non contaminate dall’uomo.
Il Childe Harold’s Pilgrimage è una sorta di diario poetico di viaggio, scritto tra il 1812 e il 1818, che mescola esperienza personale e riflessione esistenziale. Harold, l’alter ego di Byron, è un giovane nobile stanco della società e della guerra, in cerca di qualcosa che dia senso al suo esilio volontario.
Nel Canto III, il poeta si lascia andare a una contemplazione profonda della natura, in particolare del mare e della notte. Ed è qui che compaiono le stelle, non solo come elementi del paesaggio, ma come presenze metafisiche.
“Night’s azure arch and stars innumerable…”
Il cielo notturno diventa una cupola immensa, azzurra, popolata di luci senza nome. Byron non ha bisogno di mitologia o astrologia: ciò che lo affascina è la sproporzione tra l’infinitamente grande e la piccolezza dell’uomo. Ma non c’è angoscia in questo. C’è desiderio.
“And this gray spirit yearning in desire To follow knowledge like a sinking star, Beyond the utmost bound of human thought.”
Il suo spirito grigio — consumato, stanco — desidera. Desidera conoscere, esplorare, spingersi oltre. Le stelle diventano simbolo di un sapere irraggiungibile, ma anche di una tensione vitale che è tipicamente umana: il bisogno di uscire da se stessi, di fondersi con l’universo, anche solo per un attimo.
Una poesia “moderna”, che parla al nostro tempo
Rileggere oggi questi versi ha un sapore stranamente attuale. In un’epoca in cui siamo costantemente connessi, iperstimolati, spaventati dalla solitudine e dal silenzio, Byron ci ricorda che nella solitudine c’è compagnia, che nella natura c’è musica, e che nelle stelle c’è qualcosa che parla direttamente all’anima.
La sua non è una fuga romantica verso la campagna idealizzata, ma un’esplorazione lucida del bisogno di separarsi per ritrovarsi. “There is society where none intrudes”, scrive: c’è società dove nessuno disturba. E oggi, che sentiamo ogni notifica come un urlo, questo verso suona come una carezza.
Cosa dice la critica
I versi di Byron sono tra i più citati nella tradizione romantica inglese. Harold Bloom li ha definiti “una delle più grandi fughe liriche verso l’ineffabile dell’Ottocento”. E non è un caso che molti scrittori e pensatori, da Emerson a Nietzsche, abbiano sentito un’eco di questo slancio interiore nelle proprie opere.
Nella sua lettura critica, Jerome McGann (tra i massimi studiosi di Byron) sottolinea come questi passaggi non siano solo espressione estetica, ma gesti politici: una dichiarazione di sfiducia nei confronti della civiltà occidentale del suo tempo, e un atto di riconnessione col cosmo.
Non solo bellezza: anche inquietudine
C’è però un altro aspetto: la sottile inquietudine che attraversa i versi. L’immagine finale — “To follow knowledge like a sinking star” — è ambigua. Seguire la conoscenza come una stella che sprofonda: è un sogno di trascendenza, o un segnale di fallimento? Non lo sappiamo. Forse entrambi.
Byron sa che la tensione verso l’infinito è sublime, ma anche destinata a rimanere incompiuta. Eppure è proprio questo a renderla vera: un desiderio che non si può esprimere del tutto, ma che non si riesce nemmeno a tenere nascosto.
“What I can ne’er express, yet cannot all conceal.”
Chiunque abbia guardato il cielo notturno in silenzio, almeno una volta, sa esattamente cosa intende.
Un invito a smarrirsi
Leggere Byron oggi, in questi versi, non significa solo ammirare la bellezza di una lingua raffinata. Significa accettare l’invito a perdersi un po’. A lasciare il sentiero. A spegnere il telefono. A guardare in alto, verso un cielo azzurro scuro, pieno di punti che sembrano piccoli — e invece, da vicino, sono mondi.
“There is a pleasure in the pathless woods…”
Forse è il momento di riscoprirlo.