“Sono venuto al mondo” (1973) di Eugenio Montale, la tagliente poesia che racconta la disillusione
Sospesa fra presente e passato, “Sono venuto al mondo” è una poesia in cui Eugenio Montale riflette sul mondo, sui suoi orrori e sulle sue banalità…
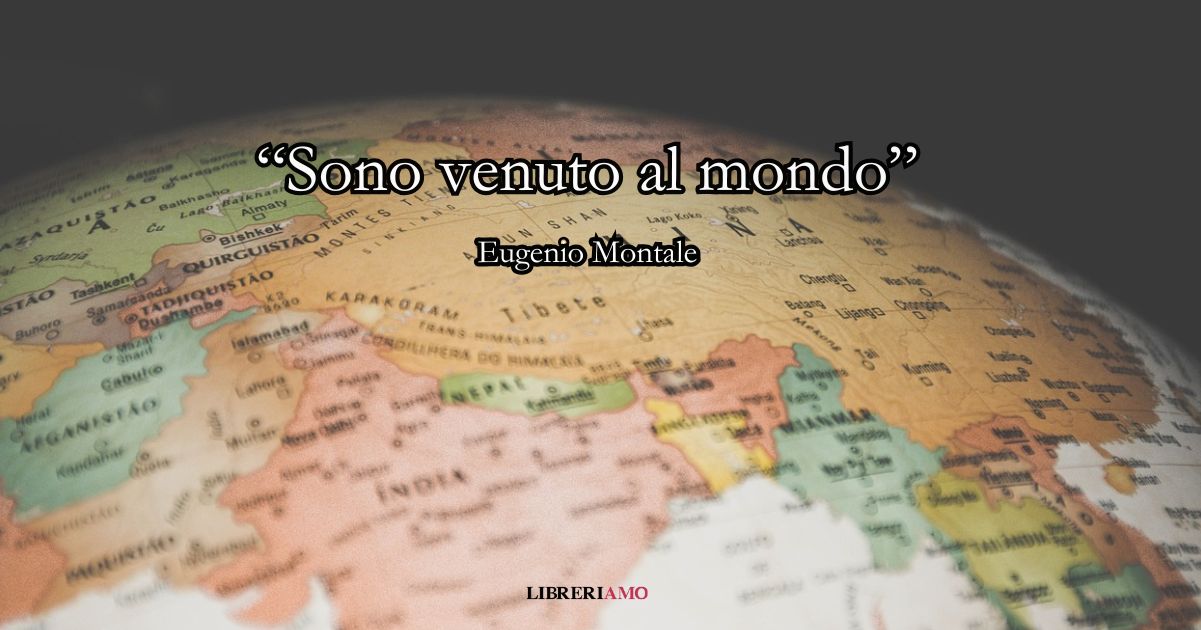
Quanto è banale il male che ogni giorno commettiamo nei confronti del nostro prossimo? Quanto è violento e brutale il mondo che abitiamo, distratti dalla frenesia del quotidiano? Nella sua poesia, “Sono venuto al mondo”, il poeta ligure Eugenio Montale racconta con disillusione questa consapevolezza. Una poesia attuale, che interroga anche noi.
“Sono venuto al mondo” di Eugenio Montale
Sono venuto al mondo in una stagione calma.
Molte porte si aprivano che ora si sono chiuse.
L’ Alma Mater dormiva. Chi ha deciso
di risvegliarla ?Eppure
non furono così orrendi gli uragani del poi
se ancora si poteva andare, tenersi per mano,
riconoscersi.E se non era facile muoversi tra gli eroi
della guerra, del vizio, della jattura,
essi avevano un viso, ora non c’è neppure
il modo di evitare le trappole. Sono troppe.Le infinite chiusure e aperture
possono avere un senso per chi è dalla parte
che sola conta, del burattinaio.
Ma quello non domanda la collaborazione
di chi ignora i suoi fini e la sua arte.E chi è da quella parte ? Se c’è, credo
che si annoi più di noi. Con altri occhi
ne vedremmo più d’uno passeggiare
tra noi con meno noia e più disgusto.
Il significato di questa poesia
Dove leggere “Sono venuto al mondo”
Nel cuore della raccolta Satura, pubblicata in due sezioni tra il 1971 e il 1973, si cela una poesia breve e intensa, dal titolo semplice ma dirompente: “Sono venuto al mondo”.
Appartenente alla seconda parte del libro (Satura II), questo componimento riflette il tono tardo di Eugenio Montale: più prosastico, più spoglio, più ironico, eppure ancora attraversato da una vena lirica sotterranea, da un’inquietudine che non si spegne.
Satura è la raccolta della maturità, del disincanto, della voce che smette i panni dell’oracolo e si fa voce “di un uomo qualunque” nel tumulto del Novecento. Qui, il poeta si fa cronista e testimone di un mondo che si sgretola, osservatore ironico ma non distaccato.
“Sono venuto al mondo” è in questo senso una poesia-emblema: apparentemente semplice, quasi aforistica, ma intrisa di amarezza e lucidità. È il pensiero nudo di un uomo che guarda la propria esistenza e quella della collettività con la lente del tempo e del sospetto.
Lo stile e le immagini
Lo stile adottato da Montale in questo testo è scarno, essenziale, a tratti colloquiale. La metrica è libera, la punteggiatura scarna, le frasi spesso brevi, come battute trattenute tra i denti. Tuttavia, dietro questa sobrietà formale si cela un’architettura complessa, sorretta da immagini nitide e potenti.
Si noti l’efficacia simbolica di quella “stagione calma” in cui il poeta dice di essere nato: un’immagine di apparente quiete che contrasta con le “infinite chiusure e aperture” del presente. I riferimenti all’“Alma Mater” e al “burattinaio” introducono elementi metaforici che toccano il sacro e il profano, il sapere e il destino, senza mai abbandonare il tono disilluso.
E poi ci sono i “visi” degli eroi, che un tempo si potevano riconoscere, mentre oggi “non c’è neppure / il modo di evitare le trappole”: un’immagine dura e cupa della contemporaneità, dove tutto è confuso, indecifrabile.
La poesia alterna un tono elegiaco a uno sferzante, con un uso sapiente dell’enjambement che spezza il verso e lo carica di esitazione e ambiguità.
Il significato della poesia
Nel cuore del testo si percepisce un doppio movimento: da un lato, un ritorno alla memoria, al tempo “in cui si poteva andare, tenersi per mano”; dall’altro, una constatazione gelida sul presente, sul moltiplicarsi di trappole invisibili, sulla perdita di riferimenti, sull’assenza di un senso riconoscibile.
Montale ci dice che non è solo la realtà ad essersi complicata, ma il nostro sguardo a non essere più in grado di coglierla. L’ultima strofa è forse la più tagliente: se davvero esiste un “burattinaio”, egli si annoia “più di noi”.
Nessun disegno superiore, nessuna regia salvifica: solo noia e disgusto. Una visione amara, figlia della delusione storica e personale. Montale ha attraversato il Novecento, le guerre, la fine delle illusioni ideologiche.
Con Satura, e in particolare con poesie come questa, egli registra il fallimento di ogni utopia, il declino della poesia come voce profetica, e al tempo stesso il bisogno di continuare a dire, di testimoniare, anche solo con “il poco che si può”.
“Sono venuto al mondo” è il grido sommesso di chi ha guardato troppo a lungo la realtà, e ne ha colto il vuoto. Ma proprio in quella consapevolezza, nella capacità di restare lucido e umano anche nel disincanto, sta l’estrema forma di resistenza del poeta.