“Scarpette rosse” (1972), una poesia di Anne Sexton sul trauma generazionale
Una poesia di Anne Sexton che affonda le sue radici nella fiaba di Andersen “Scarpette rosse” e affronta il trauma generazionale. Scopri di più…
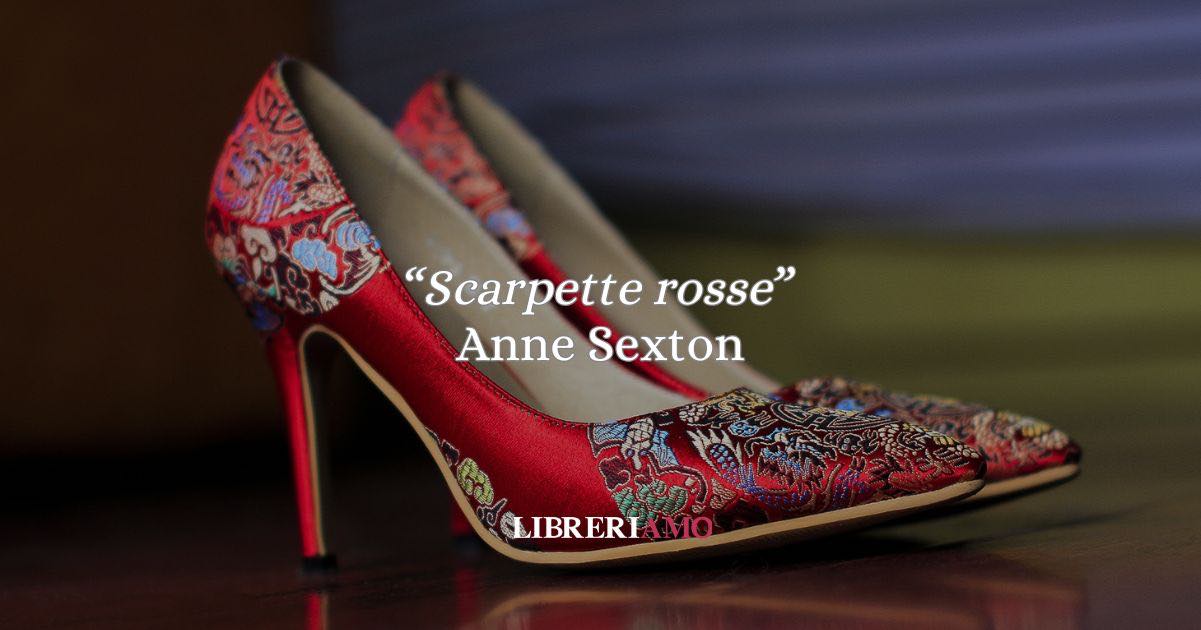
Per parlare di questa poesia bisogna prima raccontare la fiaba omonima di Hans Christian Andersen a chi non la conosce.
Una fiaba cruenta
Pubblicata per la prima volta nel 1845, “Scarpette rosse” parla di una povera bambina di nome Karen che viene adottata da una signora benestante, perché orfana. Tutto sembra filare liscio, fin quando la donna non si ammala e Karen non sceglie un paio di scarpette rosse molto appariscenti e inadeguate con cui fare la cresima…
Con il passare del tempo, le scarpette diventano un simbolo di vanità, egoismo e disobbedienza della ragazza che, dopo averle indossate a un ballo invece di stare accanto alla madre adottiva morente, scopre che sono stregate. Appena le infila, cominciano a ballare da sole, costringendola a danzare senza sosta, giorno e notte, tra boschi, strade e villaggi, senza mai potersi fermare.
A quel punto, non riesce più a toglierle e, disperata, Karen chiede aiuto a un boia che le amputa i piedi per liberarla dalla maledizione. Le scarpette rosse, con i piedi ancora dentro, continuano a danzare da sole e Karen, pentita, si ritira in una piccola casa e si dedica a una vita devota. Alla fine della fiaba, muore in pace e sale in cielo.
Una fiaba da brivido, come lo erano davvero prima dell’arrivo della Disney e della censura, che aveva un chiaro intento morale e cristiano: punire la vanità, la disobbedienza e il culto dell’apparenza. Le scarpe rosse, simbolo di seduzione e desiderio terreno, sono lo strumento della punizione divina.
A questa fiaba fa riferimento “Scarpette rosse”
“The Red Shoes”, la poesia di Anne Sexton, è una delle più emblematiche della raccolta “The Book of Folly” (1972), in italiano “Il libro della follia”, pubblicata da La nave di Teseo. Tra questi versi, Anne Sexton rilegge gli archetipi e le fiabe alla luce della sua esperienza personale, con uno stile spietato e visionario.
Nello specifico, “Scarpette rosse” prende sì spunto dalla fiaba omonima, ma non si limita a riscriverla: la trasforma in un grido, in un atto poetico e politico che parla di violenza, corpo, desiderio e catene familiari.
Ed è proprio contro questo tipo di narrazione che Anne Sexton si ribella nella sua poesia. Invece di mostrare il pentimento e la redenzione, ne amplifica l’orrore, denunciando l’oppressione esercitata sui corpi e desideri delle donne.
“Scarpette rosse” è il racconto di una danza senza fine, di una maledizione ereditaria che passa di madre in figlia come un oggetto proibito. E le scarpette — simbolo di femminilità, sessualità e trasgressione per la Karen di Andersen — diventano qui segno di un destino disturbante, un incubo che prende forma attraverso immagini corporee e oniriche, fino alla dissoluzione finale; un discorso che molte persone, membri di una famiglia disfunzionale, avranno già sentito in terapia: rompere la catena familiare.
“Scarpette rosse” (1972) di Anne Sexton
Eccomi in pista
nella città morta.
M’allaccio scarpette rosse.
La calma è in mio possesso:
l’orologio che formicola,
le dita come cani in fila,
la pentola non bolle ancora rospi,
la sala bianca d’inverno e senza mosche,
la lepre s’acquatta nel muschio prima dello sparo.
M’allaccio scarpette rosse.Non son mie,
son di mia madre
e furon di sua madre.
Tramandate come un cimelio
ma nascoste come lettere sconce.
La strada, la casa di cui fan parte, son celate
e tutte le donne pure
son celate.Tutte le ragazze
che portarono scarpette rosse
salirono su un treno che non si fermò.
Sfrecciarono fra corteggiatori
senza fermarsi alle stazioni.
Ballarono
come trote prese all’amo.
Con loro si giocò.
A loro le orecchie
come spille da balia si strappò.
E caddero le braccia,
diventarono cappelli.
E rotolarono le teste,
cantarono per strada.
E i piedi – oddìo al mercato i piedi –
i piedi loro, scarafaggi
verso un angolo sgusciati,
balzaron poi danzando baldanzosi.
La gente esclamò: di certo
c’è un congegno! Se no…Ma i piedi continuavano.
I piedi non riuscivano a fermarsi.
Caricati a molla come un cobra che ti fissa.
Due elastici tirati sul punto di spezzarsi.
Due isole durante un terremoto.
Due navi in collisione, e affondano.
Non badavano a te e a me.
Non potevano ascoltare.
Non potevano fermarsi.
Quel che fecero fu la danza della morte.Quel che fecero le finirà.
The Red Shoes, Anne Sexton
I stand in the ring
in the dead city
and tie on the red shoes.
Everything that was calm
is mine, the watch with an ant walking,
the toes, lined up like dogs,
the stove long before it boils toads,
the parlor, white in winter, long before flies,
the doe lying down on moss, long before the bullet.
I tie on the red shoes.They are not mine.
They are my mother’s.
Her mother’s before.
Handed down like an heirloom
but hidden like shameful letters.
The house and the street where they belong
are hidden and all the women, too,
are hidden.All those girls
who wore the red shoes,
each boarded a train that would not stop.
Stations flew by like suitors and would not stop.
They all danced like trout on the hook.
They were played with.
They tore off their ears like safety pins.
Their arms fell off them and became hats.
Their heads rolled off and sang down the street.
And their feet – oh God, their feet in the market place –
their feet, those two beetles, ran for the corner
and then danced forth as if they were proud.
Surely, people exclaimed, surely they are mechanical. Otherwise…But the feet went on.
The feet could not stop.
They were wound up like a cobra that sees you.
They were elastic pulling itself in two.
They were islands during an earthquake.
They were ships colliding and going down.
Never mind you and me.
They could not listen.
They could not stop.
What they did was the death dance.What they did would do them in.
Un’eredità tossica: il dolore come cimelio di famiglia
Questa poesia sembra affondare le radici in un conflitto familiare profondo, quasi mitologico. Le scarpe rosse, che “non son mie, son di mia madre / e furon di sua madre”, rappresentano una catena di trasmissione intergenerazionale, in cui ciò che si eredita non è un oggetto d’amore, ma una condanna. Le scarpette sono un cimelio nascosto “come lettere sconce”, e con esse la poetessa eredita anche la vergogna, il trauma, la punizione.
Anne Sexton aveva un rapporto complesso con la propria madre, descritto in più interviste come distante e giudicante. Eredita da lei non tanto delle scarpette, ma una visione distorta della femminilità, fatta di apparenza, repressione e colpa. Il riferimento alla madre non è solo familiare, ma simbolico: rappresenta l’intera genealogia culturale che impone alle donne modelli irraggiungibili e li punisce appena vengono infranti.
L’analisi dei passaggi più potenti
Tra i versi più emblematici della poesia, spicca l’immagine:
“Tutte le ragazze / che portarono scarpette rosse / salirono su un treno che non si fermò.”
Il treno è una metafora dell’ineluttabilità, della corsa verso una fine programmata. Le ragazze non scelgono, sono spinte su rotaie sociali, storiche, familiari. Le “scarpette rosse” le trasformano in oggetti di desiderio e poi in vittime.
“Ballarono / come trote prese all’amo.”
Un’immagine cruda che accosta la danza, atto di libertà e bellezza, alla sofferenza di una preda che si contorce.
“E i piedi – oddìo al mercato i piedi – […] i piedi non riuscivano a fermarsi.”
Il riferimento è diretto alla fiaba di Andersen: nella versione originale, la bambina disobbediente che indossa le scarpette rosse è condannata a danzare fino alla morte.
Anne Sexton: tra poesia e terapia
Nata nel 1928 in Massachusetts, Anne Sexton ha vissuto una vita segnata dalla malattia mentale, dai tentativi di suicidio e da una continua tensione tra il ruolo di madre, donna e scrittrice. Iniziò a scrivere su suggerimento del suo terapeuta, e divenne una delle voci più potenti della poesia confessionale americana, al fianco di Sylvia Plath e Robert Lowell.
Morì suicida nel 1974. In quell’occasione aveva tolto l’anello nuziale, indossato il cappotto di pelliccia della madre, e si era chiusa nel garage. La madre è presente fino alla fine, come nelle scarpe della poesia. Non è difficile vedere quanto questa poesia sia profondamente autobiografica, seppure trasfigurata nell’immaginario fiabesco.