Cesare Pavese, una poesia che parla del buio dell’anima: 9 settembre 1927
La potente e commovente poesia giovanile di Pavese: 9 settembre 1927, un bacio negato, un viaggio nel dolore e nel buio dell’anima.
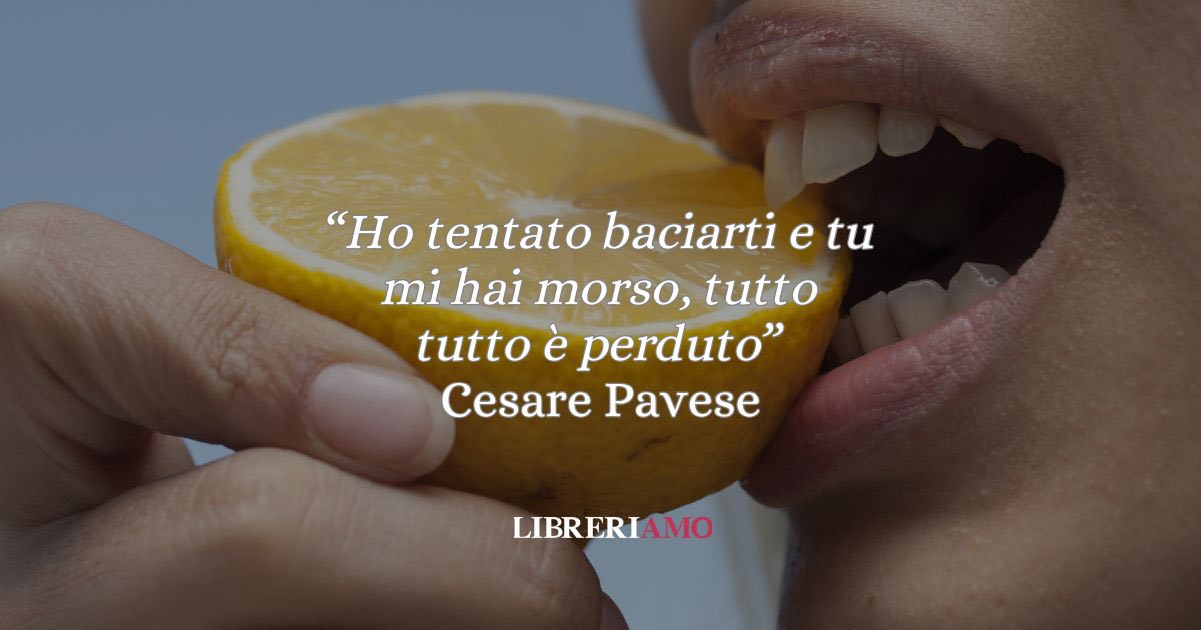
La poesia di Cesare Pavese, datata 9 settembre 1927 che appartiene alla fase giovanile dello scrittore piemontese non ha titolo, ma alcuni la nominano con il primo verso: “Ho tentato baciarti e tu mi hai morso”.
Nelle sue parole, il poeta esprime intensamente la fine di un amore, il buio e la malinconia che si tramuta in un destino fatale, esistenziale: “tutto tutto è perduto”. Una perdita tracciata dalle linee della poetica che via via si farà più pesante e netta.
Siamo negli anni in cui Pavese, appena ventenne, si confronta con il peso dei sentimenti e con un’inquietudine che sarà il fulcro della sua intera opera. È un Pavese che si misura con il mito dell’amore assoluto — senza il quale più nulla esiste (“tutto è perduto” V. 2-9) — ma anche con la sua impossibilità: l’eros si trasforma subito in ferita, e la memoria diventa un tormento (V. 11).
“Ho tentato baciarti e tu mi hai morso” di Cesare Pavese
Ho tentato baciarti e tu mi hai morso,
tutto tutto è perduto.
Possedevo un divino paradiso
in quei giorni lontani.
Vivevo in un gran sogno
che i timori malcerti
di una fine e i rimorsi
mi facevano solo più bello.
Ora ho perduto tutto.
Per volere sapere,
per il mio male implacabile
che non crede al futuro
mi sono gettato nel buio…
·······································
9 settembre 1927
Passi importanti
Il testo si apre con un’immagine immediata e violenta:
«Ho tentato baciarti e tu mi hai morso, / tutto tutto è perduto.»
Nei primi due versi troviamo un bacio negato e una perdita irreparabile: l’intimità, la comunione tra due figure che viene di colpo offesa dai denti, dal morso, e che viene negata, trasformandosi in dolore. Il morso non è soltanto il gesto fisico della persona amata, ma la materializzazione del rifiuto, della distanza incolmabile. In due soli versi Pavese condensa la frustrazione amorosa: dal desiderio di possesso e fusione si passa subito alla constatazione della perdita totale. Quel “tutto tutto” è un raddoppio che amplifica la disperazione, una sottolineatura quasi ossessiva e che si ripresenta nel verso 9.
Dopo l’attacco netto, la poesia diventa nostalgica:
«Possedevo un divino paradiso / in quei giorni lontani.»
Il ricordo del paradiso, tema della memoria, e l’illusione del sogno: due temi che per Pavese resteranno fondamentali nella poetica futura.
In due versi vengono evocati dolcezza e sofferenza insieme, un ricordo agrodolce che andrà a scontrarsi sul finire della poesia con il “male implacabile”. Il paradiso evocato non è soltanto la felicità passata, ma una condizione mitica, irraggiungibile.
«Vivevo in un gran sogno / che i timori malcerti / di una fine e i rimorsi / mi facevano solo più bello.»
La contraddizione è evidente: la felicità era già minata dai presagi di fine, ma proprio questa precarietà la rendeva più intensa, più viva. È una dinamica che Pavese riprenderà spesso: l’amore brucia perché è consapevole della sua fragilità, e la bellezza coincide con la sua natura effimera.
Ed ecco la dimensione drammatica, l’abbandono totale della riflessione agrodolce:
«Per volere sapere, / per il mio male implacabile / che non crede al futuro / mi sono gettato nel buio…»
Il desiderio di sapere, di scoprire il senso della negazione, lascia nel buio e ella disperazione. L’espressione “male implacabile” richiama quella che sarà la nota dominante di Pavese fino agli ultimi giorni: un dolore che non si placa e che non concede tregua.
Qualche parola su Pavese
Nel 1927 Pavese ha soltanto diciannove anni. È un giovane che vive tra Torino e le Langhe, con una formazione classica solida e una crescente passione per la letteratura inglese e americana. È anche un periodo di incertezze sentimentali: gli amori giovanili, spesso non corrisposti o tormentati, incidono profondamente sulla sua scrittura.
La poesia nasce dunque in un contesto in cui l’esperienza amorosa è vissuta come trauma fondante, come iniziazione al dolore. Si tratta di un tema che Pavese non abbandonerà mai: dal Mestiere di vivere alle ultime raccolte poetiche, l’amore e la perdita si intrecceranno fino al gesto estremo del suicidio, nel 1950.
Un bacio negato a chiunque
Al di là del dato autobiografico, la poesia parla a tutti per la sua universalità. Chiunque abbia vissuto un amore negato o spezzato riconosce nei versi di Pavese il dramma di un sentimento trasformato in assenza.
Il bacio mancato diventa simbolo di ogni desiderio frustrato. Il paradiso perduto è l’immagine della felicità irrecuperabile. Il buio finale è la metafora di un dolore che sembra non avere soluzione.
Tuttavia, questa poesia ci spiega come anche il dolore faccia parte di noi, e che l’unico modo di affrontarlo è nominarlo, trasformarlo in parole.