Montale e la poesia “Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale”: il manifesto potente dell’essenzialità
“Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale” di Eugenio Montale: una poesia potente che rifiuta il superfluo e rivela la sua poetica più autentica.
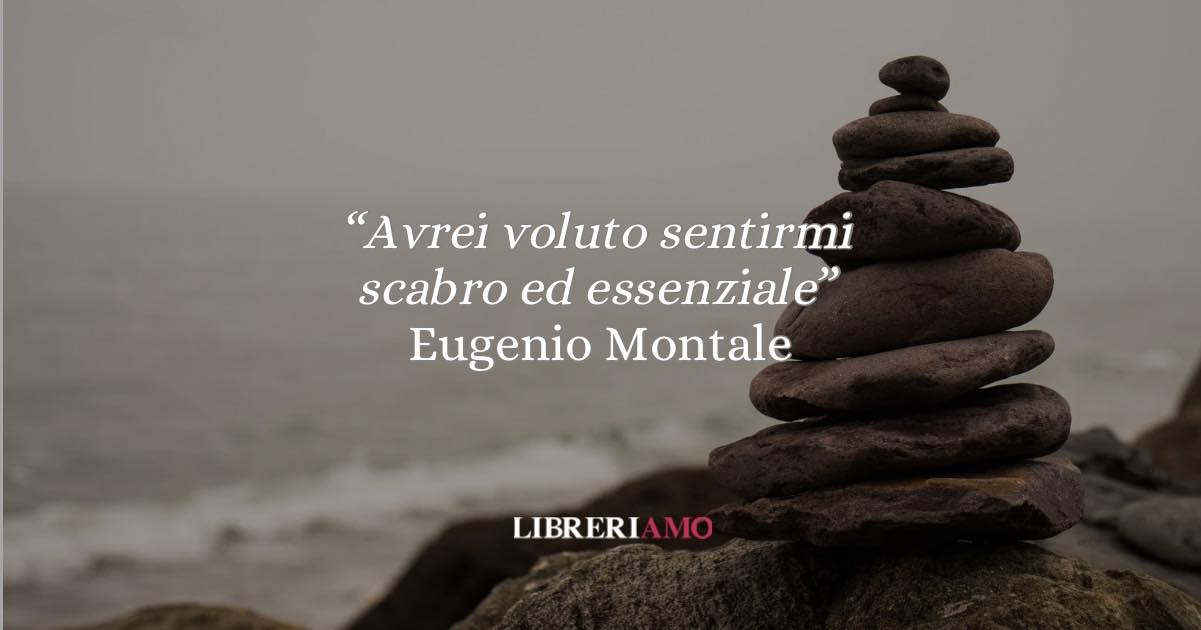
“Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale” è una poesia che mette in luce il conflitto interiore di Eugenio Montale, lo stesso conflitto che attraversa tutta la sua opera: l’ermetismo. La ricerca della parola essenziale, nuda, spoglia, necessaria, e la constatazione della complessità della vita e del pensiero.
Questo testo, che prende titolo dal primo verso, è uno dei momenti più intensi della riflessione montaliana sul ruolo del poeta e sulla possibilità stessa della poesia. Non a caso, in controluce, vi si legge il dialogo con Gabriele D’Annunzio e con quella “pagina rombante” che Montale rifiuta, in nome di una scrittura più sobria e tagliente.
La poesia nasce a rischiarare un periodo cruciale per la letteratura italiana, segnato dal passaggio tra il decadentismo dannunziano e le nuove poetiche del Novecento. Montale si pone come voce alternativa, portatore di un modello che rifiuta l’eccesso retorico per abbracciare una parola più scabra e quotidiana.
“Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale” di Eugenio Montale
Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale
siccome i ciottoli che tu volvi,
mangiati dalla salsedine;
scheggia fuori del tempo, testimone
di una volontà fredda che non passa.Altro fui: uomo intento che riguarda
in sé, in altrui, il bollore
della vita fugace – uomo che tarda
all’atto, che nessuno, poi, distrugge.Volli cercare il male
che tarla il mondo, la piccola stortura
d’una leva che arresta
l’ordegno universale; e tutti vidi
gli eventi del minuto
come pronti a disgiungersi in un crollo.Seguìto il solco d’un sentiero m’ebbi
l’opposto in cuore, col suo invito; e forse
m’occorreva il coltello che recide,
la mente che decide e si determina.Altri libri occorrevano
a me, non la tua pagina rombante.
Ma nulla so rimpiangere: tu sciogli
ancora i groppi interni col tuo canto.
Il tuo delirio sale agli astri ormai.
Questa poesia è un autoritratto in negativo. Montale dice di aver desiderato una vita e una scrittura scabra, come i ciottoli levigati dal mare, ridotti all’essenziale, capaci di essere “testimoni fuori dal tempo”. Ma riconosce di essere stato altro: un uomo pensoso, esitante, incline all’analisi piuttosto che all’azione.
Il testo diventa allora una riflessione sulla missione della poesia: non un canto roboante e sensuale, come quello di D’Annunzio che si può trovare nell’“Alcyone”, ma una parola che cerca la verità nascosta, la “stortura” che “inceppa l’ordegno universale” (V. 12). L’intenzione è quella di marcare una distanza da una tradizione lirica ormai consunta, per affermare una nuova poetica fondata sull’essenzialità, sulla verità spoglia, sul rifiuto del superfluo.
“Altro fui: uomo intento che riguarda in sé, in altrui, il bollore della vita fugace”
Qui emerge l’ammissione di una natura diversa: non l’essenzialità, ma la complessità dell’osservazione. Montale si descrive come uomo che riflette, che ritarda l’azione, che non riesce a recidere con un colpo netto. È un’autocritica, ma anche il riconoscimento della sua inclinazione poetica.
“Volli cercare il male che tarla il mondo”
Questi versi rappresentano il cuore filosofico del testo. Montale non si accontenta di osservare la vita, ma cerca il difetto nascosto, la piccola crepa che incrina il meccanismo del mondo. È la sua “vocazione negativa”: la ricerca non del senso pieno, ma del male, della mancanza, dell’imperfezione.
“Forse m’occorreva il coltello che recide, la mente che decide e si determina”
Qui il poeta esprime il rimpianto di non aver avuto la forza di un taglio netto, di una decisione risoluta. È la contrapposizione tra esitazione e azione, tra pensiero e atto.
“Altri libri occorrevano a me, non la tua pagina rombante”
Il riferimento polemico è a Gabriele D’Annunzio e alla sua poesia ridondante, “rombante” appunto. Montale dichiara la necessità di altri maestri, di una scrittura sobria, meno decorativa e più aderente alla verità del mondo.
“Ma nulla so rimpiangere: tu sciogli ancora i groppi interni col tuo canto”
Eppure, il giudizio non è del tutto negativo: anche se rifiuta il modello dannunziano, Montale ammette che la sua poesia ha avuto un effetto liberatorio, capace di sciogliere nodi interiori. È un riconoscimento dell’efficacia della grande arte, anche quando si sceglie un’altra via.
Qualche parola su Montale
Eugenio Montale (1896–1981), premio Nobel per la letteratura nel 1975, fu voce centrale del Novecento italiano. Nato a Genova, trascorse gran parte della sua giovinezza in Liguria, luogo che influenzò profondamente la sua poesia, soprattutto nella raccolta “Ossi di seppia” (1925), da cui è tratta “Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale”.
In quegli anni l’Italia letteraria era ancora dominata dall’eredità di D’Annunzio, il poeta-vate che con la sua lingua ricca e sonora aveva rappresentato l’apice del decadentismo. Montale, invece, si pone come anti-dannunziano: sceglie una poesia scarna, quotidiana, legata alla realtà concreta. È il poeta della “linea ligure”, della pietra, della secchezza, contrapposta al lusso e alla sensualità del Vate.
Questa poesia è quindi non solo un autoritratto, ma anche un manifesto poetico e culturale: Montale dichiara a quale tradizione non vuole appartenere, e quale strada intende seguire.
Il desiderio di “essenzialità”
La poesia ci mostra anche l’importanza di accettare la propria natura: Montale avrebbe voluto essere “scheggia fuori del tempo”, ma si riconosce come uomo esitante, pensoso, incapace di decisioni drastiche. Eppure, proprio questa sua fragilità diventa forza poetica. Il dialogo implicito con D’Annunzio ricorda al lettore che ogni epoca deve ridefinire il senso della poesia: ieri come oggi, la sfida è trovare parole che non siano vuote, che non si limitino a “rombare”, ma che riescano a sciogliere “i groppi interni” di chi legge.
“Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale” è una delle liriche più significative di Montale perché unisce confessione personale e dichiarazione di poetica. Nel desiderio di una parola ridotta all’osso, nell’ammissione della propria esitazione, nella polemica con D’Annunzio, si condensa la svolta del Novecento italiano: dalla retorica all’essenzialità, dall’eccesso al necessario.