L’aquilone (1899) di Pascoli: poesia sulla giovinezza spezzata che diventa salvezza
Scopri perché una vita finita troppo presto diventa salvezza grazie ai versi di “L’aquilone”, il poema di Giovanni Pascoli in ricordo dell’amico Pirro.
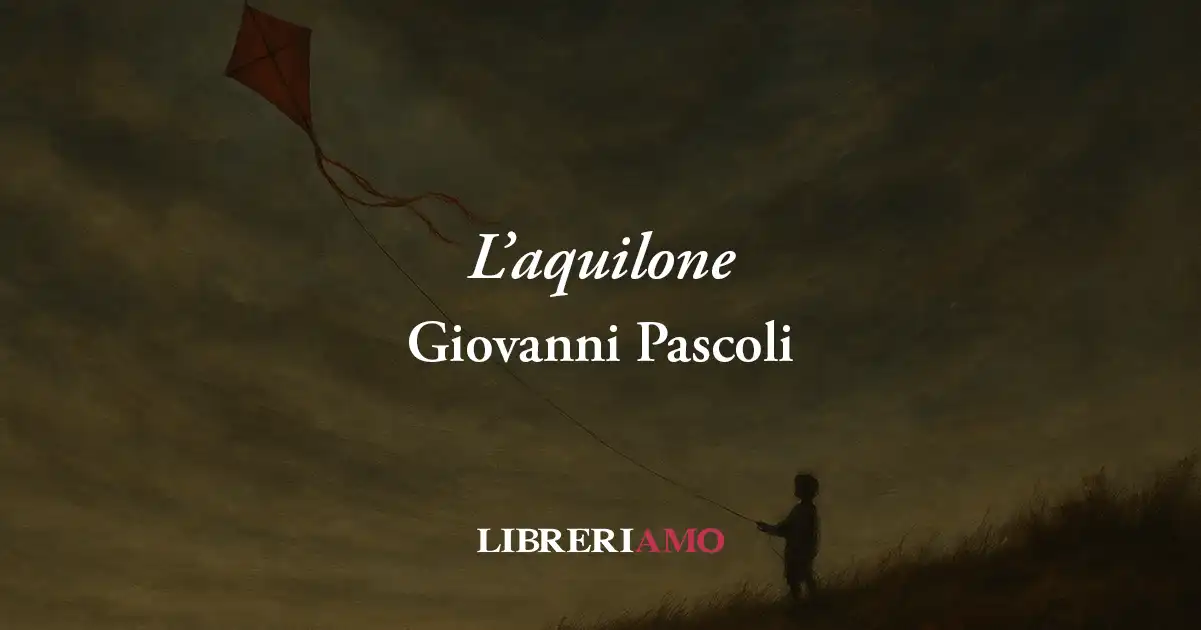
L’aquilone di Giovanni Pascoli è un poemetto che rovescia la nostra idea di vita e destino. Per il poeta, vivere a lungo non è un premio ma una condanna, significa assistere alla lenta caduta dei propri sogni, vedere le illusioni sgretolarsi una dopo l’altra. Morire giovani, invece, diventa paradossalmente una salvezza, perché permette di portare con sé un mondo interiore ancora intatto, puro, non violato dall’amarezza dell’età adulta.
Nell’universo pascoliano, memoria e morte sono le uniche vere difese contro la realtà. La vita consuma, disincanta, ferisce; la memoria preserva, la morte protegge. È un pensiero radicale, quasi scandaloso agli occhi di oggi, eppure profondamente coerente con la sensibilità fragilissima del poeta di San Mauro di Romagna.
L’aquilone fu composto nel 1899 e fa parte della seconda edizione della raccolta di poesie Poemetti di Giovanni Pascoli publicata nel 1900. Dalla terza edizione del 1904 la raccolta fu titolata dal poeta Primi Poemetti. Dentro questo libro, L’aquilone è uno dei testi più rivelatori, un rito della memoria, un frammento di infanzia che riemerge per parlare della condizione umana, del destino delle illusioni e del prezzo che si paga crescendo.
Leggiamo il poema di Giovanni Pascoli per scoprirne il profondo significato.
L’aquilone di Giovanni Pascoli
C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole,
anzi d’antico: io vivo altrove, e sento
che sono intorno nate le viole.Son nate nella selva del convento
dei cappuccini, tra le morte foglie
che al ceppo delle quercie agita il vento.Si respira una dolce aria che scioglie
le dure zolle, e visita le chiese
di campagna, ch’erbose hanno le soglie:un’aria d’altro luogo e d’altro mese
e d’altra vita: un’aria celestina
che regga molte bianche ali sospese…sì, gli aquiloni! E’ questa una mattina
che non c’è scuola. Siamo usciti a schiera
tra le siepi di rovo e d’albaspina.Le siepi erano brulle, irte; ma c’era
d’autunno ancora qualche mazzo rosso
di bacche, e qualche fior di primaverabianco; e sui rami nudi il pettirosso
saltava, e la lucertola il capino
mostrava tra le foglie aspre del fosso.Or siamo fermi: abbiamo in faccia Urbino
ventoso: ognuno manda da una balza
la sua cometa per il ciel turchino.Ed ecco ondeggia, pencola, urta, sbalza,
risale, prende il vento; ecco pian piano
tra un lungo dei fanciulli urlo s’inalza.S’inalza; e ruba il filo dalla mano,
come un fiore che fugga su lo stelo
esile, e vada a rifiorir lontano.S’inalza; e i piedi trepidi e l’anelo
petto del bimbo e l’avida pupilla
e il viso e il cuore, porta tutto in cielo.Più su, più su: già come un punto brilla
lassù, lassù… Ma ecco una ventata
di sbieco, ecco uno strillo alto… – Chi strilla?Sono le voci della camerata mia:
le conosco tutte all’improvviso,
una dolce, una acuta, una velata…A uno a uno tutti vi ravviso,
o miei compagni! E te, sì, che abbandoni
su l’omero il pallor muto del viso.Sì: dissi sopra te l’orazioni,
e piansi: eppur, felice te che al vento
non vedesti cader che gli aquiloni!Tu eri tutto bianco, io mi rammento:
solo avevi del rosso nei ginocchi,
per quel nostro pregar sul pavimento.Oh! te felice che chiudesti gli occhi
persuaso, stringendoti sul cuore
il più caro dei tuoi cari balocchi!Oh! dolcemente, so ben io, si muore
la sua stringendo fanciullezza al petto,
come i candidi suoi pètali un fioreancora in boccia! O morto giovinetto,
anch’io presto verrò sotto le zolle
là dove dormi placido e soletto…Meglio venirci ansante, roseo, molle
di sudor, come dopo una gioconda
corsa di gara per salire un colle!Meglio venirci con la testa bionda,
che poi che fredda giacque sul guanciale,
ti pettinò co’ bei capelli a onda tua madre…adagio, per non farti male.
Una poesia che è il simbolo di una giovinezza spezzata
L’aquilone è una poesia di Giovanni Pascoli che porta in superficie uno dei pensieri più radicali della poetica pascoliana. L’infanzia non è soltanto un ricordo felice, è un luogo interiore che protegge dal disincanto del mondo. Quando questo luogo si perde, inizia la parte più dolorosa della vita. Per Pascoli il dolore nasce proprio dalla distanza tra ciò che si è stati e ciò che si è costretti a diventare.
Dentro questa prospettiva, la morte giovanile assume un significato che sorprende il lettore contemporaneo. Non è solo un evento tragico, ma una forma estrema di innocenza che si conserva. L’aquilone che sale nel cielo è l’immagine di un’anima che rimane intatta, che sfugge al destino di chi cresce e vede le illusioni spegnersi una dopo l’altra.
È un pensiero che intreccia tenerezza, nostalgia e un lutto mai risolto, e che restituisce alla memoria un potere salvifico. Pascoli sembra suggerire che ciò che la vita toglie, la memoria può restituire, e che nelle immagini del passato sopravvive l’unica forma possibile di consolazione.
L’aquilone racconta una giovinezza spezzata ma salvata nel punto esatto in cui era ancora pura. Il compagno che muore giovane non conoscerà mai la caduta delle illusioni, mentre il poeta adulto vive ormai da tempo in quel dolore. L’aquilone del bambino resta per sempre sospeso nel cielo di Urbino, mentre quello di Pascoli è già da tempo caduto a terra.
La genesi de L’aquilone, la morte dell’amico Pirro
“L’aquilone” nasce nel 1899 da una precisa sovrapposizione temporale. Un giorno d’autunno che sembra primavera innesca nel poeta il ricordo degli anni trascorsi nel collegio Raffaello di Urbino (1862-1871).
Il cuore narrativo del poema è la rievocazione di una giornata di vacanza scolastica e, in particolare, la figura di Pirro Viviani, un compagno di scuola morto prematuramente a diciassette anni. Tuttavia, come Pascoli stesso chiarì in una lettera all’amico Tommaso Ricciarelli (1901), l’opera non è una semplice cronaca autobiografica.
Quel ragazzo non rappresenta solo se stesso, ma diventa il simbolo di una giovinezza spezzata che riguarda tutti: è una commemorazione collettiva della morte dell’infanzia e delle sue illusioni, di cui l’aquilone che vola alto è l’emblema perfetto.
Se il tema della “morte giovane” avvicina il testo a Giacomo Leopardi (e alla sua A Silvia), Pascoli ne ribalta il senso filosofico. Mentre per Leopardi la morte precoce è una tragedia che nega la vita, per Pascoli essa diventa un triste privilegio.
La morte infantile è vista paradossalmente come una salvezza. Chi muore giovane si risparmia la disillusione dell’età adulta, portando via con sé i sogni intatti. Questa visione culmina nell’immagine finale della madre che pettina il figlio morto: una scena che rivela il nucleo profondo della poetica pascoliana, dove la morte non è fine, ma una dolce regressione verso il rifugio sicuro e protettivo dell’abbraccio materno.
La spiegazione dei versi de L’aquilone di Pascoli
Il poema si apre con un gioco di percezioni che disorienta. Pascoli è adulto, ma un’aria insolitamente mite inganna i sensi e lo riporta indietro nel tempo. Il famoso attacco, “C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico”, è l’interruttore che accende la memoria. Ciò che appare nuovo è in realtà qualcosa di già vissuto.
Il contrasto fra le viole appena nate e le foglie morte del bosco dei Cappuccini crea una tensione visiva che rispecchia la dinamica dell’illusione. La natura sembra recitare una parte, come se volesse imitare la primavera pur essendo ancora immersa nell’autunno. È un’illusione della percezione che diventa metafora delle illusioni della vita, splendide ma destinate a dissolversi.
Urbino come teatro della memoria
Il ricordo prende forma nel paesaggio di Urbino, dove Pascoli trascorse gli anni del collegio Raffaello. L’ambiente non è un semplice sfondo, ma una vera scenografia emotiva.
Le siepi di rovo e di albaspina, le bacche rosse rimaste per caso, i primi fiori bianchi che annunciano la primavera, costruiscono un paesaggio in bilico fra dolcezza e durezza. È il riflesso dell’età infantile, che è insieme gioco e ferita, luce e spine.
È in questo luogo, sospeso fra stagioni diverse, che appare l’oggetto simbolico capace di accendere la scena: l’aquilone.
L’aquilone come immagine dell’anima che fugge
Il volo dell’aquilone è reso con una vivacità straordinaria. Non è un semplice giocattolo, ma qualcosa che sembra animato da una forza propria. Pascoli lo descrive mentre ondeggia, sale, perde l’equilibrio, poi si riprende. La similitudine con il fiore che fugge sullo stelo suggerisce un’immagine naturale, fragile, bellissima.
Il filo diventa lo stelo che ancora l’aquilone alla terra. Quando l’aquilone lo strappa, sembra voler fuggire dalla realtà verso un luogo più lieve, un altrove dove non esistono peso né dolore. È la rappresentazione poetica dell’illusione che tenta di sottrarsi alla gravità del mondo.
Il paradosso centrale: la fortuna di morire giovani
A un certo punto il ricordo cambia tono. Le voci della camerata si sovrappongono e una emerge con più forza: quella di Pirro Viviani, il compagno morto a diciassette anni. È qui che il poemetto rivela il suo nucleo più radicale.
Pascoli considera Pirro felice perché ha visto cadere solo gli aquiloni, non le grandi illusioni della vita. Ha lasciato il mondo stringendo sul petto il suo balocco preferito, portando con sé la dolcezza della fanciullezza.
Per il poeta questo è un privilegio amaro. Chi non cresce non conosce il peso delle delusioni, non vede frantumarsi sogni e aspettative. Il dolore dell’età adulta risparmia chi se ne va troppo presto.
Il finale e la cura materna che annulla la morte
Gli ultimi versi racchiudono una delle immagini più tenere e struggenti della poesia italiana. Giovanni Pascoli immagina Pirro disteso dopo la morte, con la madre che gli pettina dolcemente i capelli biondi. Il gesto è lento, attento, come se il corpo potesse ancora provare dolore.
Questa scena racchiude tutto il mondo emotivo del poeta. Nella morte rinasce l’infanzia, perché la morte diventa ritorno alla madre, all’unico luogo dove non esiste il pericolo, dove non c’è più nulla da temere. È una consolazione estrema che unisce infanzia, memoria e lutto in un’unica immagine luminosa e terribile.