“La sera fiesolana” (1899) di Gabriele D’Annunzio: il crepuscolo come canto d’amore
“La sera fiesolana”, una poesia di Gabriele D’Annunzio che si trova nella raccolta “Alcyone”. Inno alla sera e preghiera laica da scoprire nell’articolo.
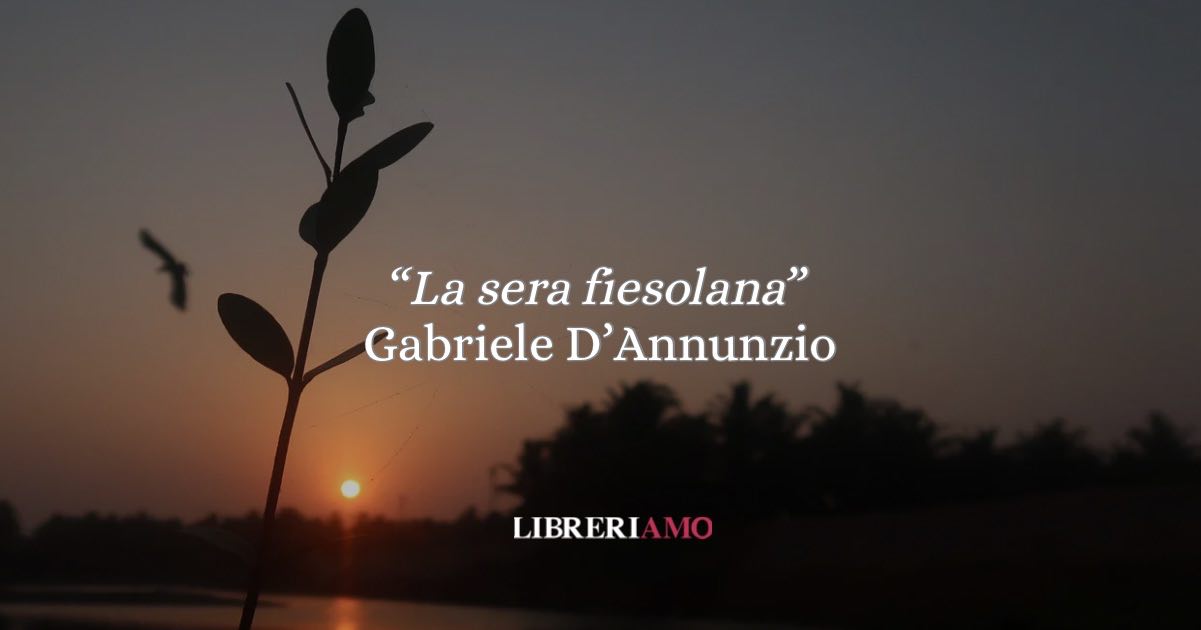
“La sera fiesolana” (1899) è uno dei componimenti più celebri di Gabriele D’Annunzio, spesso inserito nelle antologie scolastiche e pubblicato all’interno della raccolta “Alcyone” del 1903.
La poesia non è solo contemplazione del paesaggio, ma una sorta di preghiera laica rivolta alla sera, dove il poeta la invoca e la loda come si farebbe con una divinità: una fusione perfetta tra uomo, natura e arte tipica del movimento decadente ed estetico cui prenderà parte.
Il componimento nasce durante un soggiorno fiorentino, quando la dolcezza dei colli di Fiesole e la luce della sera ispirano un canto in cui la natura toscana diventa eterna e sacra. Nella stesura, D’Annunzio alterna il ritmo lento e cadenzato della contemplazione al fervore sensuale di immagini tattili e olfattive, fondendo elementi classici e cristiani, sacro e profano.
“La sera fiesolana” (1899) di Gabriele D’Annunzio
Fresche le mie parole ne la sera
ti sien come il fruscìo che fan le foglie
del gelso ne la man di chi le coglie
silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta
su l’alta scala che s’annera
contro il fusto che s’inargenta
con le sue rame spoglie
mentre la Luna è prossima a le soglie
cerule e par che innanzi a sé distenda un velo
ove il nostro sogno si giace
e par che la campagna già si senta
da lei sommersa nel notturno gelo
e da lei beva la sperata pace
senza vederla.Laudata sii pel tuo viso di perla,
o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace
l’acqua del cielo!Dolci le mie parole ne la sera
ti sien come la pioggia che bruiva
tepida e fuggitiva,
commiato lacrimoso de la primavera,
su i gelsi e su gli olmi e su le viti
e su i pini dai novelli rosei diti
che giocano con l’aura che si perde,
e su ’l grano che non è biondo ancóra
e non è verde,
e su ’l fieno che già patì la falce
e trascolora,
e su gli olivi, su i fratelli olivi
che fan di santità pallidi i clivi
e sorridenti.Laudata sii per le tue vesti aulenti,
o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce
il fien che odora!Io ti dirò verso quali reami
d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti
eterne a l’ombra de gli antichi rami
parlano nel mistero sacro dei monti;
e ti dirò per qual segreto
le colline su i limpidi orizzonti
s’incùrvino come labbra che un divieto
chiuda, e perché la volontà di dire
le faccia belle
oltre ogni uman desire
e nel silenzio lor sempre novelle
consolatrici, sì che pare
che ogni sera l’anima le possa amare
d’amor più forte.Laudata sii per la tua pura morte,
o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare
le prime stelle!
D’Annunzio è trasformare un momento fugace — il calare della sera — in un’esperienza assoluta, quasi mistica. La “Sera” non è soltanto un fenomeno naturale, ma una figura femminile e divina, a cui il poeta si rivolge con un “Laudata sii” che riecheggia il “Cantico delle Creature” di San Francesco.
Questa invocazione non ha però un contenuto strettamente religioso: è un’estasi estetica, un’esaltazione dei sensi, dove la natura viene venerata come un’entità viva che consola, seduce e pacifica.
I passaggi chiave
La poesia si apre con un’immagine estremamente intima e delicata: “Fresche le mie parole ne la sera / ti sien come il fruscìo che fan le foglie…”
Qui, il poeta paragona le proprie parole a un suono lieve, quasi impercettibile, suggerendo un approccio sommesso, rispettoso, alla grandezza della natura. Il paragone con il lavoro di un raccoglitore di gelsi introduce subito la dimensione sensoriale: vista, udito e tatto si intrecciano.
L’anafora di “Laudata sii” scandisce la struttura, suddividendo la poesia in momenti tematici: il viso della sera, le sue vesti, la sua “pura morte” (cioè il momento in cui cede il passo alla notte). Ogni lode è accompagnata da una serie di immagini concrete: gli alberi, il grano, il fieno, gli olivi “fratelli”, descritti con un affetto quasi fraterno.
Nella seconda parte, il paesaggio diventa più enigmatico e simbolico: il fiume che chiama “a reami d’amor”, le colline che si curvano “come labbra che un divieto chiuda”. La natura è antropomorfizzata, trasformata in corpo e gesto, capace di parlare e di custodire segreti.
Il verso finale, “Laudata sii per la tua pura morte, o Sera”, sintetizza il senso ultimo: la sera è un momento di chiusura, ma anche di attesa e promessa. La “morte” non è negazione, bensì passaggio, preludio all’apparizione del mattino a seguire.
D’Annunzio e l’estetica italiana
Gabriele D’Annunzio (1863–1938), figura centrale del Decadentismo italiano, vive un’esistenza segnata dall’arte, dall’amore e dalla ricerca costante del bello. Nei primi anni del Novecento, la sua produzione poetica si concentra sulla celebrazione sensuale della natura, vista come luogo di fusione tra l’io e il cosmo. “Alcyone”, raccolta a cui appartiene “La sera fiesolana”, rappresenta il culmine di questa visione.
In Toscana, D’Annunzio trova un paesaggio che si presta perfettamente alla sua poetica: le colline dolci, i tramonti dorati, il ritmo agricolo della vita contadina. Qui la sua sensibilità estetica si unisce a un’eco di sacralità francescana, filtrata però da un senso moderno, sensuale e artistico della vita.