La Paura (1945) di Carlos Drummond de Andrade, poesia sul potere del timore
Scopri come La paura domina la società umana grazie ai versi della poesia di Carlos Drummond de Andrade, poeta brasiliano che dipinge il presente.
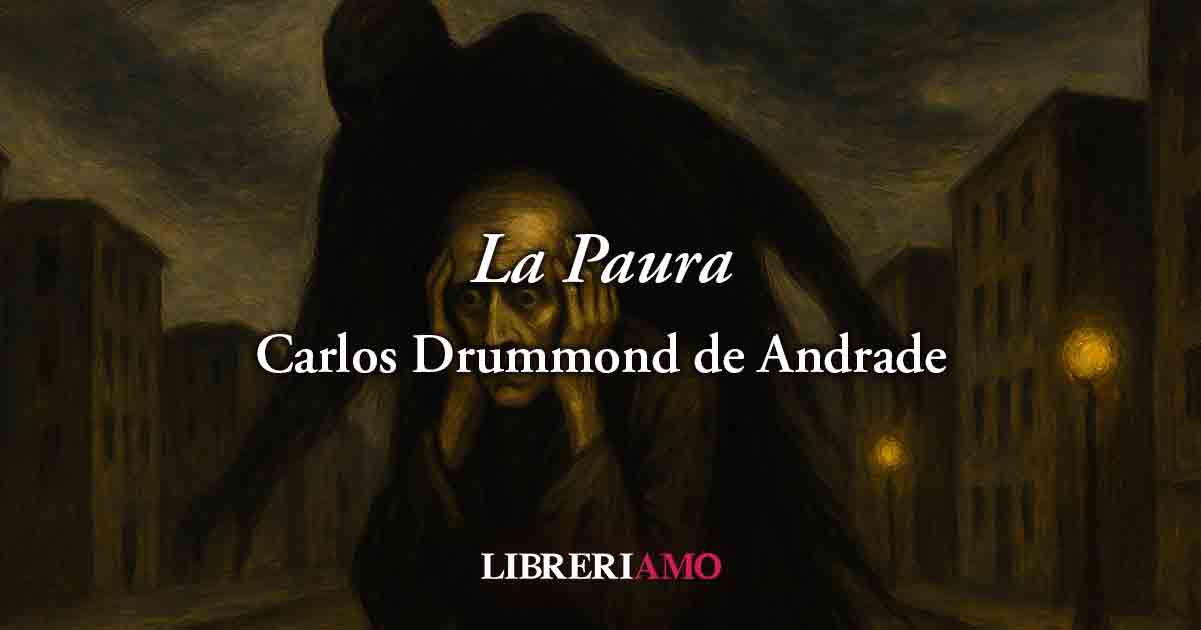
La paura (1945) di Carlos Drummond de Andrade è una poesia che sembra scritta oggi e che offre la condizione universale dell’umanità e dello stesso Pianeta. Viviamo in un’epoca in cui la tensione sociale è quotidiana. Lo scontro non riguarda solo le guerre, ma il semplice “stare insieme”. Dal micro delle relazioni al macro della politica globale, la sensazione diffusa è che qualcosa di catastrofico stia per deflagrare.
Eppure, questa atmosfera non è nuova. Carlos Drummond de Andrade l’aveva già fotografata ben ottant’anni fa, realizzando una lirica che trasforma un’emozione privata in condizione collettiva, cemento di città, istituzioni, affetti. È per questo che la sua poesia, letta oggi, suona come un referto clinico del presente. Quest’opera resta un ritratto impressionante di come la paura modelli la nostra esistenza: ieri come oggi.
La paura fu scritta trav il 1943 3 il 1945 e fa parte della raccolta di poesie A rosa do Povo (La rosa del Popolo) di Carlos Drummond de Andrade, pubblicata per la prima volta nel 1945.
Leggiamo questa meravigliosa poesia di Carlos Drummond de Andrade per coglierne l’attualità.
La Paura
In verità abbiamo paura.
Nasciamo al buio.
Le esistenze sono poche:
postino, dittatore, soldato.
Il nostro destino, incompleto.E siamo stati educati alla paura.
Annusiamo fiori di paura.
Vestiamo panni di paura.
Per paura, guadiamo fiumi rossi.Siamo soltanto uomini
e la natura ci ha traditi.
Ci sono gli alberi, le fabbriche,
malattie galoppanti, carestie.Ci rifugiamo nell’amore,
questo celebre sentimento,
ma l’amore mancò: pioveva,
tirava vento, faceva freddo a San Paolo.Faceva freddo a San Paolo… Nevica.
La paura, con la sua cappa,
ci dissimula e ci culla.Ho avuto paura di te,
mio compagno dalla pelle scura.
Di noi, di voi, di tutto.
Ho paura dell’onore.Così ci fanno borghesi.
La nostra strada è tracciata.
Perché morire insieme?
E se invece vivessimo?Vieni, armonia della paura,
vieni, terrore delle strade,
spavento notturno, timore
delle acque inquinate. Stampelledell’uomo solo. Aiutateci,
lenti poteri del laudano.
Perfino la canzone timorosa
si spezza, si agita e tace.Faremo case di paura,
duri mattoni di paura,
paurosi steli, zampilli,
strade soltanto di paura e calma.E con ali di prudenza,
con splendori codardi,
raggiungeremo la vetta
della nostra cauta salita.La paura, con la sua fisica,
produce tanto: carcerieri,
edifici, scrittori,
questa poesia; altre vite.Abbiamo il più grande terrore.
I più anziani lo comprendono.
La paura li ha cristallizzati.
Sagge statue, addio.Addio: andiamo avanti,
arretrando con occhi accesi.
I nostri figli così felici…
Fedeli eredi della paura,popolano la città.
Dopo la città, il mondo.
Dopo il mondo, le stelle,
ballando il ballo della paura.
O Medo
A Antonio Candido
“Porque há para todos nós um problema sério…
Este problema é o do medo.”
(Antonio Candido, Plataforma de Uma Geração)Em verdade temos medo.
Nascemos escuro.
As existências são poucas:
Carteiro, ditador, soldado.
Nosso destino, incompleto.E fomos educados para o medo.
Cheiramos flores de medo.
Vestimos panos de medo.
De medo, vermelhos rios
vadeamos.Somos apenas uns homens
e a natureza traiu-nos.
Há as árvores, as fábricas,
Doenças galopantes, fomes.Refugiamo-nos no amor,
este célebre sentimento,
e o amor faltou: chovia,
ventava, fazia frio em São Paulo.Fazia frio em São Paulo…
Nevava.
O medo, com sua capa,
nos dissimula e nos berça.Fiquei com medo de ti,
meu companheiro moreno,
De nós, de vós: e de tudo.
Estou com medo da honra.Assim nos criam burgueses,
Nosso caminho: traçado.
Por que morrer em conjunto?
E se todos nós vivêssemos?Vem, harmonia do medo,
vem, ó terror das estradas,
susto na noite, receio
de águas poluídas. Muletas
lentos poderes do láudano.
Até a canção medrosa
se parte, se transe e cala-se.
Faremos casas de medo,
duros tijolos de medo,
medrosos caules, repuxos,
ruas só de medo e calma.E com asas de prudência,
com resplendores covardes,
atingiremos o cimo
de nossa cauta subida.O medo, com sua física,
tanto produz: carcereiros,
edifícios, escritores,
este poema; outras vidas.Tenhamos o maior pavor,
Os mais velhos compreendem.
O medo cristalizou-os.
Estátuas sábias, adeus.Adeus: vamos para a frente,
recuando de olhos acesos.
Nossos filhos tão felizes…
Fiéis herdeiros do medo,eles povoam a cidade.
Depois da cidade, o mundo.
Depois do mundo, as estrelas,
dançando o baile do medo.
Un problema che riguarda tutti: la paura
Con La Paura, Carlos Drummond de Andrade non si limita a descrivere un’emozione privata, soggettiva, individuale. Mostra una radiografia dell’umanità. Il poeta brasiliano scrisse la poesia tra il 1943 e il 1945, in un Brasile segnato dalla dittatura di Getúlio Vargas e in un mondo devastato dalla Seconda guerra mondiale. L’angoscia era dunque tanto storica quanto esistenziale.
In questo scenario, il poeta brasiliano trasforma la paura in categoria universale. Non è un accidente della psiche, ma la sostanza che plasma i rapporti umani, la politica, le città, le generazioni future. La paura diventa origine e destino, forza invisibile che governa la società e che, proprio perché onnipresente, finisce per essere accettata come parte naturale della vita.
Il messaggio generale della poesia è chiaro e crudele. L’umanità costruisce le proprie case, le proprie istituzioni, persino i propri amori e la propria arte, sulle fondamenta della paura. È questo sentimento che addestra, ordina e paralizza. La grande intuizione di Drummond de Andrade è mostrarci che la paura non è solo ciò che subiamo, ma anche ciò che riproduciamo, generazione dopo generazione, fino a trasformarla in un destino collettivo.
Il messaggio universale di una poesia che dà voce alla fragilità umana
La poesia si apre con una dichiarazione netta, con una verità brutale. La paura non è un’emozione passeggera, ma la condizione originaria dell’uomo. “Nasciamo al buio” e già dall’inizio la vita appare segnata
dall’incertezza e dall’incompletezza. I ruoli sociali stessi, il postino, il dittatore, il soldato, appaiono come strade già tracciate, ridotte e prive di vera libertà.
Il poeta insiste poi su un punto decisivo. La paura non è solo istinto, è un’educazione. “Siamo stati educati alla paura”, impariamo a temere come si impara una lingua o un mestiere. Diventa parte del nostro modo di vivere e di percepire il mondo. Non a caso, Carlos Drummond de Andrade la rende materia concreta e sensoriale. Si può annusare nei fiori, indossare come un vestito, persino usare per attraversare fiumi rossi di sangue. È una presenza che si insinua ovunque, dalla natura alla storia.
E proprio la natura, che tradizionalmente è rifugio e consolazione, appare traditrice: porta malattie, carestie, disastri. Allo stesso tempo la società moderna, con le sue fabbriche, non dona sollievo, ma produce alienazione e oppressione. L’uomo resta schiacciato tra due forze che non offrono protezione.
Di fronte a questo, l’unico rifugio possibile sembra l’amore, “questo celebre sentimento”. Ma anche qui Drummond spiazza: l’amore non regge. La sua immagine di San Paolo fredda, piovosa e ventosa mostra come il sentimento non basti a contrastare la durezza della vita. L’amore, invece di salvare, si spegne, lasciando l’uomo solo di fronte alla paura.
La poesia assume poi una dimensione sociale e politica. Drummond de Andrade confessa di avere paura perfino del compagno “dalla pelle scura”, di sé stesso, degli altri, dell’onore. Qui si svela la paura dell’altro, del diverso, della convivenza stessa. È questo timore diffuso che trasforma gli uomini in borghesi prudenti, docili, incapaci di ribellarsi. Così la paura diventa strumento di controllo e conformismo, spegnendo ogni slancio vitale o rivoluzionario.
A questo punto il poeta compie una scelta ironica e disperata: invoca la paura come se fosse una divinità. “Vieni, armonia della paura”. Non potendola sconfiggere, tanto vale accoglierla come forza ordinatrice. È una resa sarcastica, ma al tempo stesso lucida. La paura diventa così la materia con cui si costruiscono le città e le civiltà. Case, strade, ornamenti, persino la calma apparente del vivere quotidiano sono eretti con “mattoni di paura”.
Il paradosso si fa ancora più evidente quando Drummond riconosce che la paura non è solo distruttiva, ma anche produttiva. Ha la sua “fisica”, produce carcerieri ed edifici, ma anche scrittori e poesia. Persino il testo che leggiamo è, in fondo, un figlio della paura. La civiltà intera, con le sue leggi, la sua cultura e i suoi simboli, poggia su questa forza invisibile.
Il finale della poesia è tra i più potenti e amari. I figli, definiti con amara ironia “così felici”, ereditano la paura dai padri. La città, il mondo e perfino le stelle si popolano di questa eredità velenosa, trasformando l’universo intero in un palcoscenico in cui si danza “il ballo della paura”. È l’immagine conclusiva, visionaria e apocalittica: la paura non riguarda solo l’individuo o la società, ma diventa principio cosmico, energia che muove l’intero universo.
Con La Paura, Drummond ci consegna un messaggio radicale. La paura è il vero cemento della storia, delle città, delle relazioni e delle generazioni. È la forza che ci educa, ci plasma e ci condiziona, al punto da diventare l’eredità più solida che lasciamo ai nostri figli. Leggere questa poesia oggi significa riconoscere come, in un mondo ancora attraversato da guerre, crisi e precarietà, il ballo della paura continui a scandire i nostri passi.
La paura come architettura invisibile del mondo
Nei versi di Carlos Drummond de Andrade, la paura non è soltanto un’emozione, ma la struttura nascosta della civiltà. È ciò che addestra e disciplina, che trasforma uomini in borghesi docili, che costruisce carceri, edifici, persino poesie. Una dinamica che la sociologia e la filosofia hanno descritto in profondità. Per Hobbes la paura della morte fonda il contratto sociale, per Foucault diventa biopolitica che modella corpi e comportamenti, per Heidegger è l’”Angst” (Angoscia) che rivela la fragilità dell’essere nel mondo.
E, più vicino a noi, Bauman parla di una “società della paura” in cui l’insicurezza non è eccezione, ma condizione permanente: i media, la politica, l’economia alimentano il timore come forma di governo e consumo, trasformandolo in carburante della contemporaneità.
Eppure Drummond de Andrade non si ferma alla diagnosi. In un passaggio cruciale domanda: “E se invece vivessimo?” È un varco minuscolo ma decisivo dentro una poesia che sembra murata nel pessimismo. La sua proposta non è la cancellazione della paura, impossibile e illusoria, ma il suo rovesciamento: riconoscerla, smascherarla, trasformarla in consapevolezza.
Sul piano individuale questo significa assumere la paura come dato originario dell’esistenza, ma senza permetterle di dettare le nostre scelte. Sul piano collettivo significa rompere il conformismo, costruire comunità e solidarietà che non si reggano solo sul timore, ma sulla responsabilità reciproca e sulla fiducia.
Il “ballo della paura” che chiude la poesia non è allora una condanna definitiva. Può diventare un’altra danza, non più una coreografia di timore ereditato, ma un movimento consapevole verso la vita. La domanda di Carlos Drummond de Andrade resta intatta e urgente: vogliamo continuare a trasmettere ai nostri figli solo l’eredità della paura, o possiamo offrire loro anche l’eredità del coraggio?
Siamo convinti che bisogna reagire, perché sembra di vivere in un mondo caotico e in preda alla follia. Solo i cittadini del Mondo possono cambiare le cose, attraverso un’unica parola magica: l’AMORE.