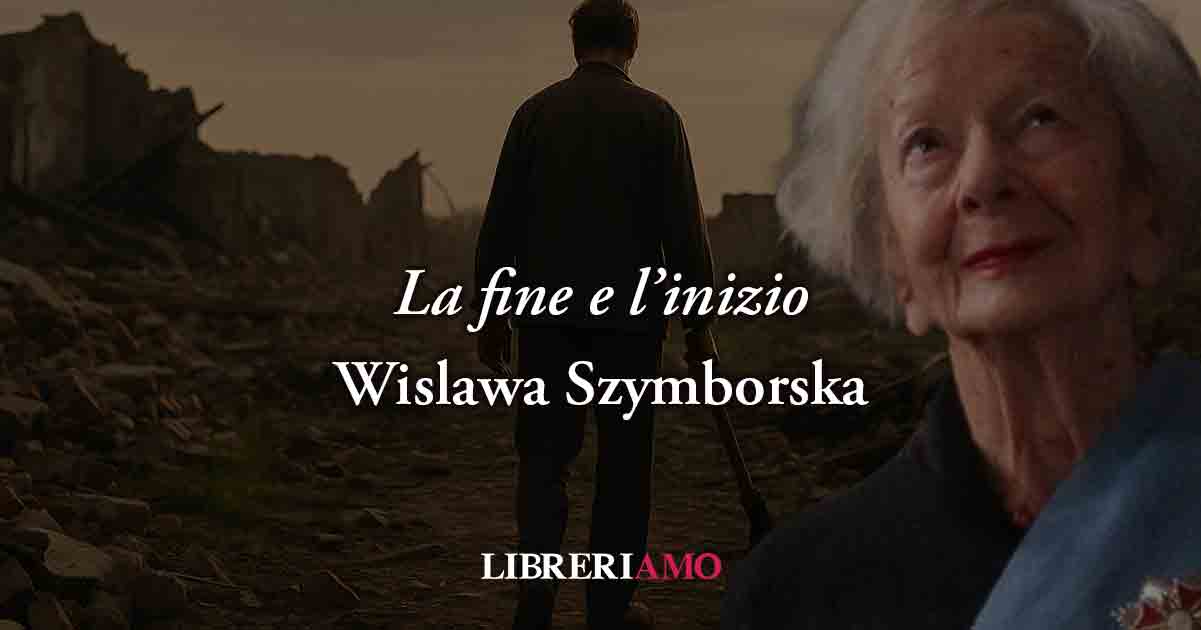La fine e l’inizio di Wislawa Szymborska esplicita ciò che ogni guerra, ogni repressione, ogni conflitto lascia dopo la sua forza distruttiva: soltanto il silenzio. Non quello solenne delle cerimonie, ma quello reale, pieno di polvere, in cui qualcuno deve ricominciare a vivere.
La Premio Nobel per la Letteratura del 1996, con la consueta lucidità ironica e compassionevole, racconta il dopo, il momento in cui l’eroismo cede il passo alla fatica quotidiana di ricostruire.
La poesia parla di ciò che non si vede: delle mani che rimettono insieme i muri, della memoria che svanisce, della natura che ricopre tutto, come se nulla fosse accaduto.
La poetessa polacca non cerca colpevoli né vincitori, ma restituisce dignità al gesto semplice di chi rimette ordine nel mondo, a chi continua nonostante tutto. È una lirica che parla della guerra, ma anche di ogni crisi, di ogni crollo personale o collettivo, perché dopo ogni distruzione, c’è sempre qualcuno che deve ripulire.
La fine e l’inizio fa parte dell’omonima raccolta di poesie di Wisława Szymborska, pubblicata in Italia per la prima volta da Libri Scheiwiller nel 1993. È uno dei testi più rappresentativi della sua poetica: una poesia che unisce sguardo storico e compassione umana, memoria e ironia, lucida consapevolezza e pietà.
Leggiamo questa meravigliosa poesia di Wislawa Szymborska per condividere il messaggio e approfondire il significato.
La fine e l’inizio di Wislawa Szymborska
Dopo ogni guerra
c’è chi deve ripulire.
In fondo un po’ d’ordine
da solo non si fa.C’è chi deve spingere le macerie
ai bordi delle strade
per far passare
i carri pieni di cadaveri.C’è chi deve sprofondare
nella melma e nella cenere,
tra le molle dei divani letto,
le schegge di vetro
e gli stracci insanguinati.C’è chi deve trascinare una trave
per puntellare il muro,
c’è chi deve mettere i vetri alla finestra
e montare la porta sui cardini.Non è fotogenico
e ci vogliono anni.
Tutte le telecamere sono già partite
per un’altra guerra.Bisogna ricostruire i ponti
e anche le stazioni.
Le maniche saranno a brandelli
a forza di rimboccarle.C’è chi con la scopa in mano
ricorda ancora com’era.
C’è chi ascolta
annuendo con la testa non mozzata.
Ma presto
gli gireranno intorno altri
che ne saranno annoiati.C’è chi talvolta
dissotterrerà da sotto un cespuglio
argomenti corrosi dalla ruggine
e li trasporterà sul mucchio dei rifiuti.Chi sapeva
di che si trattava,
deve far posto a quelli
che ne sanno poco.
E meno di poco.
E infine assolutamente nulla.Sull’erba che ha ricoperto
le cause e gli effetti,
c’è chi deve starsene disteso
con la spiga tra i denti,
perso a fissare le nuvole.
Koniec i początek, Wisława Szymborska (Testo originale)
Po każdej wojnie
ktoś musi posprzątać
Jaki taki porzadek
sam się przecież nie zrobi.Ktoś musi zepchnąć gruzy
na pobocza dróg,
żeby mogły przejechać
wozy pełne trupów.Ktoś musi grzęznąć
w szlamie i popiele,
sprężynach kanap,
drzazgach szkła
i krwawych szmatach.Ktoś musi przywlec belkę
do podparcia ściany,
ktoś oszklić okno
i osadzić drzwi na zawiasach.Fotogeniczne to nie jest
i wymaga lat.
Wszystkie kamery wyjechały już
na inną wojnę.Mosty trzeba z powrotem
i dworce na nowo.
W strzępach będą rękawy
od zakasywania.Ktoś z miotłą w rękach
wspomina jeszcze jak było.
Ktoś słucha
przytakuje nie urwaną głową.
Ale już w ich pobliżu
zaczną kręcić się tacy,
których to będzie nudzić.Ktoś czasem jeszcze
wykopie spod krzaka
przeżarte rdzą argumenty
i poprzenosi je na stos odpadków.Ci, co wiedzieli
o co tutaj szło,
muszą ustąpić miejsca tym,co wiedzą mało.
I mniej niz mało.
I wreszcie tyle co nic.W trawie, która porosła
przyczyny i skutki,
musi ktoś sobie leżeć
z kłosem w zębach
i gapić się na chmury.
“La fine è l’inizio” di un continuo conflitto
Ogni fine porta in sé un nuovo inizio, ma non sempre un inizio di pace. La storia, e in particolare quella vissuta da Wisława Szymborska, lo dimostra con dolorosa chiarezza. La guerra non termina davvero quando cessano le armi, ma quando l’uomo impara a non dimenticare. Eppure, la memoria è breve, e l’umanità sembra condannata a ripetere i propri errori, alternando distruzione e rinascita, oblio e speranza.
È in questo ciclo infinito che la poetessa polacca scrive La fine e l’inizio, voce lucida e compassionevole di chi sa che ogni ricostruzione porta in sé le tracce del conflitto appena concluso e l’ombra di quello che verrà.
La poesia così come la raccolta che ne porta il nome fu scritta dopo la vittoria di Solidarność, il sindacato fondato da Lech Wałęsa, che diventò il simbolo di libertà per tutto l’Est europeo. Le elezioni semilibere del 4 giugno 1989, frutto di un lungo dialogo tra potere e opposizione, segnano la fine di decenni di oppressione e l’inizio di un nuovo cammino democratico. Per la prima volta dopo quasi mezzo secolo, i cittadini polacchi possono scegliere, almeno in parte, chi li rappresenterà.
Ma l’evento passò tuttavia quasi inosservato all’estero. In quei medesimi giorni, gli occhi del mondo erano puntati su Pechino e sulla tragedia di Piazza Tienanmen, dove, nella notte tra il 3 e il 4 giugno 1989, la protesta pacifica di studenti e intellettuali veniva repressa nel sangue dall’esercito cinese. Migliaia di vittime, un numero mai chiarito, e una ferita ancora aperta nella coscienza globale.
Con lo sguardo dei media rivolto alla Cina, la rivoluzione pacifica polacca , quella che avrebbe portato, pochi mesi dopo, all’abbattimento del Muro di Berlino e alle transizioni democratiche in tutto l’Est, si consumò nel silenzio.
Eppure, mentre l’Europa dell’Est ritrovava la libertà, altra violenza si preparava altrove. Dopo il crollo dei regimi comunisti, le tensioni etniche e nazionaliste a lungo represse riesplosero nella dissoluzione della Jugoslavia. Tra il 1991 e il 1999, i Balcani furono travolti da una nuova ondata di guerre: la Slovenia, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo.
L’Europa che aveva appena festeggiato la caduta dei muri si ritrovò di fronte ad altre macerie, ad altri massacri, ad altre città assediate. Sarajevo divenne il nuovo simbolo dell’assurdità della guerra, una capitale europea ridotta alla fame e ai cecchini.
È in questo scenario di fine e di inizio insieme, di libertà riconquistate e di orrori che ritornano, che la poesia di Szymborska assume il suo significato più alto. La poetessa polacca non parla solo della guerra come evento, ma della storia come ciclo eterno di distruzione e ricostruzione, di oblio e di rinascita.
Ogni volta, dopo la violenza, qualcuno deve rimettere in ordine il mondo. Ogni volta, la vita riprende, ma la memoria si affievolisce. È questa la verità universale che La fine e l’inizio consegna al nostro tempo.
La poesia racconta chi ricostruisce il mondo dopo la distruzione
La fine e l’inizio è un poema di Wisława Szymborska sull’umanità silenziosa, quella che resta dopo il fragore e opera in silenzio per tornare alla vita. la poetessa dà voce non agli eroi né ai potenti, ma a chi rimbocca le maniche, spazza la polvere, ricuce il tessuto del mondo.
Nei suoi versi si riconoscono la dignità della fatica, la memoria che svanisce e la ciclicità delle guerre: un continuo ricominciare in cui la speranza e l’oblio si inseguono.
La poetessa osserva, senza giudicare, la normalità che ritorna sulle rovine, e mostra come ogni rinascita, collettiva o personale, nasce sempre da gesti minimi, concreti, e mai spettacolari.
La grammatica del “dopo”: lavoro, oblio, rinascita
Dopo ogni guerra
c’è chi deve ripulire.
In fondo un po’ d’ordine
da solo non si fa.
Così si apre la poesia, con un tono disarmante nella sua semplicità. Wisława Szymborska non parla di generali, di trattati o di eroi, ma di chi, nel silenzio, deve rimettere a posto il mondo.
Quel “c’è chi deve” si ripete come una formula antieroica, una preghiera laica che restituisce dignità a chi non appare nei libri di storia. È l’inizio della pace. Non quella proclamata dai governi, ma quella fatta di mani sporche, di fatica, di realismo.
L’immagine delle macerie “spinte ai bordi delle strade per far passare i carri pieni di cadaveri” è una delle più dure della poesia contemporanea. La morte e la vita si toccano nello stesso gesto, bisogna liberare la via, ma per farlo occorre convivere ancora con i resti del disastro. La poetessa non ci risparmia nulla, perché sa che la ricostruzione comincia sempre dentro una ferita profondissima.
Basta leggere i primi versi per immaginare negli occhi quelle scene che ormai arrivano sempre più spesso dalla cronaca, dove ancora la guerra vive e fa capire quando difficile sarà il nuovo inizio. Tutto è distrutto e da ricostruire.
C’è chi deve sprofondare
nella melma e nella cenere,
tra le molle dei divani letto,
le schegge di vetro
e gli stracci insanguinati.
L’elenco ha la precisione di un inventario domestico. È un paesaggio dell’intimità violata, dove gli oggetti di casa diventano testimoni del trauma. Il verbo “sprofondare” esplicita l’affondare nella memoria, toccare ciò che è rimasto sommerso.
Poi la poesia si solleva, ma solo di poco, tornando al gesto concreto.
C’è chi deve trascinare una trave
per puntellare il muro,
c’è chi deve mettere i vetri alla finestra
e montare la porta sui cardini.
In questi versi emergono i verbi del fare, azioni quotidiane e precise. Szymborska costruisce il dopoguerra come un lavoro artigianale, un atto di pazienza collettiva. Non c’è retorica, ma il riconoscimento del valore nascosto nel gesto ordinario.
Non e’ fotogenico
e ci vogliono anni.
Tutte le telecamere sono gia’ partite
per un’altra guerra.
In pochi versi la poetessa anticipa un tema oggi attualissimo, ovvero la disattenzione del mondo verso la ricostruzione. I riflettori amano le rovine, non la lentezza del risanamento. La Szymborska smaschera così la nostra fame di tragedie “spettacolari” e la nostra incapacità di guardare il lavoro invisibile di chi ricompone.
Allo stesso tempo sembra indicare la mancanza di consapevolezza che risanare dopo la distruzione richiede tempo, richiede energie e molte volte ciò che è stato non sarà mai più e finito per sempre e l’inizio sarà diverso.
Bisogna ricostruire i ponti
e anche le stazioni.
Le maniche saranno a brandelli
a forza di rimboccarle.
La pace è un mestiere che consuma. Le “maniche a brandelli” sono la metafora di una fatica morale, quella di chi si rimbocca sempre le stesse maniche, sapendo che forse domani dovrà ricominciare daccapo. I “ponti” e le “stazioni” sono simboli di connessione, ovvero la necessità di tornare a parlarsi, a muoversi, a sentirsi parte di qualcosa comune.
Poi, improvvisamente, la voce si fa malinconica:
C’è chi con la scopa in mano
ricorda ancora com’era.
C’è chi ascolta
annuendo con la testa non mozzata.
Ma presto
gli gireranno intorno altri
che ne saranno annoiati.
È una delle scene più umane del testo. Chi ha visto ricorda, chi non ha visto si annoia. In mezzo, la solitudine dei sopravvissuti, di chi cerca ancora di raccontare quando gli altri vogliono solo dimenticare.
La memoria, per Szymborska, è fragile come la polvere che si solleva da terra: se non la custodiamo, svanisce.
C’è chi talvolta
dissotterrerà da sotto un cespuglio
argomenti corrosi dalla ruggine
e li trasporterà sul mucchio dei rifiuti.
Qui la poesia si fa quasi profetica. Le “ragioni” delle guerre, i loro “argomenti”, finiscono tra i rifiuti della storia, diventano oggetti logori, inutili.
L’oblio è il prezzo della sopravvivenza, ma anche il suo pericolo più grande.
Chi sapeva
di che si trattava,
deve far posto a quelli
che ne sanno poco.
E meno di poco.
E infine assolutamente nulla.
La poesia scende gradualmente verso il silenzio. È la curva della memoria che si spegne: chi sa tace, chi resta non ricorda. E il ciclo ricomincia, perché la storia ripete ciò che non sa più nominare.
L’ultimo quadro è una delle chiusure più enigmatiche e struggenti.
Sull’erba che ha ricoperto
le cause e gli effetti,
c’è chi deve starsene disteso
con la spiga tra i denti,
perso a fissare le nuvole.
Tutto è tornato verde, ma quel verde è anche una coperta. L’erba cresce sopra la tragedia, non per cancellarla ma per nasconderla alla vista. Chi guarda le nuvole non è più in guerra, ma forse ha smesso anche di ricordare. È la quiete dopo il disastro, quella che consola ma inquieta: la pace che somiglia troppo all’oblio.
Il dovere di ricominciare, sapendo che non impariamo mai
La fine e l’inizio è una poesia di Wisława Szymborska che non smette di parlarci perché l’umanità non smette di ripetere se stessa. Ogni guerra, ogni conflitto, ogni crisi lascia dietro di sé lo stesso paesaggio: macerie, silenzi e mani che devono ricominciare. Eppure, a ogni fine sembra seguire solo un altro inizio, un nuovo capitolo del medesimo dramma.
La poetessa lo aveva intuito già nel 1993: la storia non progredisce, ma gira su sé stessa. Mentre l’Europa orientale cercava di rinascere dalle rovine del comunismo, già si preparava, a pochi chilometri di distanza, la tragedia dei Balcani — Sarajevo, Srebrenica, la pulizia etnica. Oggi lo stesso copione torna con altri nomi e geografie: Ucraina, Gaza, Sudan, Yemen e in tanti altre paesi che le telecamere e i reporter non riescono o non vogliono raccontare.
Le immagini cambiano, le vittime no. E come allora, mentre il mondo guarda, qualcuno, sempre anonimo, sempre invisibile, deve spingere via le macerie “per far passare i carri pieni di cadaveri”.
Viviamo in un tempo che registra in tempo reale ogni orrore, ma non lo elabora. C’è l’assuefazione dell’orrore, molte volte anticipato (questo è davvero non accettabile) da uno spot pubblicitario, che ha il ruolo di alzare l’attesa, lo spasimo per vedere la “morte”.
Wisława Szymborska avrebbe sorriso amaramente davanti alla saturazione digitale della sofferenza, a una guerra che si guarda in streaming e si dimentica con lo scroll successivo. “Non è fotogenico e ci vogliono anni”, scriveva. Oggi più che mai quella frase è un atto d’accusa contro un’epoca che confonde la visibilità con la memoria, la cronaca con la coscienza.
Ogni conflitto, ieri come oggi, produce il suo dopo: i sopravvissuti, i ricostruttori, i testimoni. Ma a differenza del passato, la velocità dell’oblio è diventata una forma di complicità. La memoria storica non ha più il tempo di sedimentare: tutto diventa notizia, e poi silenzio.
E così “chi sapeva di che si trattava” deve far posto a chi “ne sa poco, e infine assolutamente nulla”. È la più terribile profezia della Szymborska: il mondo ripete perché non ricorda, distrugge perché non comprende, ricostruisce senza aver mai davvero capito.
Eppure, in mezzo a questa lucidità disperata, la poetessa lascia uno spiraglio.
Quel corpo disteso sull’erba, “con la spiga tra i denti”, non è solo oblio. È anche l’ostinazione della vita che torna, della natura che rinasce, della speranza che resiste persino quando la ragione cede. Forse non impariamo mai, ma continuiamo a ricominciare. Forse non diventiamo migliori, ma sopravviviamo grazie a chi, in silenzio, si ostina a mettere i vetri alle finestre del mondo.
È questa la lezione di La fine e l’inizio Wislawa Szymborska. Ogni epoca ha i suoi detriti, e ogni generazione il suo compito di ripulire.
Il rischio è farlo senza memoria. Il dovere, invece, è ricominciare sapendo. Perché la pace, se mai arriverà, non sarà il contrario della guerra, ma la sua comprensione.