“Il prigioniero” di Gabriele D’Annunzio: il destino dell’uomo
Una riflessione potente sul destino, l’arte e la lotta eterna dell’uomo contro l’ignoto: “Il prigioniero” di Gabriele D’Annunzio dall'”Alcyone”.
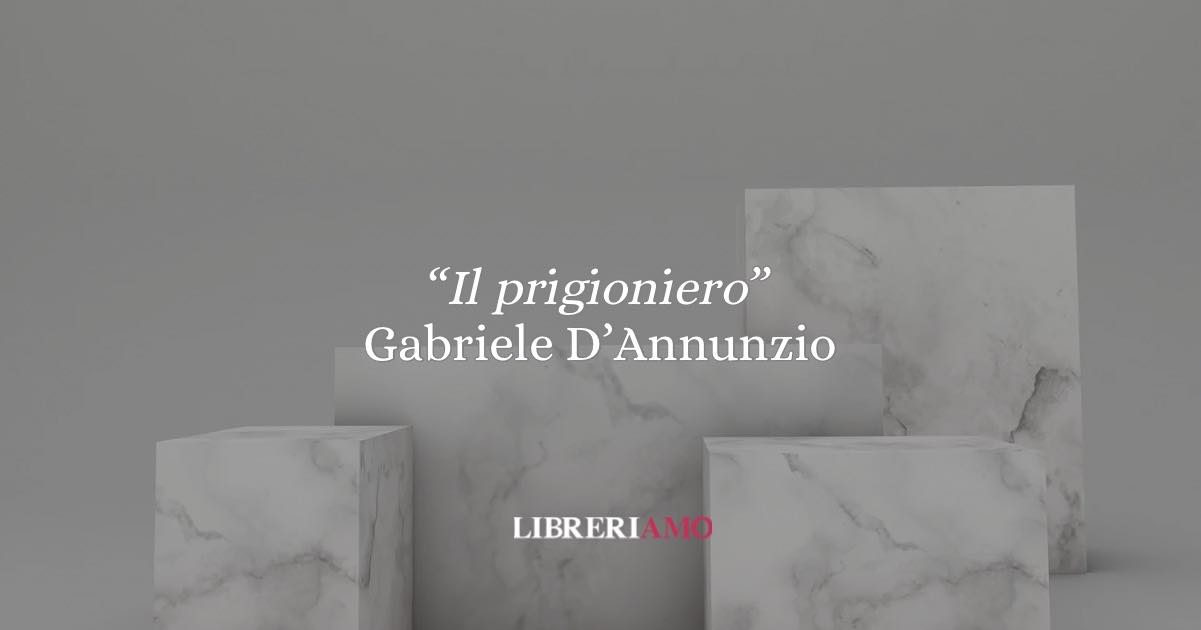
Nella poesia che vi presentiamo oggi, Gabriele D’Annunzio riflette sul mistero della vita, sull’ignoto che incombe e sulla lotta vana dell’uomo contro il fato, attraverso una scrittura sontuosa e visionaria.
“Il prigioniero” è un componimento breve che non mette in campo solo versi a tematica naturalistica — tipici del Vate — ma anche figure mitiche e storiche. Non canta solo la bellezza, come spesso avviene in “Alcyone”, ma affronta l’enigma della sofferenza e della limitatezza umana: un destino al quale non si può sfuggire.
“Il prigioniero” di Gabriele D’Annunzio
Ardi, sei triste come il prigioniero
ignudo che il titano Buonarroto
cavò da quel che or splende avìo e remoto
sacro, per il pontefice guerriero.Costretto anche tu sei dal tuo mistero,
vittima consacrata al Mare Ignoto;
e la bocca tua bella grida a vòto
contra il fato che tolseti l’impero.Tiranno fosti in Gela, trionfale
nell’ode pitia re? Traesti schiavi
da Tespe uomini e marmi alla tua Tebe?O sul cavallo bianco eri a Micale,
presso il padre di Pericle, e pugnavi
con l’altra gioventù nel nome d’Ebe?
Essere prigionieri
La figura del “prigioniero” diventa simbolo della condizione umana: ogni essere vivente è incatenato a un destino misterioso, contro cui combatte invano. L’ardore e la tristezza del protagonista riflettono la tensione tra la grandezza interiore e la consapevolezza della caducità.
Attraverso richiami alla scultura michelangiolesca (V. 2) e a episodi della storia greca (V. 11/13), D’Annunzio crea un ponte tra arte, mito e vita, mostrando come tutte le epoche abbiano conosciuto la stessa sconfitta contro l’ignoto.
L’ignoto e il non finito
Il linguaggio visionario di D’Annunzio si concentra su immagini di forza e di costrizione: il corpo scolpito da Michelangelo e rimasto incompiuto diventa emblema dell’uomo mai del tutto liberato dalla pietra della necessità. La “bocca che grida a vòto” (V. 7) è il grido dell’umanità intera, che chiede spiegazioni al destino senza riceverne.
L’ignoto, raffigurato come un mare sconfinato, divora ogni tentativo di ribellione. Ma c’è anche una sorta di esaltazione: l’uomo è “vittima consacrata” (V. 6), cioè partecipe di un mistero sacrale che lo lega al divino e lo rende eterno nella memoria.
Versi importanti
“Ardi, sei triste come il prigioniero / ignudo che il titano Buonarroto cavò”
Con questi versi, D’Annunzio evoca “i Prigioni di Michelangelo”: lavori incompiuti, appena abbozzati, che paiono lottare per liberarsi dalla pietra. L’uomo, come quelle sculture, è condannato a non raggiungere mai la libertà completa.
“La bocca tua bella grida a vòto / contra il fato”
La voce dell’uomo è destinata a rimanere inascoltata, segno dell’impotenza davanti al destino.
“Tiranno fosti in Gela…”
I richiami alla storia greca (Gela, Tebe, Pericle, Micale) ampliano la dimensione universale: non importa se si è stati potenti tiranni o valorosi guerrieri, il destino accomuna tutti.
Vita dell’autore
Il testo riflette bene la condizione esistenziale di D’Annunzio. Negli anni della stesura di “Alcyone” (1903), il poeta era ormai celebre e potente, ma avvertiva già il senso di precarietà e di sfida contro un fato più grande di lui.
Il tema della prigionia può essere letto come una proiezione del suo rapporto con la vita: da un lato la ricerca di gloria e di dominio, dall’altro la consapevolezza che tutto è effimero.
D’Annunzio stesso si vedeva come un “prigioniero del destino”, un titano che arde ma non riesce a liberarsi dall’ignoto.
La sua esistenza, segnata da amori tempestosi, ambizioni politiche e passioni estreme, riflette bene questa lotta tra volontà di potenza e destino ineluttabile.
L’accostamento a Michelangelo non è casuale: D’Annunzio aveva una profonda ammirazione per il Rinascimento italiano, che vedeva come epoca di genialità eroica. Nello stesso tempo, i riferimenti alla Grecia antica esprimono il suo desiderio di riportare in vita un mondo di bellezza e di eroismo.
Ma, come i prigionieri di Michelangelo, anche i grandi del passato restano “incompiuti”, incapaci di sfuggire alla prigionia del tempo.
“Il prigioniero” ci parla
L’idea di essere costretti dentro limiti che non possiamo superare risuona in un’epoca in cui, pur con la tecnologia e le conquiste della modernità, restiamo fragili davanti al mistero dell’esistenza.
Le “catene” di cui parla D’Annunzio sono oggi le nostre paure, le insicurezze, le ansie che non ci abbandonano e non riescono a lasciarci andare in un futuro più incerto del presente.
Ma il poeta ci lascia anche un’immagine di grandezza: essere prigionieri non significa rinunciare alla dignità, bensì assumere fino in fondo la condizione umana, trasformandola in canto e memoria.