“Dormiveglia” di Umberto Saba: la malinconia che diventa speranza
Scopri la poesia “Dormiveglia” di Umberto Saba: un viaggio intenso tra malinconia e speranza, dalla tentazione della morte al sorriso della vita.
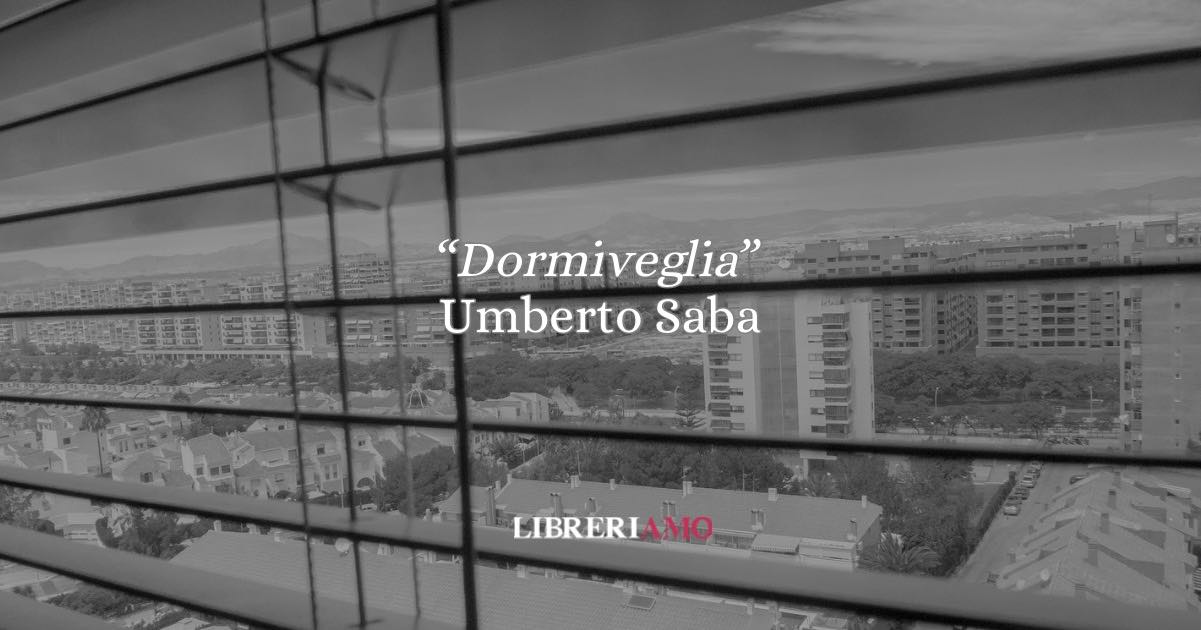
Scritta negli anni della piena maturità artistica di Umberto Saba, “Dormiveglia” è una poesia che parla al lettore con la stessa immediatezza con cui la luce del mattino filtra attraverso le veneziane in una stanza buia: una luce sempre presente, impossibile da bloccare, che il poeta rende parola e condensa nero su bianco in poche strofe; il passaggio esistenziale dall’ombra al sorriso, dalla tentazione della morte al ritorno della vita.
Il passaggio, una luce immediata
Tra le molte poesie di Umberto Saba, “Dormiveglia” occupa un posto particolare per il tono intimo e delicato con cui viene ritratto un momento sospeso tra sogno e veglia, fragilità e rinascita. Saba, poeta triestino nato nel 1883 e morto nel 1957, ha sempre coltivato una poesia limpida, capace di accogliere la vita nella sua interezza: gioie semplici e dolori profondi, malinconie quotidiane e improvvise epifanie di speranza.
“Dormiveglia” di Umberto Saba
Trillava un cardellino
nell’attonita stanza,
e il sole s’oscurava.
Un rullo, una campana,
il gallo a quando a quando
s’udivano; e il mattino
piú si andava velando.Io giacevo sognando,
e brevi erano l’ore.
Poi un altro sopore
prese l’anima mia,
una malinconia
che fu in breve dolore.Restai solo con esso.
Maledissi la sorte.
Desiderai la morte.
Ma venne la speranza
col suo chiaro sorriso,
e mi baciò sul viso,
e mi chiamò un eletto.Ricondusse al mio letto
il sonno che fuggiva.
La poesia si apre con il canto di un cardellino, un dettaglio simbolico e delicato che simboleggia proprio l’incertezza del mattino. La veglia è confusa, abitata da un senso di smarrimento. Segue il suo stato sospeso: “Io giacevo sognando, / e brevi erano l’ore”.
Il tempo scorre con rapidità, senza lasciare appigli. Il dormiveglia diventa allora un terreno fertile per l’insorgere della malinconia, che da sentimento lieve si trasforma presto in dolore. È un movimento tipico della sensibilità sabiana: il piccolo turbamento interiore che si fa universale, l’esperienza minima che diventa metafora della condizione umana.
Poi, la discesa interiore arriva nei versi: “Restai solo con esso. / Maledissi la sorte. / Desiderai la morte.”
Un passaggio improvviso e crudo, dove la malinconia si muta in vera e propria disperazione. Saba racconta con semplicità la verità del dolore, un momento di abbandono radicale che è il centro della poesia, e ricorda come l’autore abbia spesso vissuto periodi di depressione e senso di inadeguatezza.
Ma proprio quando il buio sembra definitivo, appare la speranza. Con un’immagine quasi fiabesca, Saba la descrive come una presenza femminile che lo bacia sul viso e lo chiama “un eletto”: è la grazia inattesa che giunge senza spiegazioni.
La speranza non elimina il male, ma lo ricompone in una visione più ampia, restituendo al poeta un senso di scelta e di valore.
L’ultima strofa chiude il cerchio: “Ricondusse al mio letto / il sonno che fuggiva”. Dopo il turbamento, l’anima trova una tregua. Non si tratta solo del ritorno al riposo fisico, ma di una quiete spirituale: la consapevolezza che la vita, pur nel dolore, custodisce sempre una possibilità di consolazione.
Chi era Umberto Saba?
Dormiveglia rientra in quella parte della produzione di Saba che si colloca tra gli anni ‘20 e ‘30, periodo di grande intensità creativa ma anche di fragilità psicologica. Il poeta viveva allora tra Trieste e periodi di cura in cliniche psichiatriche, segnato da crisi depressive che egli stesso racconta con schiettezza nella sua opera.
Nella poetica sabiana, il tema del dolore attraversa l’intera esistenza: già nella raccolta Il “Canzoniere” — di cui questa poesia fa parte —, che riunisce gran parte della sua produzione, la malinconia e la disperazione sono spesso bilanciate da improvvisi bagliori di speranza. È il suo modo di leggere la vita: non come trionfo di luce, ma come alternanza di cadute e risalite, di buio e di improvvisi sorrisi.
La biografia di Saba contribuisce a illuminare questi versi: il trauma infantile dell’abbandono del padre, l’inquietudine identitaria di una Trieste sospesa tra culture diverse, la continua ricerca di un equilibrio interiore. “Dormiveglia” è dunque lo specchio della sua vicenda personale: il passaggio dalla tentazione della morte alla grazia della speranza non è un artificio poetico, ma una verità vissuta.
L’ansia e la solitudine: la depressione, la malinconia di un tempo
Il cardellino, la stanza attonita, il sonno che ritorna: sono immagini di una quotidianità fragile, che ciascuno può riconoscere. La speranza non è un concetto astratto, ma una presenza che ci sorprende, un gesto che ci riconcilia con noi stessi.
La poesia ci ricorda che non bisogna vergognarsi del dolore, né nascondere la tentazione del nulla: fa parte dell’esperienza umana. E in un presente molto legato alla ricerca di una salute mentale Saba ci ricorda che anche dentro di noi esiste sempre la possibilità di un sorriso, di un ritorno alla vita.
Non moralizza né predica: semplicemente mostra il movimento della coscienza, e lascia al lettore la possibilità di riconoscersi in esso. Offre una piccola parabola poetica che racchiude l’essenza della sua visione: l’attenzione alle cose semplici, la sincerità nel raccontare il dolore, la fiducia in una speranza che, anche se fragile, non abbandona mai del tutto l’essere umano.