Emily Dickinson, 4 versi su “Il tramonto che scherma, svela”
Emily Dickinson scrive quattro versi e “svela” ciò che si nasconde dietro il tramonto: un paradosso. Un’idea semplice, ma che arriva anche oggi al cuore di chi legge. Il tramonto nasconde, “scherma”, ma al contempo mostra, “svela”, quei colori così belli che hanno un che di minaccioso. È qui che la poesia diventa un ossimoro…
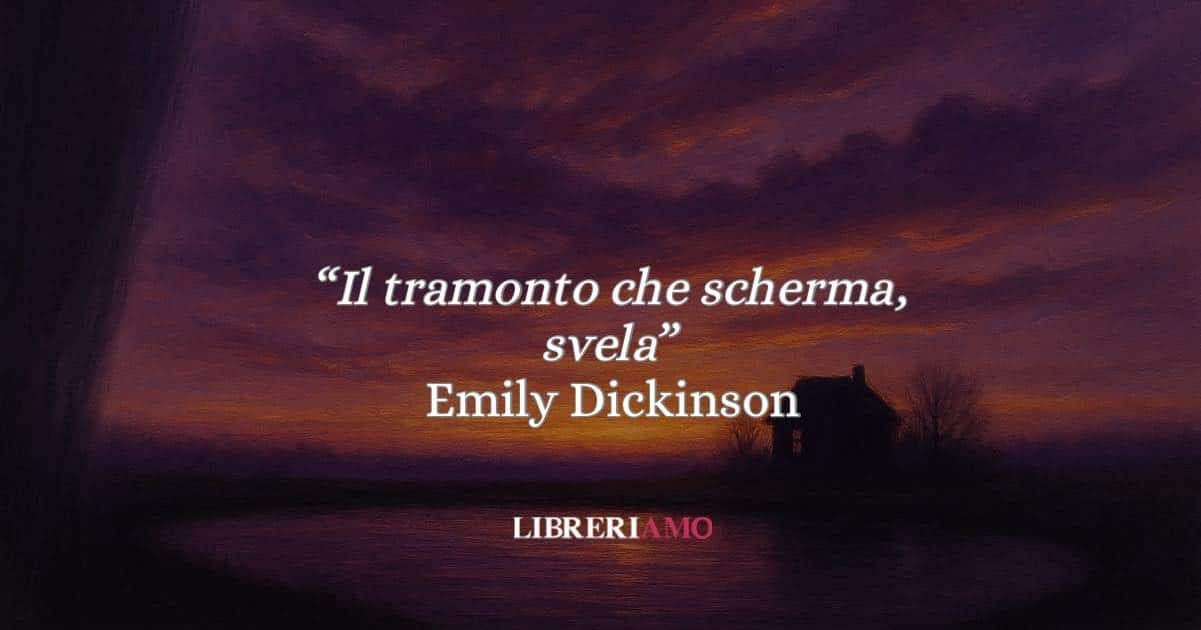
Emily Dickinson scrive quattro versi e “svela” ciò che si nasconde dietro il tramonto: un paradosso. Un’idea semplice, ma che arriva anche oggi al cuore di chi legge. Il tramonto nasconde, “scherma”, ma al contempo mostra, “svela”, quei colori così belli che hanno un che di minaccioso. È qui che la poesia diventa un ossimoro e, proprio attraverso il suo paradosso, ci insegna a guardare.
“Il tramonto che scherma, svela” di Emily Dickinson
(Italiano)
Il tramonto che scherma, svela –
esaltando ciò che vediamo
con minacce d’ametista
e fossati di mistero.(Inglese)
Sunset that screens, reveals –
Enhancing what we see
By menaces of Amethyst
And Moats of Mystery.
Che cosa dice davvero questa poesia?
Il tramonto di Dickinson non è un quadretto paesaggistico, non descrive come fa Carducci nella sua poetica per Lidia; non mette in fila dettagli naturalistici, non “dipinge” alla D’Annunzio. Piuttosto opera: cala — “scherma” — un velo a tinte rosso-viola sul mondo, attenua i contorni, e proprio così “svela”, perché mette in rilievo i contrasti e la profondità degli oggetti. È la lezione di ogni grande museo: la luce che rivela non è quella che abbaglia, ma quella filtrata, graduata. Dickinson dice: vedere bene non significa vedere tutto, ma vedere meglio.
Le “minacce d’ametista” (v. 3) sono il viola del crepuscolo: tinta ambigua, regale e penitenziale insieme. È una bellezza che inquieta e, come ogni colore mistico, promette rivelazione. Al tempo stesso ricorda che ogni verità porta con sé un bordo pericoloso, un superamento della comfort zone: può donare potere illimitato, spiegazioni e conoscenze eterne, ma anche terribili ritorsioni. “Améthystos” in greco significa “non ebbro”. È un viola che sobria lo sguardo, lo rende più lucido; minaccia l’illusione di possedere il reale in un colpo d’occhio e, proprio così, esalta ciò che vediamo.
Poi ci sono i “fossati di mistero” (v. 4), una struttura vera e propria che ricorda le protezioni attorno ai castelli medievali: senza fossato non c’è castello. Il mistero non è nebbia decorativa: è architettura del vero. Difende la fortezza della realtà dalla nostra fretta di conquistarla. Non si tratta di rinunciare a capire, ma di riconoscere che la conoscenza autentica ha sempre un perimetro: ci fa sostare su un bordo.
La vita di Emily
Emily Dickinson (Amherst, 1830–1886) vive quasi sempre nella casa di famiglia, in Massachusetts. Ebbe una formazione puritana, una vita trascorsa lontano dall’enfasi e dal clamore. Si può dire che fosse “apparentemente preclusa in casa”, ma in realtà quello era il suo stile di vita: una stanza al piano di sopra, un giardino curatissimo, un erbario, finestre che guardano il cielo d’ogni ora. La finestra è la sua soglia: non barriera, ma punto di osservazione. Lì studia le stagioni, le luci, i cambi d’aria; da lì impara che l’occhio si educa al poco, al vicino, al dettaglio.
La sua poesia resta in gran parte schermata anche socialmente. Pochi testi pubblicati in vita; la grande rivelazione avviene postuma, grazie alle sorelle e agli amici che ordinano i fascicoli trovati nella stanza. Anche qui la biografia ricalca la poetica: un lungo velare, poi l’improvviso svelamento.
Velo e svelo
La sua poetica del velo/rivelazione dialoga con altri testi: la luce “obliqua” che opprime come un inno (There’s a certain Slant of light), l’abitudine al buio che educa la pupilla (We grow accustomed to the Dark), l’imperativo etico-estetico di dire la verità di traverso (Tell all the truth but tell it slant). Questi quattro versi sono la versione naturale di quel manifesto: la verità si lascia vedere meglio quando non la si abbaglia.
Un discorso che parla anche di noi
Oggigiorno non facciamo che condividere. Condividiamo la colazione, il buongiorno, il caffè; il primo giorno di scuola dei figli, il pranzo col partner, la cena, la geolocalizzazione del mare. Profili saturi che Dickinson avrebbe probabilmente disdegnato: mostrare troppo significa non lasciare spazio all’immaginazione. La sua lezione è controintuitiva e salutare: imparare a “schermare” per “svelare”. Non per nascondere, ma per proteggere la profondità.
Il tramonto di Dickinson ci invita a un’economia dell’attenzione: rallentare, lasciare zone d’ombra, permettere al non detto di respirare. È un invito che riguarda l’arte, ma anche l’amore, la fede, la ricerca, la cura di sé. Una misura che si può praticare: meno esposizione compulsiva, più messa a fuoco; meno abbaglio, più contrasto.
Quattro versi, un’intera poetica
“Il tramonto che scherma, svela” è il modo in cui Emily Dickinson ci insegna a guardare — e a dire. La verità, per lei, arriva quando rinunciamo alla violenza dell’evidenza e accettiamo la pazienza dei filtri. Allora la realtà si esalta, l’ametista non fa più paura, e il fossato del mistero non separa: custodisce. In quella custodia, nella luce che non abbaglia ma rivela, c’è la possibilità più matura del nostro sguardo. Una poesia fatta di soli quattro versi, sì; ma anche un piccolo manuale di visione per il nostro tempo.