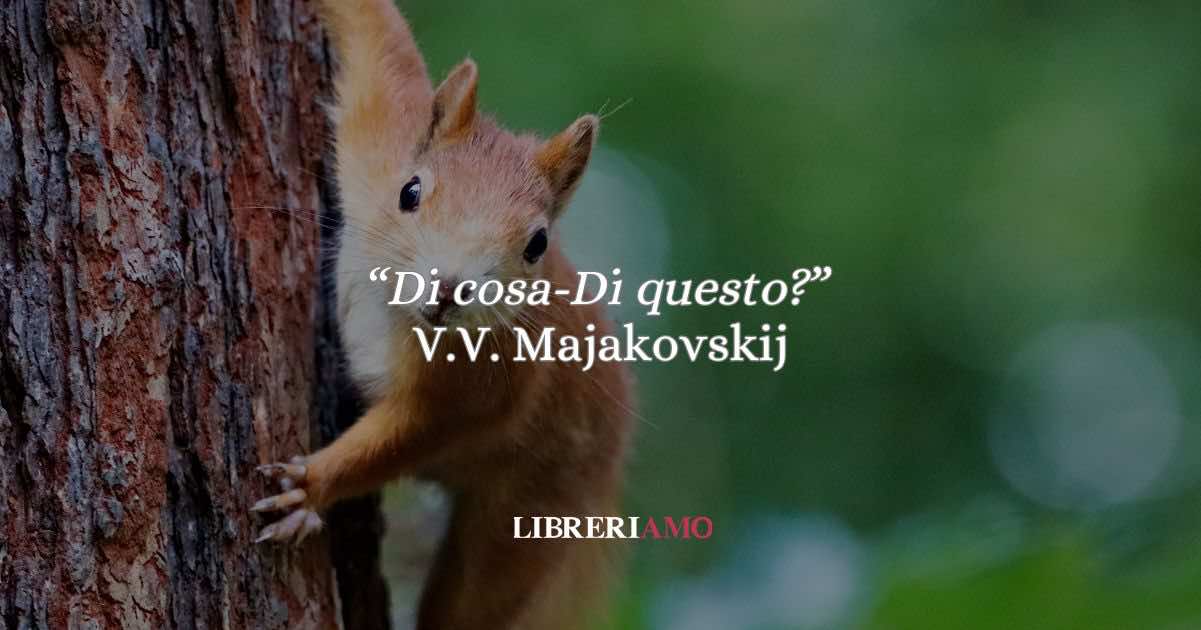Quando Vladimir Majakovskij scrive “Di cosa – Di questo?” si trova al culmine della sua parabola creativa e della sua lotta personale con il linguaggio. In questa poesia, apparentemente dedicata a un semplice “tema”, il poeta non descrive soltanto un argomento letterario, ma affronta la forza che plasma l’arte e la vita: la parola come ordigno, il pensiero come arma.
È un testo che mette in scena la battaglia tra ispirazione e realtà, dove il “tema” diventa una creatura capace di inseguire, schiacciare, ribaltare l’esistenza di chi scrive.
Vladimir Vladimirovič Majakovskij (1893-1930), nato a Bagdadi in Georgia, fu poeta, drammaturgo e pittore russo. Cresciuto tra l’attivismo politico e l’avanguardia artistica, aderì giovanissimo al partito bolscevico e venne arrestato più volte.
Espulso dall’Istituto di pittura di Mosca per le sue idee, si avvicinò al futurismo e ne divenne una delle voci più radicali. Con poemi come La nuvola in calzoni e Il flauto di vertebre fuse amore e rivoluzione, visione personale e impegno politico.
Accolse con entusiasmo la rivoluzione d’Ottobre, fondò il LEF (Fronte di sinistra delle arti) e collaborò con artisti come Rodčenko. La sua vita fu segnata da passioni estreme e delusioni profonde: l’amore, la politica e le critiche del regime contribuirono al suo suicidio nel 1930. Majakovskij resta simbolo di un’arte incendiaria, capace di sconvolgere i canoni e di parlare con voce profetica.
“Di Cosa – Di questo? “ di Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Dentro quel tema
intimo
e minuscolo,
cantato e ricantato
a piú non posso,
io – scoiattolo poetico – mi voltolo
e voglio voltolarmi ancora.Il tema
è una preghiera a Buddha,
ora – e lama che il negro affila contro i padroni.
Metti – Marte, sia pure un solo cuore d’oro,
lassú:
pure lui geme
su quello,
ora.Il tema arriverà,
per i gomiti
spintonerà lo storpio al foglio,
imporrà:
– Raspa! –Con un gridío
lo storpio
lascia il foglio, coi versi il canto abbaglia il sole.
Il tema arriverà,
suonando dalla cucina,
svoltando squaglierà,
Gigante,
tipo cappello di fungo.Starà un istante,
poi il crollo,
sepolto sotto foglietti spiegazzati.Il tema arriverà,
imponendo:
– Verità! –
Il tema arriverà,
ingiungendo:
– Beltà! –
Spappoli pure i palmi tuoi, la trave
– tu mugoli un valzer dalla croce.Il tema sfiorerà al volo l’abbecedario
(libro piú facile di quello non esiste!):
la A
diventerà
un Kazbek inarrivabile.
Appanna,
svia dal sonno, dal pane.
Il tema arriverà,
mai trito nei secoli,
dirà soltanto:
– D’ora in poi guarda me!
– E tu guardandolo vai,
sei un alfiere,di seta scarlatta segni la terra, di fuoco. È astuto, il tema!
Si inabissa sotto i fatti,
pronto a balzare negli anfratti degli istinti, e, come furibondo
(lo trascurano!),
sconquassa;
l’anima spicca dalla pelle.
Mi si fa innanzi iroso, il tema,
impone:– Voglio
le redini dei giorni! –
Guardato con disgusto il mio feriale,
uomini e oggetti sperde, è un fortunale.
Il tema arriva,
tutti gli altri eclissa.Solo,
si fa da presso incontrastato.
Mi accoltella alla gola, il tema.
Dal cuore alle fronti.
Martellatore! Il tema intenebra il giorno, e impone:
– Picchia coi versi delle tempie il tenebrore.
Il tema porta
come nome:
. . . . . . !
I versi più importanti della poesia
“Io – scoiattolo poetico – mi voltolo e voglio voltolarmi ancora”
Qui Majakovskij si autoritrae in modo ironico e crudele. Lo scoiattolo, piccolo e instancabile, corre nella ruota senza mai fermarsi: immagine perfetta del poeta costretto a inseguire sempre nuovi temi, senza riposo.
“Il tema arriverà, imponendo: – Verità! – Il tema arriverà, ingiungendo: – Beltà! –”
Il “tema” prende voce e diventa giudice: ordina cosa scrivere, come pensare, quali valori portare avanti. È il linguaggio stesso che si ribella, che pretende di guidare chi lo maneggia.
“La A diventerà un Kazbek inarrivabile”
Qui la lettera dell’alfabeto si trasforma in montagna: la lingua è un paesaggio titanico, non una sequenza di segni astratti. Majakovskij sottolinea la difficoltà e la grandezza del gesto poetico: anche la parola più semplice può diventare un vertice irraggiungibile.
“Mi accoltella alla gola, il tema”
L’immagine conclusiva è drammatica: la poesia non consola, ma ferisce. Scrivere significa accettare un duello costante con la parola, fino al sangue. È una metafora della stessa vita del poeta, vissuta come combattimento.
Da dove è tratta la poesia
“Di cosa – Di questo?” appartiene al poema Pro eto ( Di questo , 1923), una delle opere più intense e tormentate di Majakovskij. Non si tratta soltanto di un testo isolato, ma di un frammento di una più ampia confessione amorosa nata da una crisi profonda.
Durante le festività natalizie del 1922, infatti, Lili Brik impose al poeta una separazione di due mesi per tentare di arginare la gelosia e la routine che minacciavano la loro relazione.
Alla fine di quella pausa forzata, i due si riunirono a Pietrogrado, e sul treno Majakovskij le recitò il poema: «quando ebbe finito la lettura ne fu cosí sollevato che scoppiò in lacrime».
Come osserva Paola Ferretti, Di questo rappresenta il bottino inestimabile di quella reclusione natalizia: un capolavoro burrascoso e apocalittico, in cui la “sofferenza immedicabile” di un amore non del tutto ricambiato si sublima in speranza proiettata nel futuro.
Per il poeta, “reietto di ogni adesso”, la felicità non può esistere nell’immediato, ma solo nel “XXX secolo”, in una dimensione oltre la corporeità e oltre il tempo.
Così, il tema personale si intreccia con l’idea di un amore assoluto e cosmico, capace di sopravvivere al dolore e di trasfigurarsi in eterno ritorno.
L’essenza della vita e della poetica di Majakovskij
Molti elementi di “Di cosa – Di questo?” rispecchiano le tensioni biografiche di Majakovskij e si intrecciano con la sua concezione estrema della poesia.
La sua attività frenetica di scrittore e propagandista, sempre alla ricerca di un linguaggio nuovo, lo rende lo “scoiattolo poetico” che non smette di correre, simbolo di una creatività incessante ma anche logorante.
Le pressioni politiche e artistiche a cui fu sottoposto emergono nel “tema” che comanda, che impone verità e bellezza dall’alto, proprio come il partito e la società sovietica pretendevano dal poeta ufficiale.
E la conclusione violenta (“mi accoltella alla gola”) richiama la sua fine tragica, mostrando come la poesia non fosse per lui un rifugio ma un campo di battaglia. In questo senso, il testo diventa un autoritratto drammatico: nei suoi versi il “tema” si fa forza assoluta, più potente dell’uomo, capace di schiacciare e trascinare, rivelando insieme la grandezza e la fragilità del poeta, la sua incapacità di separare vita e arte, l’urgenza di trasformare ogni esperienza in parola e l’impossibilità di salvarsi da un destino creativo divorante.