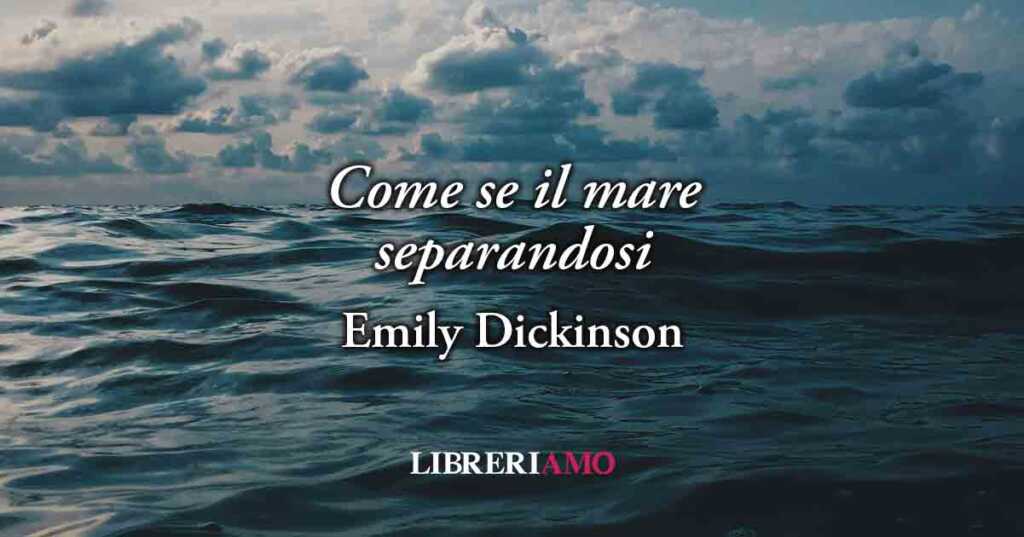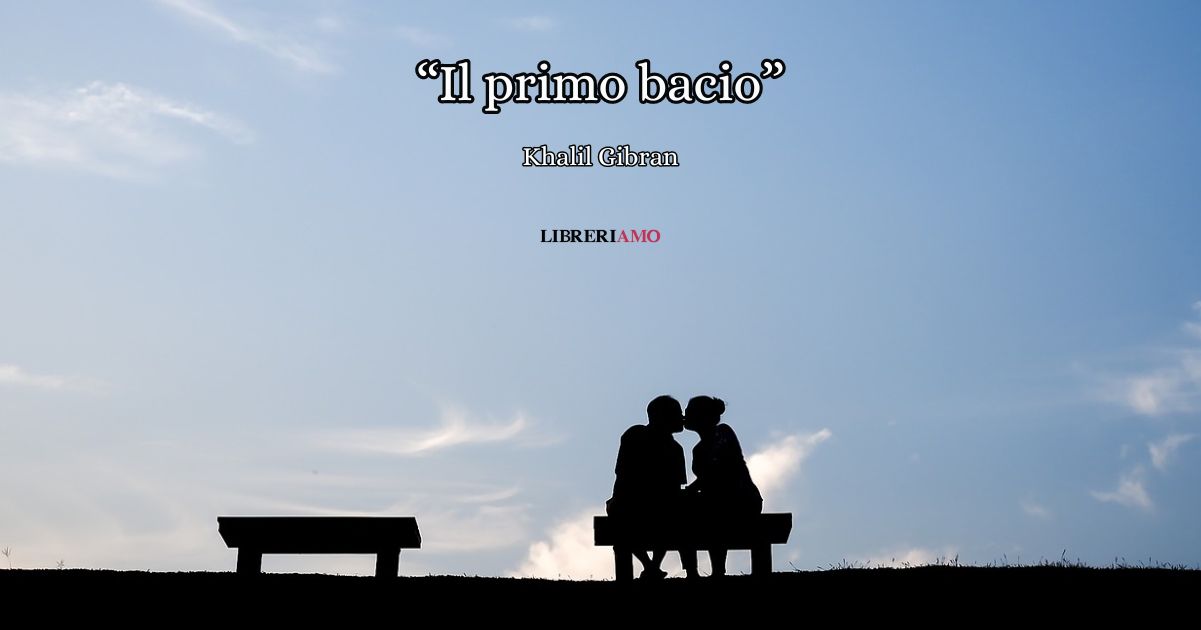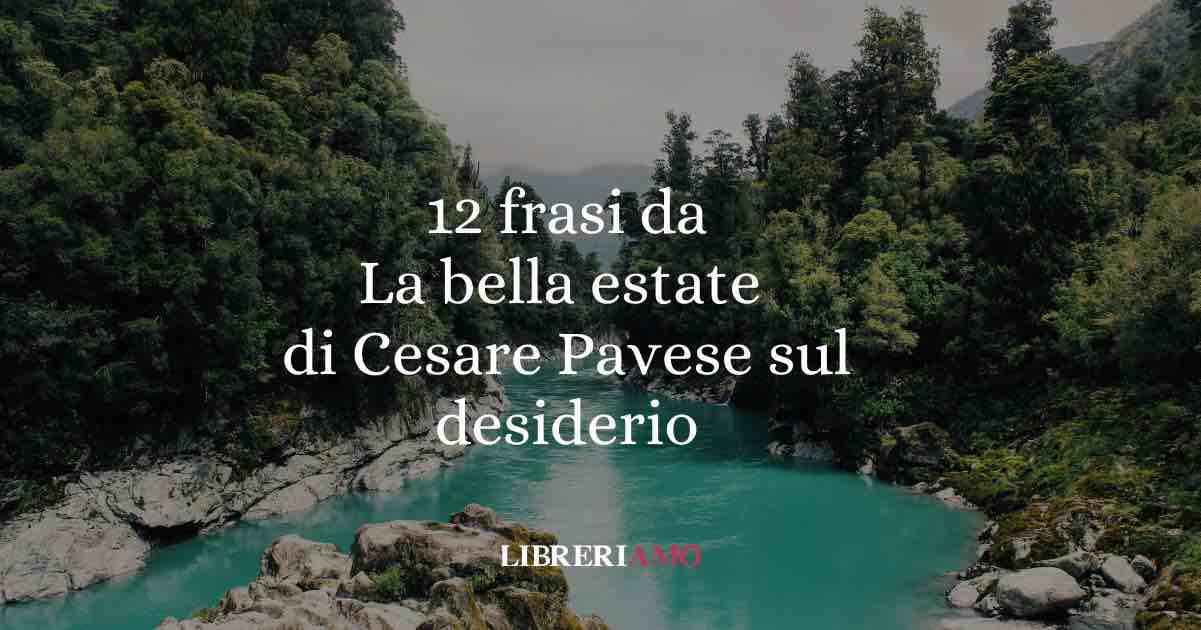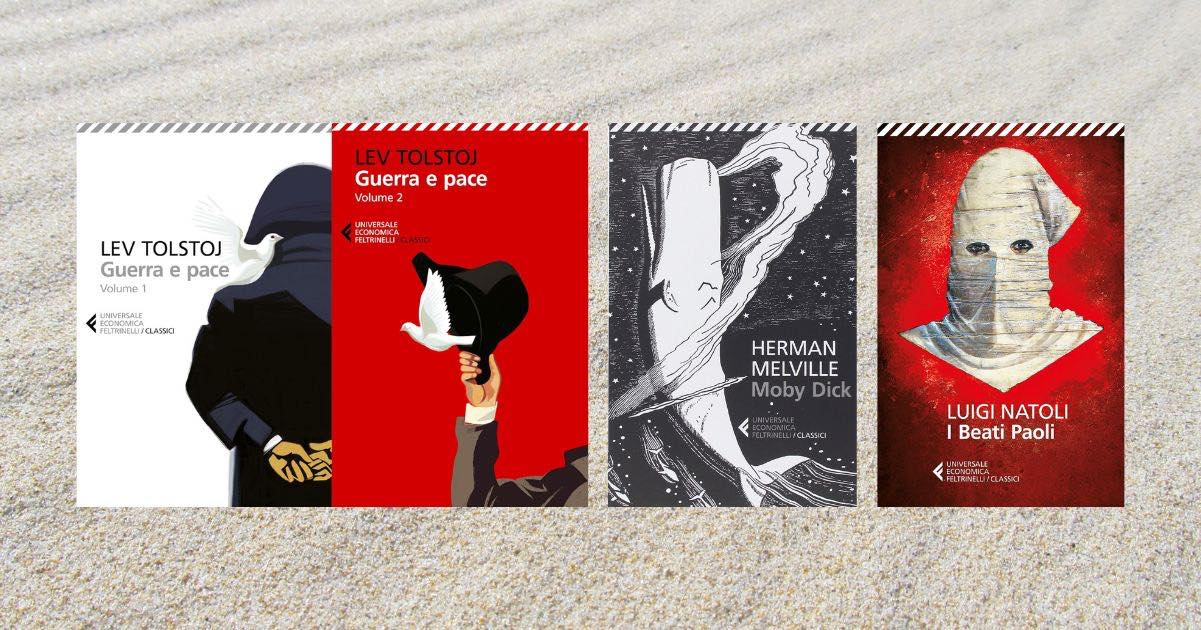Come se il mare separandosi di Emily Dickinson è una poesia che mette in scena i limiti della comprensione umana di fronte al senso dell’esistenza che è infinito. Si cerca in tutti i modi, oggi più che mai, di comprendere tutto ciò che circonda, dimenticando che non può esserci sempre una spiegazione a tutto. Anche le macchine più intelligenti, quelle guidate dalla meccanica quantistica, avranno sempre un limite rispetto all’universo in cui si è immersi.
Bisogna saper accettare che esiste sempre un limite, la sete di voler trovare una spiegazione da ogni cosa non va placata, ma nella consapevolezza che si potrà scoprire sempre qualcosa di nuovo. Oggi sembra invece che i giudizi, i pensieri, le conversazioni, i commenti delle persone siano caratterizzati da certezze. Il principio di verità sembra essersi impossessato dell’umanità e quando si è convinti di agire in nome della verità si finisce inevitabilmente per trascurare la grande saggezza del dubbio.
As if the Sea should part, questo il titolo originale della poesia, fu scritta nel 1863 ed è il Frammento 720 della raccolta di poesie The Poems of Emily Dickinson, curata da Thomas Herbert Johnson e pubblicata nel 1955. la poesia all’interno della raccolta Tutte le poesie di Emily Dickinson, della collana I Meridiani della casa editrice Mondadori.
Leggiamo questa breve ma intensa poesia di Emily Dickinson per comprenderne il significato e coglierne la contemporaneità.
Come se il mare separandosi di Emily Dickinson
Come se il mare separandosi
svelasse un altro mare,
questo un altro, e i tre
solo un presagio fosserod’un infinito di mari
non visitati da rive
il mare stesso al mare fosse riva
questo è l’Eternità.
As if the Sea should part, Emily Dickinson
As if the Sea should part
And show a further Sea −
And that – a further – and the Three
But a Presumption be –Of Periods of Seas
Unvisited of Shores
Themselves the Verge of Seas to be
Eternity is Those
Dickinson e l’eternità: la bellezza dell’incompletezza e del dubbio
Come se il mare separandosi è una poesia di Emily Dickinson che svela un’immagine vertiginosa: onde che si aprono su altri mari, e questi su altri ancora, in un moto senza fine. È una visione poetica dell’infinito che non possiamo afferrare del tutto, e che ci ricorda i limiti strutturali della nostra comprensione umana.
I versi dell’autrice si presentano come un’onda di rivelazioni che non termina mai, e che porta a intuire un infinito di mari, non segnati da rive, non contenuti da confini.
La poesia, come spesso accade in Dickinson, è un enigma illuminato: parla dell’Eternità, ma non come luogo ultraterreno, bensì come condizione, esperienza del pensiero, vertigine dell’anima. L’eternità è un infinito che si mostra per frammenti, mai per intero.
L’illusione delle certezze e la convinzione di essere verità
Oggi più che mai, viviamo nell’illusione di poter spiegare ogni cosa. La scienza avanza, l’intelligenza artificiale impara, la meccanica quantistica ridefinisce le leggi della realtà. Eppure, per quanto possiamo penetrare il mistero, ci sarà sempre un orizzonte che ci sfugge, un “altro mare” che si apre, proprio come nei versi di Dickinson. Nessuna macchina, per quanto sofisticata, potrà mai superare il paradosso di essere interna all’universo che cerca di comprendere.
La raccolta incessante di dati danno l’illusione che tutto possa essere spiegato. Eppure, come la poesia ci suggerisce, l’universo è composto di livelli che si dischiudono uno dopo l’altro, senza fine. Nemmeno la macchina più intelligente potrà mai superare il fatto di essere dentro ciò che osserva. C’è un punto in cui la conoscenza si arresta: non per mancanza di strumenti, ma per natura delle cose.
E proprio qui entra in gioco la poesia, la filosofia, la spiritualità: quegli strumenti dell’anima che non servono a “sapere” tutto, ma a intuire ciò che non si può dire.
Nella società contemporanea, il paradosso è evidente: mentre il mondo si fa sempre più complesso e sfaccettato, le persone sembrano volere risposte semplici e definitive. Il dibattito pubblico, i social network, le conversazioni quotidiane sono sempre più dominati da certezze urlate, opinioni rigide, convinzioni assolute.
Il principio di verità, che dovrebbe essere una ricerca, è diventato spesso una bandiera ideologica, uno strumento di giudizio, a volte di esclusione. Ma come ci insegna la grande poesia, non è nel possesso della verità che si trova la libertà, bensì nella sua esplorazione.
La saggezza del dubbio
Accettare che esista sempre un limite non significa arrendersi, ma abbracciare la condizione umana nella sua forma più autentica. Il dubbio non è debolezza: è apertura, curiosità, intelligenza profonda. È ciò che ci spinge a cercare, a scoprire, a restare in ascolto del mondo.
Emily Dickinson ci invita, con le sue parole limpide e misteriose, a non perdere la meraviglia di fronte all’inconoscibile. A sostare in silenzio davanti a quell’onda che si apre, e poi un’altra ancora, e un’altra. A capire che non tutto ha una spiegazione, ma tutto può essere compreso poeticamente.
Non è un invito all’arrendevolezza, ma alla consapevolezza. Il desiderio di sapere, di esplorare, di interpretare il mondo è un atto sublime e necessario. Ma questa sete dovrebbe essere accompagnata da un rispetto profondo per ciò che non si può spiegare del tutto. Il mistero non è un fallimento della conoscenza, ma il suo respiro.
E invece oggi si assiste a una sorta di idolatria della certezza. Tutti sembrano sapere tutto, avere opinioni granitiche su ogni questione, risposte pronte, giudizi veloci. Il principio di verità, usato come bandiera, rischia di diventare una gabbia. E quando si è convinti di possedere la verità, si finisce per perdere la saggezza del dubbio, quella preziosa condizione in cui la mente rimane aperta, e l’anima in ascolto.
Emily Dickinson con questi versi ci invita a contemplare ciò che non si afferra. L’eternità non è sempre da capire, è da intuire. E forse, proprio lì, nel riconoscere i limiti, nel sostare davanti all’ignoto, troviamo la nostra forma più alta di intelligenza.
Emily Dickinson in questa poesia, breve ma chiara, vuole provare a rendere concreto il concetto di eternità. Per fare ciò prende come esempio il mare e lo suddivide, un infinito che si scompone in altri infiniti e regala un senso di libertà e immensità che in natura non si riuscirebbe a trovare se non nella grandezza del mare.
La poetessa americana ci spiega come sia possibile che il mare sia infinito ed eterno, ci dice, infatti, che questo non ha rive, che il suo limite è sé stesso. È un componimento, questo, con una forte anima filosofica. L’intenzione dell’autrice di voler dimostrare l’eternità, concetto temporale, con il mare, concetto spaziale rende la poesia incredibilmente sofisticata, nonostante il lessico semplice.