Cesare Pavese, “tango —”: la poesia segreta del desiderio
In “tango —” Cesare Pavese racconta il desiderio e l’impossibilità di abbandonarsi: una poesia giovanile che svela già il suo destino interiore.
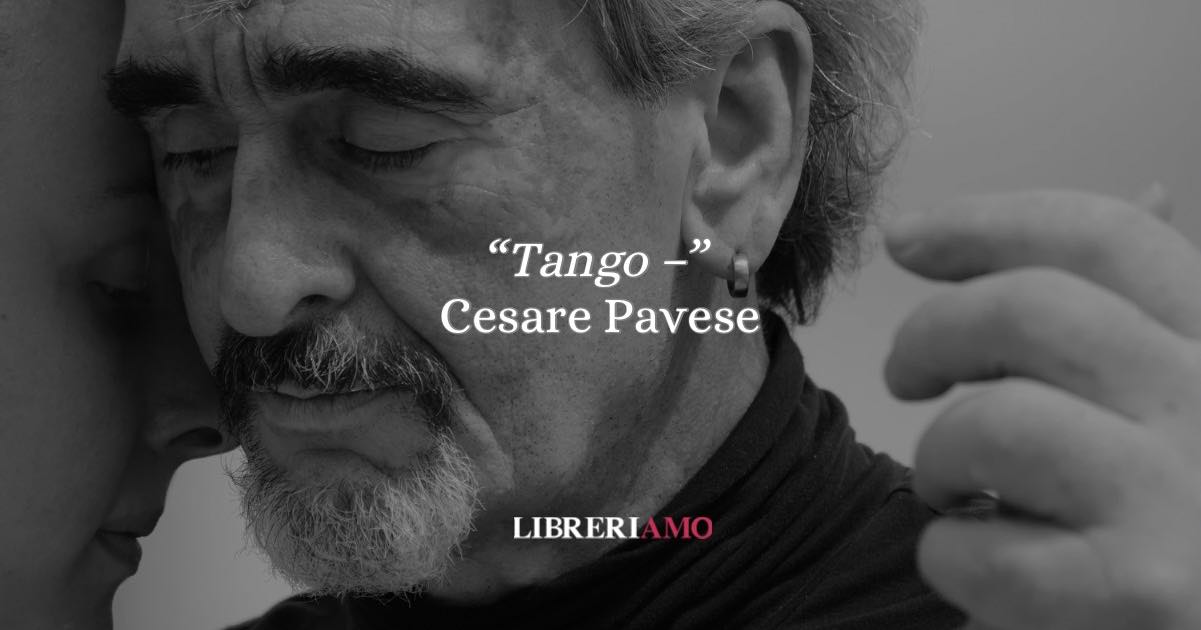
Un giovane Cesare Pavese intitola questa poesia “Tango —” tra il 23-26 giugno 1928. È ancora uno studente, probabilmente frequenta le sale da ballo, ed è attraverso quest’immagine che mitizza una danza priva di festa, un’immagine in sul la ragazza protagonista della scena può solo “fare male all’anima” (V. 44).
Tra le righe parla di un incontro di corpi, una sala chiusa, una “luce livida” (V. 46); e i corpi, “sollevati e schiantati dalla musica” (V. 4), come “ombre” (V. 15).
È una trance collettiva: in mezzo, il poeta che guarda e non può “abbandonarsi” (V. 50). Pur trovandoci a far fronte a una raccolta come “Il desiderio mi brucia” composta tra il 1927 e il 1928, prima di “Lavorare stanca”, troviamo già la sua firma: Pavese mette in scena un “io spettatore”, incapace di coincidere col presente e condannato a viverlo come visione cinematografica.
“Tango —” di Cesare Pavese
Mi son visto una notte
in una sala chiusa
a l’abbraccio dei corpi che danzavano,
sollevati e schiantati dalla musica,
sotto la luce livida
che filtrava nei muri, di lontano,
mi soffocava il cuore
come in fondo a un abisso, sotto il buio,
tra bagliore e bagliore,
giungono spaventose
scosse di una tempesta,
che impazzisce là in alto, sopra il mare.Mi giungevano a tratti,
pallide e stanche,
le ombre dei danzatori,
vibrazioni di un mare moribondo.
E vedevi i colori,
delle donne abbraccianti
illividirsi anch’essi,
e tutto rilassarsi
di spossatezza oscena,
e i corpi ripiegarsi,
strisciando sulla musica.Solo ancora splendeva
su quella febbre stanca
il corpo di colei
che fiorisce in un volto
tanto giovane e chiaro
da fare male all’anima.
Ma era solo il ricordo.
Io la guardavo immobile
e la vedevo, dolorosamente,
nella luce del sogno.
Ma passava strisciando,
senza scatti più, languida,
con un respiro lento
e mi pareva un gemito d’amore,
ma l’uomo a cui s’abbandonava nuda
forse non la sentiva.
E un’ubbriachezza pallida
le pesava sul volto, sul volto
giovane e stupendo
da fare male all’anima.Tutti tutti tacevano di abbrezza,
travolti dentro il gorgo
di quella luce livida,
posseduti di musica,
nelle carezze ritmiche di carne,
e stanchi tanto stanchi.
Io solo non potevo abbandonarmi:
cogli arsi occhi sbarrati,
mi fissavo smarrito
su quel corpo strisciante.(23-26 giugno 1928)
Pavese costruisce un quadro allucinato della modernità: una sala da ballo come una camera di mare in burrasca. La musica che sovrasta i colori, i corpi, e filtra attraverso i muri, dove i presenti non sono altro che “vibrazioni di un mare moribondo” (V. 16).
In mezzo al gorgo, l’io lirico non partecipa: “Io solo non potevo abbandonarmi” (V. 50). È il gesto più pavesiano che ci sia: scegliere lo sguardo invece del gesto, la distanza invece dell’adesione. Ma in questa distanza vibra un desiderio assoluto, che ha il volto di una ragazza “tanto giovane e chiaro / da fare male all’anima” (V. 27/28). Ne rimane ammaliato, affascinato: il corpo bello, nudo, che brilla nella luce del giorno. Ma l’immagine appartiene al ricordo e al sogno, non al presente, ed è questo che l’allontana, è questo che rende impossibile la coincidenza di queste due realtà.
Passaggi chiave
“Mi son visto una notte / in una sala chiusa”
Quando Pavese dice “mi son visto” si apre a un’identità doppia: si vede mentre vive. Il reale è già cinema interiore.
“sollevati e schiantati dalla musica”
La musica è forza cieca, quasi fisica. Solleva e abbatte: una perfetta metafora del desiderio che trascina e consuma.
“sotto la luce livida / che filtrava nei muri”
La luce non illumina, sbianca: è livida. Filtra dai muri come un contagio.
“tra bagliore e bagliore, / giungono spaventose / scosse di una tempesta… sopra il mare”
L’immagine marittima è un classico pavesiano: l’elemento naturale come controcampo mitico della città. La sala diventa abisso, la musica tempesta: un paesaggio dell’anima.
Pavese, vita e ossessioni che entrano nei versi
Nel 1928 Pavese ha poco più di vent’anni. Torino è il suo teatro: biblioteche, cinema, colline e, sì, anche sale da ballo. È un giovane che legge moltissimo, studia letteratura angloamericana, prende appunti, impara a guardare. Molte poesie del periodo mettono in scena corpi e città come se fossero inquadrature: il movimento collettivo è sempre filmato dalla distanza di chi non riesce a farne parte.
Accanto al tema della estraniazione, affiorano i tratti dell’Eros pavesiano: idealizzato, schivo, spesso legato a visioni femminili che si accendono e subito sfumano nel rimpianto. Quel “volto tanto giovane e chiaro” (V. 27/28) non è una persona identificabile: è un archetipo (la ragazza-salvezza) che ritornerà ovunque nella sua opera, fino ai romanzi e ai diari.
“Tango —” anticipa così molte costanti future: la sproporzione tra desiderio e realtà, la metafora marina come misura emotiva, il male di vivere che si sovrappone all’incanto dei sensi. Anche lo stile è già suo: verso lungo, fraseggio prosastico, montaggio di immagini che avanzano per accostamenti più che per commento.
Nota biografica
Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe e cresciuto a Torino, è stato poeta, narratore, traduttore e diarista. Ha portato nella letteratura italiana l’aria dell’America, del cinema, dei miti quotidiani. Gli anni giovanili furono segnati da timidezza, grandi letture e un’educazione sentimentale spezzata tra sogno e paura.
Dopo “Lavorare stanca” (1936) e i romanzi maturi, la sua voce si è fatta sempre più nuda, fino agli ultimi racconti e al diario “Il mestiere di vivere”. Il 27 agosto 1950 si tolse la vita in un albergo torinese.
Leggere “tango —” sapendo tutto questo non toglie nulla al suo incanto oscuro: anzi, ci fa intuire come in queste pagine del 1928 sia già palpabile la postura esistenziale che accompagnerà Pavese per sempre — guardare, desiderare, non riuscire a coincidere. È la sua fragilità, ma anche la fonte della sua arte.