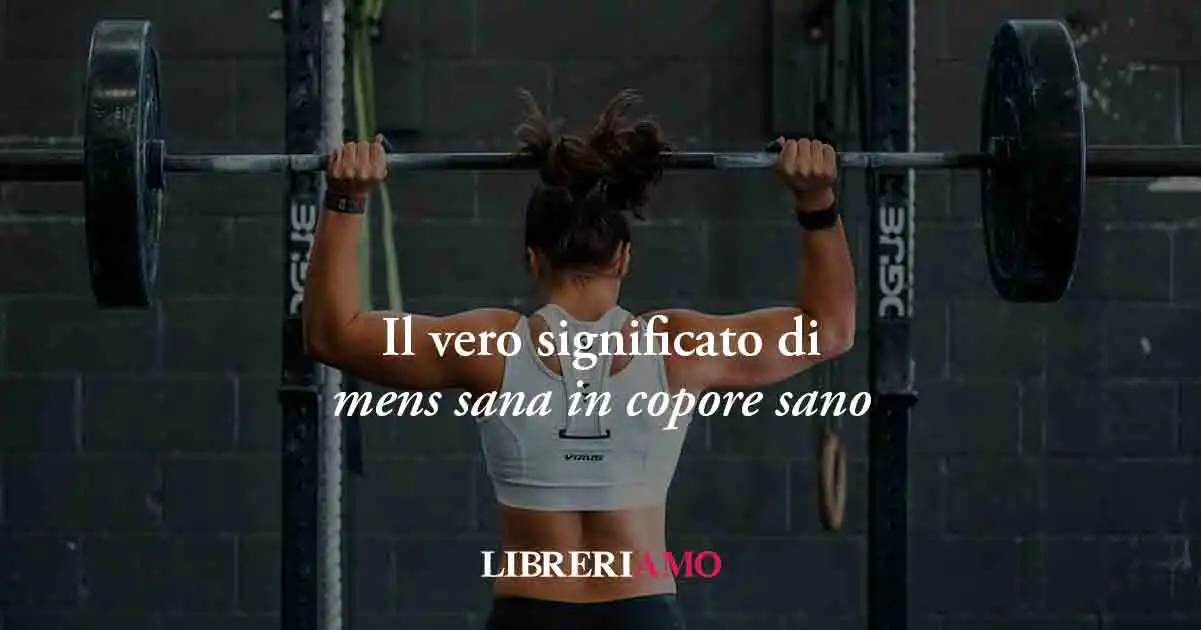Mens sana in corpore sano. Basta varcare la soglia di un qualsiasi centro fitness moderno, tra il rumore ritmico dei tapis roulant e l’odore acre dello sforzo fisico, per imbattersi quasi certamente in questa massima, la più celebre e fraintesa della storia.
La si ritrova stampata sulle pareti, sulle magliette tecniche, citata nei piani di allenamento. Nel corso dei secoli, e in particolare nell’era del wellness, questa frase è stata elevata a dogma, quasi fosse una formula matematica infallibile: se si scolpisce il corpo, la mente ne trarrà giovamento. È diventata la promessa implicita che la prestazione fisica, l’estetica e la salute muscolare siano la via maestra per ottenere lucidità ed efficienza intellettuale. Addirittura, è diventata l’acronimo di uno dei marchi sportivi più famosi al mondo.
Tuttavia, questa interpretazione si basa su un equivoco secolare. Decimo Giunio Giovenale, l’autore di quel verso, non intendeva affatto celebrare lo sport, né tantomeno suggerire una relazione di causa-effetto tra bicipiti e neuroni. Al contrario, se il poeta satirico potesse osservare l’uso odierno delle sue parole, probabilmente ne riderebbe amaramente. Di fatto, si è trasformato quella che era una disperata preghiera sulla fragilità umana in uno slogan motivazionale, formativo e pubblicitario.
Giovenale e la massima Mens sana in corpore sano
Per restituire a quel verso la sua dignità originale bisogna immergersi nel contesto da cui proviene: la Satira X.
Si tratta di un testo cupo, a tratti brutale, in cui il poeta passa in rassegna la vanità dei desideri umani (“Vanitas vanitatum”). Giovenale osserva con cinismo come gli uomini passino la vita a implorare gli dèi per ottenere ricchezza, potere, bellezza o una vita lunga, senza rendersi conto che spesso sono proprio queste concessioni a portarli alla rovina.
Nel suo ragionamento, chi accumula ricchezze finisce spesso avvelenato da eredi avidi. Chi brama il potere politico rischia di fare la fine di Seiano, il potente prefetto di Tiberio, il cui corpo fu trascinato con un gancio per le strade di Roma tra gli insulti della folla. Chi chiede la bellezza per i propri figli li condanna a diventare preda di seduttori corrotti. Il messaggio è chiaro e spietato: bisogna stare attenti a ciò che si desidera, perché gli dèi, per punire, potrebbero esaudire quanto richiesto e implorato.
Le due parole che cambiano tutto
È in questo scenario di totale disillusione che arriva il celebre verso, spesso citato a metà. La frase completa, infatti, cambia radicalmente la prospettiva e si trova nel quarto libro delle Satire, precisamente nella decima Satira al verso 356:
Orandum est ut sit mens sana in corpore sano.
Quelle due parole iniziali, “Orandum est”, sono la chiave di volta: significano “bisogna pregare”. Giovenale non sta affermando che una mente sana risieda naturalmente in un corpo sano. Sta dicendo che, visto che la gloria e la ricchezza sono pericolose, se proprio l’uomo deve chiedere qualcosa al cielo, dovrebbe limitarsi a chiedere il minimo indispensabile: la salute. Dovrebbe pregare affinché il corpo regga e la mente rimanga integra. Non è un vanto di prestazione, ma un’umile richiesta di aiuto per sopportare le durezze dell’esistenza.
Che cos’è davvero una “mente sana”?
L’errore moderno, tuttavia, non è soltanto grammaticale, ma profondamente filosofico. Quando oggi si parla di “mente sana”, si tende a immaginare una mente produttiva, veloce, priva di stress, pronta per il lavoro. Ma per Giovenale, influenzato dalla dottrina stoica, la sanità mentale era tutt’altro.
Per comprendere meglio il significato della frase facendo riferimento allo stoicismo, subito dopo quel verso famoso il poeta definisce con precisione chirurgica cosa intenda per salute dello spirito nei versi 357-360. Ecco cosa deve chiedere l’uomo saggio:
“Fortem posce animum mortis terrore carentem,
qui spatium vitae extremum inter munera ponat
naturae, qui ferre queat quoscumque laboresLa traduzione svela il vero significato:
Chiedi un animo forte, libero dal terrore della morte,
che consideri la fine della vita come un dono di natura,
che sappia sopportare qualunque fatica.
La “mens sana” di Giovenale non è l’intelligenza logica. È, in definitiva, l’imperturbabilità, la tempra dell’individuo. È la capacità interiore di accettare la sofferenza, di non conoscere l’ira (nesciat irasci) e di non desiderare nulla che non si possa avere. È la pace interiore di chi sa stare al mondo senza esserne schiacciato.
La genesi di un equivoco secolare
Ma quando si è consumato questo tradimento semantico? Non esiste una data precisa sul calendario, eppure è possibile tracciare una linea del “crimine” molto chiara che mostra come la frase sia stata progressivamente svuotata della sua gravità stoica per essere riempita di nuovi significati utilitaristici.
Il primo colpevole intellettuale fu il filosofo inglese John Locke che, nel 1693, aprì il suo trattato Pensieri sull’educazione proprio con questa citazione. Locke, tuttavia, operò uno scarto fondamentale: trasformò quella che era una richiesta divina in un obiettivo pedagogico. La salute del corpo non era più una grazia da implorare, ma una condizione necessaria, quasi meccanica, per permettere alla mente di apprendere. Da preghiera, la frase divenne un progetto educativo.
Il vero punto di non ritorno si ebbe però nell’Inghilterra Vittoriana del XIX secolo, con l’avvento del cosiddetto “Cristianesimo muscolare“. Nelle rigide Public Schools britanniche, come Eton o Rugby, si radicò l’idea che lo sport forgiasse il carattere morale. Si iniziò a credere che un corpo allenato e disciplinato fosse garanzia automatica di una mente retta e di un cittadino esemplare, pronto a guidare l’Impero. Qui l’equivoco mise radici profonde: la dimensione della sofferenza interiore sparì del tutto a favore della prestazione esteriore.
Il XX secolo, con le sue tragedie, estremizzò ulteriormente questo concetto. I regimi totalitari si impossessarono della massima di Giovenale per scopi politici. Per il Fascismo e il Nazismo, l’educazione fisica di massa non serviva a creare filosofi stoici, ma una popolazione più “forte” e prestante. Il legame divenne brutale e diretto: il corpo forte serviva allo Stato, e la “mente sana” non era più quella saggia, ma quella purificata da ogni debolezza e allineata al regime.
Infine, nel dopoguerra, arrivò il mercato. La frase perse la sua connotazione politica per assumerne una commerciale, diventando il pilastro del nascente settore del fitness e persino l’acronimo di una delle più celebri aziende sportive: ASICS. Nel 1949, Kihachiro Onitsuka fondò la sua azienda di scarpe cercando un nome che ispirasse. Usò l’acronimo di una variante della frase latina: “Anima Sana In Corpore Sano”.
Da qui in poi, con il boom del fitness degli anni ’80 (Jane Fonda, il bodybuilding), la frase diventa definitivamente lo slogan commerciale che conosciamo oggi: “Fai sport per stare bene di testa”. La trasformazione era completa: da monito sulla vanità della vita, il verso era diventato uno slogan per vendere scarpe e abbonamenti in palestra.
Dall’estetica all’etica: una lezione per oggi
Rileggere oggi questo classico, depurato dalle incrostazioni della storia, permette di smettere di guardare alla palestra come a un luogo di redenzione psicologica automatica. Il fraintendimento dell’epoca attuale risiede proprio nell’illusione del controllo: nella convinzione che modellando l’esterno possiamo silenziare le inquietudini dell’interno.
Il corpo va certamente curato, Decimo Giunio Giovenale stesso riconosce che un “corpore sano” è un dono prezioso, ma l’equilibrio vero non nasce dai chilometri percorsi o dai pesi sollevati. Nasce da un esercizio molto più difficile e invisibile: quello di costruire uno spirito saldo, capace di restare in piedi anche quando il corpo cede o la vita colpisce duro. La lezione più grande è che la frase di Giovenale non è uno spot per l’estetica, ma una preghiera laica per avere coraggio e affrontare la vita su solidi e sani principi.