La lingua italiana è come il Made in Italy, un’eccellenza da difendere e gustare
Viviamo nell’era del “Globish” standardizzato, ma l’italiano resta la nostra Ferrari. Da Pasolini a Gramsci, ecco perché difendere la lingua italiana.
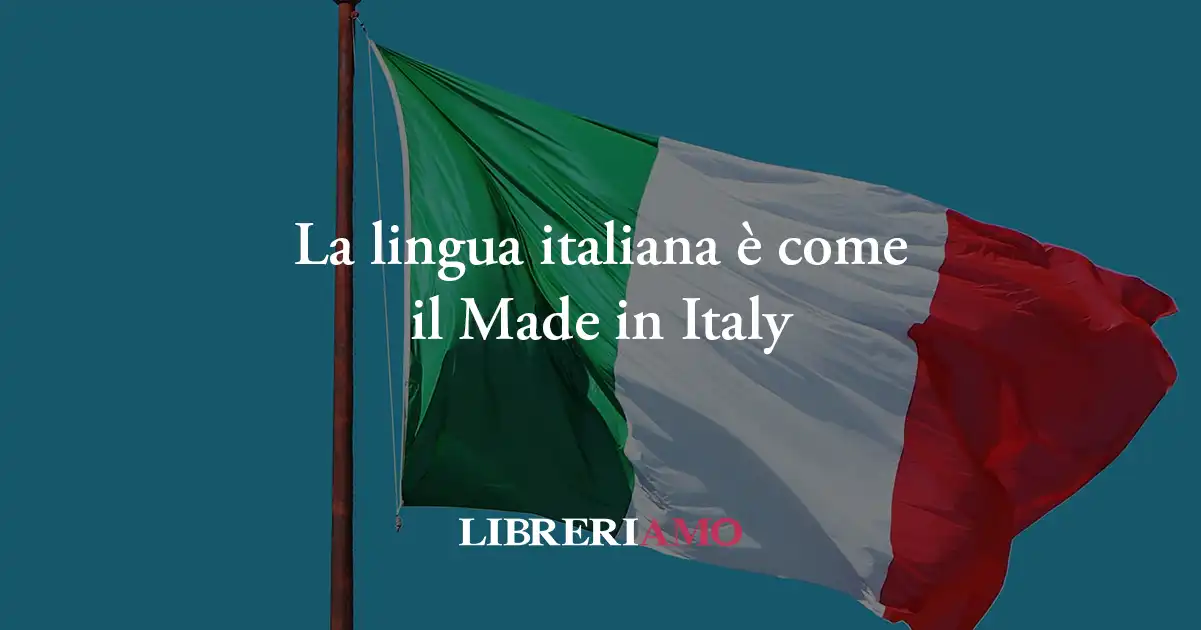
Viviamo in un mondo globale dove il cosiddetto Globish, l’inglese semplificato e standardizzato usato dai non madrelingua per comunicare a livello internazionale è diventato come la plastica utile, economico, indistruttibile, ma terribilmente standardizzato. La lingua italiana è la nostra seta, il nostro vino d’annata, la nostra Ferrari.
Non è un codice nato dalla burocrazia, ma da un miracolo di alto artigianato. Tutto è partito dal volgare fiorentino, una materia prima viva che i nostri grandi letterati hanno saputo lavorare, limare ed elevare. Dante, Petrarca e Boccaccio hanno fatto con le parole ciò che oggi fanno i grandi stilisti con i tessuti. Hanno trasformato una parlata locale in un modello di bellezza universale.
L’italiano, dunque, è il primo vero prodotto del Made in Italy, un’opera d’arte costruita per durare. E proprio come difendiamo le nostre eccellenze dalle contraffazioni, abbiamo il dovere di difendere la nostra lingua dall’appiattimento e dall’impoverimento estetico-culturale.
Sono state queste le motivazioni della pubblicazione di un libro, come 501 Quiz sulla lingua italiana (Newton Compton Editori) di Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo, in libreria da questo fine settimana.
Contro la lingua “di plastica”, tuteliamo l’italiano
Perché è urgente difendere la “sartorialità” dell’italiano? Perché il rischio, oggi, è che la lingua diventi un semplice strumento tecnico, perdendo la sua anima. Pier Paolo Pasolini, con profetica lucidità, lo aveva teorizzato già nel 1964 nel saggio Nuove questioni linguistiche, che si può leggere nel libro Empirismo eretico (Garzanti, 1972).
Egli aveva previsto una “lotta radicale tra comunicatività ed espressività”. La “comunicatività” è la lingua tecnologica, quella che serve solo a trasmettere dati (la “plastica”). L’”espressività” è invece la lingua della cultura e della poesia. Scriveva Pasolini:
Il fine della lotta del letterato sarà l’espressività linguistica, che viene radicalmente a coincidere con la libertà dell’uomo rispetto alla sua meccanizzazione.
Ecco il punto cruciale. Difendere l’italiano espressivo non è un vezzo da intellettuali. Significa difendere la nostra libertà dalla meccanizzazione, rifiutando di diventare ingranaggi di un mondo standardizzato, dove si usano parole tutte uguali.
La lingua come casa e memoria
Ma la questione non è solo sociale, è esistenziale. Se riduciamo il nostro vocabolario, riduciamo il nostro spazio vitale. Come affermava il filosofo Martin Heidegger nella Lettera sull’umanismo (1947)
il linguaggio è la casa dell’Essere.
Noi abitiamo le nostre parole. Se la nostra “casa linguistica” diventa povera e prefabbricata come il Globish, anche il nostro pensiero e la nostra esistenza rischiano di diventare superficiali. Inoltre, difendere le nostre parole significa custodire la nostra storia.
Ma la difesa della lingua non è solo una questione di estetica o di resistenza personale. È una questione di strategia nazionale. Antonio Gramsci, nei Quaderni del carcere, ci offre due lezioni folgoranti.
La prima riguarda l’individuo.
Possedere una lingua complessa significa possedere un pensiero complesso.
Chi parla solo il dialetto o comprende la lingua nazionale in gradi diversi, partecipa necessariamente di una intuizione del mondo più o meno ristretta e provinciale, fossilizzata.” Senza la padronanza della “lingua nazionale, storicamente ricca e complessa”, siamo condannati a una visione del mondo limitata.
La seconda lezione riguarda la nazione.
Gramsci osserva con ammirazione il “modello francese”, dove la lingua è trattata come un pilastro dello Stato. Scrive:
Il punto di vista francese è quello della «lingua» come concezione del mondo, come base elementare – popolare-nazionale – dell’unità della civiltà francese. Perciò l’Accademia Francese ha una funzione nazionale di organizzazione dell’alta cultura.
Gramsci ci dice che una grande nazione deve organizzare la sua cultura. Non possiamo lasciare la lingua al caso o al degrado. Dobbiamo curarla come la “base elementare” della nostra civiltà, esattamente come fanno i francesi. Il nostro “Made in Italy” linguistico ha bisogno di tutela, disciplina e orgoglio.
La biodiversità culturale
Spesso si crede che parlare una lingua “globale” sia l’unico modo per aprirsi al mondo. È vero il contrario. L’antropologo Claude Lévi-Strauss ci ha insegnato che il dialogo esiste solo tra chi è diverso. Se l’Italia rinuncia alla sua “seta” linguistica per vestire solo la “plastica” globale, non avrà più nulla di interessante da dire. Nel saggio Race et Histoire (Razza e storia, 1952) scriveva:
La civiltà mondiale non potrebbe essere altro che la coalizione, su scala mondiale, di culture che preservino ciascuna la propria originalità.
Se l’Italia rinuncia alla sua originalità linguistica per conformarsi a uno standard globale, non avrà più nulla di unico da offrire al mondo.
Sfatare un mito: tutelare le radici, non è provincialismo
Bisogna sgombrare il campo da un equivoco comune: tutelare la lingua italiana non è un atto di provincialismo nostalgico. Al contrario. Già il linguista Wilhelm von Humboldt sosteneva che ogni lingua traccia un “cerchio magico” intorno a chi la parla. È solo abitando pienamente il proprio cerchio, ovvero la propria lingua madre, che si hanno gli strumenti cognitivi per comprendere i cerchi degli altri.
Il vero provinciale oggi è chi, non possedendo una forte identità culturale, si limita a scimmiottare modelli esterofili senza capirli davvero.
Come ci ha insegnato la filosofa Simone Weil nel suo capolavoro La prima radice (L’enracinement, 1949), l’apertura verso l’altro è possibile solo se si parte da una base solida.
Il radicamento è forse il bisogno più importante e più misconosciuto dell’anima umana.
Un albero può stendere i suoi rami verso il cielo e verso gli altri alberi solo se ha radici ben piantate nel proprio terreno. Senza radici, non si vola: si viene spazzati via dal vento. Difendere l’italiano, dunque, non significa alzare muri, ma costruire le fondamenta necessarie per incontrare le altre culture alla pari, con dignità e ricchezza.
“Parole” contro “Termini”: la sfida di Leopardi
C’è infine una ragione puramente estetica, che ci riporta al cuore del Made in Italy. L’italiano non serve solo a definire la realtà, ma a immaginarla. È la celebre distinzione tracciata da Giacomo Leopardi nello Zibaldone (1821) tra “termini” e “parole”. I termini scientifici definiscono l’oggetto in modo freddo e chiuso. Le parole italiane, invece, evocano “immagini accessorie”, sentimenti, ricordi.
Il libro 501 Quiz sulla lingua italiana nasce proprio in questo solco. Non come un rigido manuale scolastico, ma come una palestra per riallenare la mente a scegliere la “parola” giusta – quella capace di evocare bellezza e precisione – rifiutando il “termine” generico e standardizzato.
È un modo per avvicinare le persone alla nostra lingua, per riscoprirne la straordinaria ricchezza e ampliare la conoscenza “giocando”. Perché custodire il nostro Made in Italy più prezioso non deve essere un dovere pesante, ma un piacere intelligente.