“Tutti gli indirizzi perduti”, un altro capolavoro di Laura Imai Messina
Su un’isola del Seto, l’archivio delle lettere mai recapitate riaccende memorie e legami. Laura Imai Messina firma “Tutti gli indirizzi perduti”.
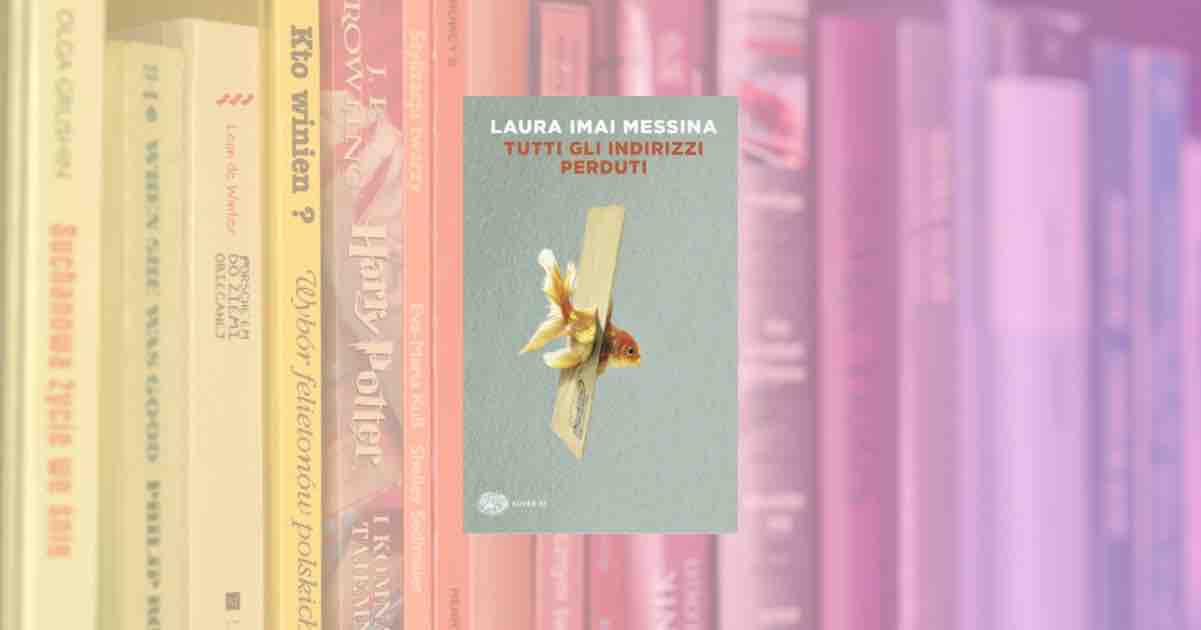
Dopo il “telefono del vento” di “Quel che affidiamo al vento”, qui Laura Imai Messina affida alla posta un gesto antichissimo – scrivere una lettera – e lo sposta in un luogo quasi mitico, un’isola del Mare Interno di Seto dove si conservano le missive destinate a chi è irraggiungibile. “Tutti gli indirizzi perduti” (Einaudi) è uscito a fine ottobre 2024 e conta 240 pagine: un romanzo compatto, costruito come una partitura di storie che si richiamano, una polifonia in cui la voce narrante tiene insieme fragilità private e domande comuni.
Uno “sfondo esistente”
L’ambientazione del libro non è invenzione pura: l’“Ufficio postale alla deriva” di Awashima esiste davvero, ed è il detonatore reale di una finzione che ha molto a che fare con la nostra idea di memoria, cura, comunità.
“Awashima è l’indirizzo che ha preso in carico tutti gli indirizzi perduti della terra”.
L’ufficio postale alla deriva
Arriva Risa, con una sacca di buste
Risa è una dottoranda dell’Università di Tokyo. Sbarca ad Awashima in una mattina tersa di primavera con una sacca di buste; si è offerta di catalogare le lettere accumulate per dieci anni nell’ufficio dell’isola. È figlia di un postino – l’uomo che le ha insegnato che nessuna lettera dovrebbe andare perduta – e porta con sé un’eredità più ambigua: una madre intermittente, visionaria, capace di parole magiche ma fragile nel reggere la vita.
L’inventario delle missive diventa un viaggio nelle vite degli altri: c’è chi scrive al marito morto, chi al proprio cuscino, chi chiede perdono a una lucertola, chi si rivolge alla sé del futuro o alla vecchia vicina che leggeva storie da bambino. Lì Risa incontra gli isolani (tra cui Takuto), ma soprattutto incontra se stessa, un pezzo alla volta, attraverso le parole altrui.
“I nostri pensieri sono naufraghi che chiedono come unico approdo l’ascolto”.
Un dispositivo narrativo semplice e preciso
Il romanzo alterna capitoli “di racconto” a lettere scelte dall’archivio: un ritmo che apre finestre e, insieme, mantiene la tensione sul percorso interiore della protagonista. La lingua è misurata, spesso in piano-sequenza, con scarti lirici controllati: non estetismo, ma la prova che si può essere dolci senza essere sfuggenti. L’andamento corale evita le scorciatoie del sentimentalismo; l’intreccio, pur lineare, gioca sul non detto, sugli spigoli della cura e sulle definizioni che diamo alle parole (“madre”, “perdono”, “attenzione”).
La verità di Awashima (e perché ci riguarda)
Sarebbe facile liquidare l’isoletta come un’invenzione poetica. E invece Awashima c’è, l’ufficio anche: riceve lettere per “amori mai nati”, “dentini da latte”, “inventori di oggetti” e persone scomparse. Il luogo è diretto da un anziano ex postino (Nakata Katsuhisa, novantunenne al momento del reportage) e custodisce la posta indirizzata a chi non ha un indirizzo.
Più vicino a noi, il Corriere di Bologna ha ricordato che l’ufficio “esiste davvero”, collocandolo su un’isola piccola, spopolata, dove si prova a tenere insieme comunità e memoria; la stessa iniziativa promozionale del tour italiano ha previsto cassette postali temporanee in alcune librerie per raccogliere missive “mai scritte”, poi lette dall’autrice e indirizzate ad Awashima.
“L’ufficio degli indirizzi perduti esiste davvero”.
La scrittura come gesto che cura
C’è una frase ricorrente che sembra il cuore etico del libro: “tutto il senso dello scrivere queste lettere è, precisamente, scriverle”. In una stagione che affida le nostre parole a piattaforme che dimenticano, la lettera – anche se senza risposta – è un atto di presenza: “messaggio in bottiglia” che alleggerisce il cuore e mette ordine al caos. Il romanzo lo mostra senza didascalie, lasciando che sia il lavoro paziente di Risa a costruire l’idea di cura: prendersi in carico la parola dell’altro è riconoscerne l’esistenza.
Come messaggi in bottiglia, sono parole lasciate andare alla deriva che non aspettano una risposta.
Gli sconosciuti contano (una politica dell’attenzione)
Tra le righe vive un’idea che l’autrice esplicita nella nota finale: siamo fatti anche degli sconosciuti. Non serve “meritare” l’attenzione per essere degni di cura; molto del nostro mondo è costruito da persone di cui non sapremo nulla, e tuttavia ne ereditiamo gesti, strade, case, oggetti. “Tutti gli indirizzi perduti” prova a rovesciare il primato del “conosciuto” e a rileggerlo come politica quotidiana dell’attenzione.
“È dall’incontro con gli sconosciuti che può nascere lo straordinario”.
Questa postura attraversa le storie delle lettere e le piccole pratiche dell’isola: fare spazio all’altro senza pretenderne la biografia, consentire che un indirizzo “sbavato” o mai scritto dica comunque qualcosa di vero.
Tempo, perdita, genealogie emotive
Il libro insiste su una domanda antica: come si trasmette il dolore? Non solo per via diretta, ma per eredità invisibili – “tracce” che rimbalzano tra generazioni. La riflessione sul tempo è fertile: sincronicità, “finestre” in cui certe azioni trovano l’innesto giusto, stagioni in cui è possibile rinunciare. L’universo di Risa ragiona proprio così, per finestre e fenditure.
“Disponiamo dell’infinito per un tempo limitato”.
Il percorso interiore della protagonista – alimentato da un rapporto complesso con la madre e da una dedizione quasi etica del padre postino – rende credibile l’oscillazione tra sospensione e slancio. Non c’è guarigione definitiva, ma una capacità rinnovata di stare nel mondo; e di scegliere parole più precise.
Comunità che resiste allo spopolamento
Awashima è anche un personaggio: un luogo che si svuota (scuole che chiudono, abitanti che invecchiano) e che proprio grazie a un archivio di lettere registra una forma di resistenza. L’ufficio postale alla deriva, minuscolo e un po’ sghembo, mantiene vivo il gesto di “passarsi parola”: nel romanzo è la prova che un’infrastruttura minima – una stanza, delle buste, un vecchio postino – può tenere insieme un’idea di comunità.
Struttura e stile
Un mosaico in trenta capitoli
La macchina narrativa è chiara: trenta capitoli, intervallati da lettere selezionate. Le missive non sono “siparietti” decorativi; spostano lo sguardo, allargano la mappa emotiva, rimbalzano sulla storyline di Risa con effetto di eco. L’impressione è di un diario collettivo che, a tratti, somiglia a una raccolta di micro-saggi sul vivere: dalla grammatica della gentilezza all’etica delle parole, fino alla responsabilità parentale di “non dire male” il mondo a chi nasce.
Una prosa “carezzevole” e concreta
Le recensioni hanno parlato – con resa felice – di un linguaggio “quasi poetico” e “estremamente umano”. La poesia qui non è zucchero: è precisione sensoriale (odori d’inchiostro, carta che taglia, sera che abbassa il tono della voce) e, soprattutto, controllo del ritmo. Le frasi si allungano quando la memoria dilata, si fanno brevi quando arriva la verità. Ne esce una voce che non teme la tenerezza, ma la usa per penetrare nei contrasti – “attenzione senza possesso”, “cura non proprietaria”.
“Imai Messina dà voce a un’umanità alla deriva, scegliendo con delicatezza l’incanto delle parole”.
Dove finisce il reale e dove comincia il romanzo
Un pregio forte del libro è il suo ancoraggio a un dato vero: l’ufficio esiste, è stato visitato e raccontato anche in reportage giornalistici. Nelle presentazioni italiane, l’autrice ha persino invitato i lettori a imbucare lettere “mai scritte” in cassette allestite dentro alcune librerie: un prolungamento performativo della finzione, che riporta il gesto dentro la vita quotidiana e rimette in circolo il senso del progetto. In questo senso la narrativa di Imai Messina somiglia a quelle opere che non si esauriscono sulla pagina, ma scommettono sul mondo.
La ricezione: cosa ha detto la critica
La rassegna stampa italiana ha accolto il romanzo con curiosità e affetto, spesso concentrandosi su tre elementi: il dispositivo delle lettere, il tema degli sconosciuti, il legame con l’isola reale.
Non si tratta, dunque, di un “romanzo di consolazione”: la dolcezza c’è, ma viene sempre attraversata da un’idea di responsabilità. In più, molte voci hanno letto il libro come dialogo implicito con Quel che affidiamo al vento: non un’auto-citazione, piuttosto la conferma che l’autrice sta costruendo un piccolo atlante di gesti per dire addio – o, almeno, per dire meglio ciò che ci manca.
Cosa funziona (e dove il libro rischia)
Le luci
Funziona l’ambientazione: l’isola non è cartolina, ma una comunità in bilico tra spopolamento e resistenza. Funziona la struttura a “lettere inframezzate”: l’alternanza impedisce la monotonia e offre brevi shock emozionali che spingono avanti la lettura. Funziona, soprattutto, la tesi etica: la centralità degli sconosciuti non come vezzo sociologico, ma come modo concreto di tenere insieme una società fatta di micro-gesti invisibili.
Le ombre (narrative, non ideologiche)
Chi preferisce la scrittura “scabra” potrebbe sentire – in alcuni passaggi – una sovrabbondanza di immagini. È una scelta consapevole: il tono “carezzevole” è parte del progetto, ma chiede al lettore un accordo iniziale sulla temperatura emotiva. A volte le massime aforistiche rischiano la didascalia; altrove, invece, spaccano il buio con precisione. Il romanzo, insomma, vive su una linea sottile tra lirismo e concretezza, che la prosa di Imai Messina – quando resta incollata alla fisicità di buste, timbri, inchiostro – attraversa con equilibrio.
Un piccolo atlante delle parole giuste
Il lettore chiude “Tutti gli indirizzi perduti” con una sensazione non scontata: la voglia di scrivere a qualcuno. Non perché la lettera garantisca la risposta – non la garantisce – ma perché “mettere in busta” significa dare forma a un sentimento, offrirgli il peso di una carta, la traccia di un timbro, l’ostinazione di un francobollo.
“Scrivere non è aspettarsi risposta: è accettare che le parole restino, anche quando noi passiamo”.
Questa, forse, è la chiave più onesta del romanzo: non promette guarigioni, ma suggerisce esercizi di presenza. E ci ricorda – con una semplicità che non è mai semplice davvero – che “attenzione” e “cura” possono esistere anche senza legame pregresso. È una politica minima delle relazioni, fatta di gesti gratuiti. Di sconosciuti che si sfiorano senza possedersi.
L’autrice, in breve
Nata a Roma, trapiantata in Giappone da oltre vent’anni, laureata e poi dottorata in letteratura, Laura Imai Messina insegna a Tokyo e vive tra Kamakura e la capitale. I suoi libri – dai saggi su Tokyo e sui colori fino ai romanzi – mostrano un’attenzione costante per i modi in cui le città, gli oggetti, le abitudini quotidiane ci educano a guardare. Anche per questo “Tutti gli indirizzi perduti” suona autentico: nasce da un lavoro di osservazione e di ascolto, da luoghi frequentati e persone incontrate.