Cos’è lo spiritual realism e perché riguarda Emmanuel Carrère?
Dopo il disincanto, la letteratura riscopre il sacro: Emmanuel Carrère e lo spiritual realism danno voce alla sete di senso del nostro tempo.
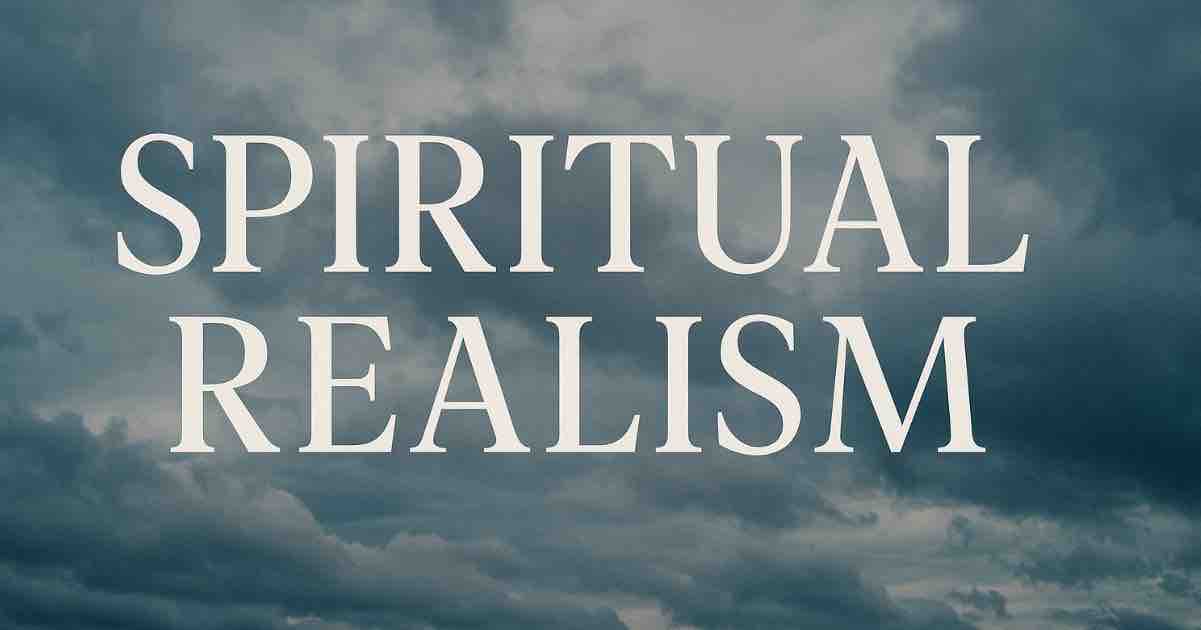
Negli ultimi anni, mentre la narrativa mainstream oscillava tra autofiction e thriller psicologici, è tornata a farsi sentire una vena sotterranea che non è né religiosa né new age, né fantastica né mistica, eppure parla apertamente di fede, di assenza di fede, di preghiera, di ricerca, di senso.
È quella che possiamo chiamare spiritual realism: un realismo che non rinuncia alla concretezza del quotidiano, ma ammette che dentro le vite reali c’è una zona verticale, una parte non misurabile, una domanda che resiste anche quando non crediamo più. È la narrativa che dice: “non so se Dio c’è, ma so che non posso vivere come se non ci fosse mai stata la possibilità di Lui”.
Perché nasce ora?
Perché abbiamo avuto decenni di ironia, di postmoderno, di smontaggio dei grandi racconti. “Tutto è narrazione”, “tutto è costruito”, “tutto è linguaggio”: verissimo, ma a un certo punto la vita bussa. Malattia, morte dei genitori, figli, depressione, crisi del mondo, guerra alle porte: e la letteratura fa quello che sa fare meglio, cioè ritrascrivere l’esperienza. Solo che, questa volta, non la ritrascrive più solo in chiave psicologica o sociale: la ritrascrive in chiave spirituale. Non religiosa, spirituale. È diverso.
In questo scenario, uno dei nomi che emergono subito è Emmanuel Carrère. Non perché sia un teologo (non lo è), non perché sia un cattolico militante (non lo è più), ma perché è uno degli scrittori contemporanei che hanno avuto il coraggio di raccontare in modo frontale una crisi di fede e di tenerla dentro la letteratura senza trasformarla in sermone. E infatti in Italia è amatissimo: lo leggono i lettori letterari, lo leggono i lettori di non-fiction, lo leggono quelli che amano i reportage e quelli che amano i romanzi sulla vita vera. Carrère riesce in una cosa difficilissima: usa il metodo del giornalismo e del romanzo per parlare di ciò che normalmente è territorio della teologia.
Che cos’è davvero lo spiritual realism?
Lo spiritual realism nasce da un gesto semplice ma radicale: guardare la realtà senza smettere di credere che in essa ci sia qualcosa di invisibile. È realismo, certo, ma un realismo che non si accontenta dei fatti. Parte da persone vere, da luoghi riconoscibili, da atti, ricordi, testimonianze, perfino da pagine del Vangelo o da faldoni giudiziari. Tutto accade nel tempo e nello spazio: non c’è magia, non c’è soprannaturale. Eppure, tra le pieghe di ciò che accade, lo scrittore cerca qualcos’altro — un segnale, un varco, una domanda che non si lascia chiudere.
Per questo è un realismo che diventa spirituale: non dice solo “è successo”, ma si chiede “perché è successo?” o “chi ero io mentre accadeva?”. È la scrittura che non pretende risposte ma difende il diritto alla domanda — quella domanda che la nostra epoca, troppo razionale o troppo disincantata, tende a soffocare. In questo senso, lo spiritual realism è profondamente laico: non predica, non catechizza, non offre consolazioni. Lo scrittore non parla dall’alto di una verità già trovata, ma dal fondo di una ferita che vuole comprendere.
Infine, è una narrativa dialogica. In ogni libro c’è sempre un interlocutore, anche quando non viene nominato: può essere Dio, un morto, un lettore, una persona amata, o la parte più nascosta di sé. La pagina non è mai monologo, ma una preghiera incerta, un tentativo di relazione con qualcosa o qualcuno che sfugge.
In fondo, lo spiritual realism è il realismo dopo la delusione. Dopo aver capito che la politica non basta a redimere il mondo, che la psicanalisi non spiega tutto e che la storia non ci protegge, rimane l’esigenza di una lingua capace di tenere insieme ciò che vediamo e ciò che manca. È la scrittura di chi, anche nel buio, continua a credere che una luce da qualche parte ci sia — e che raccontare serva almeno a cercarla.
Perché Carrère è il volto più riconoscibile
Perché non bluffa.
Carrère non scrive dall’alto di una verità già posseduta. Scrive mentre cerca. È sempre in bilico. Ne “Il Regno” racconta un periodo della sua vita in cui andava a messa, leggeva i Padri della Chiesa, pregava, teneva un quaderno spirituale. Poi questa fede si è sgonfiata. Un altro autore l’avrebbe nascosta per non darsi l’aria del convertito fallito. Lui no: la porta in scena. E dice: “Ero credente. Non lo sono più. Ma non posso fingere che non sia successo”.
È proprio questo che lo rende vicino ai lettori: non è perfetto, non è tutto risolto, non è nemmeno sempre simpatico. Ma è vero. E lo spiritual realism, per funzionare, ha bisogno di questa verità scomoda: non della santità, ma dell’ammissione.
“Il Regno” (2014)
Carrère parte da un fatto reale: negli anni ’90 attraversa una fase di fede fervorosa. Va in chiesa, legge il Vangelo ogni giorno, scrive commenti, è quasi entusiasta. Anni dopo, quella fase è finita. Lui è tornato a essere quello che era: uno scrittore laico, curioso, ironico, sensuale. Ma quella parentesi mistica lo ha segnato e lui vuole capire che cos’era. Era follia? Era bisogno? Era grazia? Era autosuggestione?
Nel libro, allora, fa due cose in parallelo:
- ricostruisce la nascita del cristianesimo attraverso Luca e Paolo, come se fosse un romanzo storico;
- ricostruisce la sua nascita di credente e la sua caduta di credente.
Il risultato è una specie di inchiesta spirituale. Carrère dice: “cammino con loro” (Luca, Paolo), “indago con loro”, “vedo come uno ha creduto nel racconto dell’altro”. È straordinario perché non chiede mai al lettore di credere. Gli chiede solo di prendere sul serio la possibilità che un giorno, nella storia, qualcosa sia davvero successo. Lo spiritual realism è questo: non finge il miracolo, ma non lo liquida.
E narrativamente funziona benissimo perché Carrère mantiene la struttura del reportage: va nelle biblioteche, cita i biblisti, racconta le sue storie d’amore finite male, parla del suo narcisismo. Mescola alto e basso. Il sacro non è mai isolato: è sempre dentro la vita.
“L’avversario” (2000)
Qui lo spiritual realism si vede da un’altra angolazione. Il libro è la ricostruzione del caso Jean-Claude Romand, l’uomo che per anni ha finto di essere un medico dell’OMS e che, quando la menzogna è crollata, ha ucciso moglie, figli e genitori. È un fatto di cronaca nera, uno dei più terribili della Francia contemporanea. Perché dovrebbe entrarci la dimensione spirituale?
Perché Carrère lo legge alla luce della parola paolina “l’Avversario”: il diavolo, l’ingannatore, il mentitore. Non per dire “Romand era posseduto”, ma per dire che in ognuno di noi c’è un luogo dove il male parla e convince. Carrère scrive con prudenza, con una pietà durissima, e si chiede: “io, al suo posto, sarei stato migliore?”. Non risponde. Non assolve. Non condanna troppo. Abita la zona grigia. E quella zona grigia è precisamente il luogo dello spiritual realism: non il male come categoria, ma il male come esperienza interiore.
È un libro che mostra come il fatto vero possa diventare parabola spirituale senza essere moralistico. Ti fa capire che lo spiritual realism non è solo fede e Vangelo, ma anche male e colpa.
Lo spiritual realism differisce dalla narrativa religiosa
Questa distinzione secondo me nel pezzo va messa bene in chiaro, perché altrimenti ti dicono: “ma quindi è narrativa cristiana?”. No. È quasi il contrario.
La narrativa religiosa parte da una verità e la mostra. Lo spiritual realism parte da un’assenza e la interroga.
In Carrère, spesso Dio non risponde. Non c’è epifania. Non c’è finale consolatorio. Eppure tu chiudi il libro con l’impressione che ci sia stata una liturgia: la liturgia del dire la verità su di sé.
Altri autori in scia
Emmanuel Carrère non è un caso isolato. Lo spiritual realism è una corrente silenziosa ma crescente, che attraversa la narrativa contemporanea come un bisogno comune di riaprire uno spazio al trascendente dopo anni di disincanto. In molte scrittrici e scrittori di oggi si avverte la stessa tensione verso un reale che non basta a se stesso.
Marilynne Robinson, con la trilogia di Gilead, Lila e Jack, è forse la voce più vicina a un cristianesimo letterario autentico: racconta un pastore anziano che scrive al figlio, ma lo fa con uno stile sobrio, intimo, completamente terreno. Ogni gesto domestico — un pasto, una camminata, una preghiera sussurrata — diventa contemplazione. Il suo realismo è preghiera che si finge prosa.
Olga Tokarczuk, invece, affronta la spiritualità da un’altra prospettiva: la visione del mondo come organismo vivente, dove ogni creatura, ogni cosa, è collegata a un tutto più grande. Nei suoi romanzi, il sacro non è trascendenza, ma rete: la vita stessa come principio sacro, come respiro che unisce. È spiritual realism in chiave mitopoietica, dove la filosofia si intreccia con la compassione ecologica.
In Annie Ernaux, la spiritualità non si manifesta come religione, ma come esigenza di verità. Quando scrive della madre, della vergogna, della memoria del tempo, non parla di Dio ma ne evoca la sostanza: l’obbligo di dire la verità su di sé, anche quando fa male. È una forma di santità laica, una fede nella parola come strumento di giustizia interiore.
Infine Karl Ove Knausgård: nelle pagine più contemplative della sua opera, quando si ferma sulle stagioni, sui figli, sul corpo del padre morto, si avverte una verticalità che scava nel quotidiano. La sua attenzione al dettaglio — la luce che cambia, il respiro del bambino, la neve che cade — diventa un modo di nominare l’eterno dentro l’istante.
Guardandoli insieme, si capisce che lo spiritual realism non è un’etichetta ma una sensibilità condivisa: la volontà di restituire alla letteratura la possibilità del sacro, senza teologia e senza dogma. Carrère è una delle sue voci più riconoscibili, ma il coro è ampio: tutti, in modi diversi, cercano di scrivere non solo cosa accade, ma cosa significa vivere in un tempo che ha smarrito il proprio cielo.