Che cos’è la speculative fiction? Il genere che immagina l’impossibile per raccontare il reale
Speculative fiction: il genere che immagina scenari alternativi al reale. Da Orwell a Dick, perché oggi torna centrale per raccontare il nostro tempo.
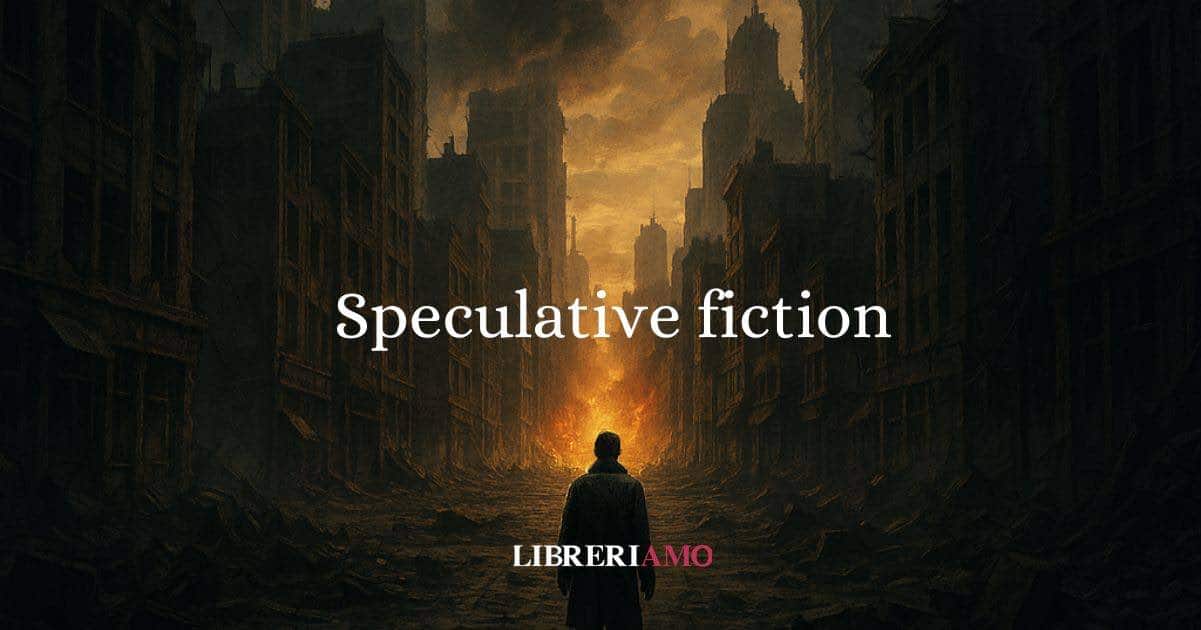
Se il grimdark è il lato oscuro del fantasy, la sua naturale evoluzione, la speculative fiction è pressoché — e ribadiamo pressoché — la stessa cosa per quanto riguarda la fantascienza: un sotto genere necessario che è andato creandosi con il passare del tempo.
Non indica soltanto storie di astronavi o mondi futuri, dov’è possibile intersecare le conoscenze attuali con la tecnologia inventata e più disparata, ma tutte quelle narrazioni che partono da un “e se…?” e portano alle estreme conseguenze ipotesi immaginarie.
Dalle radici della fantascienza alla sua evoluzione
Il termine si diffonde negli anni ’40 grazie a Robert A. Heinlein, che lo proponeva come alternativa a science fiction, e negli anni successivi è stato ripreso per comprendere romanzi che non si limitano alla scienza, ma sperimentano con filosofia, politica, antropologia e metafisica.
Il termine “speculative fiction”
La speculative fiction non ha confini netti: include distopie, ucronie, fantasy politico, post-apocalittico, perfino alcuni horror. È meno un genere e più un termine ombrello che si usa in narrativa e abbraccia tutto ciò che immagina scenari alternativi al reale.
Se la fantascienza “dura” chiede coerenza scientifica, la speculative fiction chiede coerenza concettuale: cosa accadrebbe al nostro mondo se cambiasse una regola fondamentale? Qualcosa si stravolgerebbe. Cosa? Come andrebbe la storia?
Perché nasce e perché oggi conquista i lettori
L’esigenza che ha portato alla nascita della speculative fiction è duplice: da un lato c’è la voglia di superare i confini rigidi dei generi, dall’altro la necessità di parlare del presente con strumenti metaforici.
Ogni “speculazione” diventa un laboratorio per analizzare paure, desideri e contraddizioni contemporanee.
Crisi ambientali, intelligenze artificiali e conflitti globali: la speculative fiction diventa terreno fertile in questi anni almeno quanto in quelli della sua fioritura, quando ogni “e se” era necessità di per discutere temi politici e sociali senza perdere la libertà.
Non è vera e propria evasione, quella della speculative fiction, ma specchio: non ci porta lontano dal reale, ma ce lo restituisce deformato, per renderlo più leggibile.
I primi grandi esempi
Tra i romanzi pionieri possiamo ricordare “1984” di George Orwell, distopia per eccellenza che immagina un mondo governato dal controllo totalitario del Grande Fratello e dalla manipolazione linguistica, ma anche — e soprattutto — “La svastica sul sole” di Philip K. Dick, che reimmagina il dopoguerra con una premessa ucronica: cosa sarebbe accaduto se l’Asse avesse vinto la Seconda guerra mondiale?
Questi testi non sono solo fantascienza o storia alternativa, ma speculative fiction pura, perché interrogano direttamente la società e le sue derive possibili.
“1984”
Winston Smith vive a Londra, in un futuro dominato dal Partito unico, guidato dal Grande Fratello. Qui, ogni gesto, parola e pensiero sono sorvegliati da un regime che manipola la realtà attraverso la Neolingua e la riscrittura continua della storia.
È l’amore clandestino per Julia e il tentativo di ribellione che portano Winston a scoprire quanto sia impossibile sfuggire al controllo: la libertà non è solo proibita, è inconcepibile.
Con questo libro, Orwell ha costruito un mondo che ancora oggi è sinonimo di totalitarismo e sorveglianza, la distopia per eccellenza che è critica all’Unione Sovietica.
“La svastica sul sole”
Negli anni ’60 alternativi immaginati da Dick, il Giappone controlla la costa occidentale degli Stati Uniti, la Germania nazista domina l’Est e il resto del mondo vive sotto dittature feroci: la vita quotidiana è segnata da discriminazioni, paura e menzogne di Stato; eppure, circola un libro proibito che racconta una realtà diversa, una realtà in cui la guerra è stata vinta dagli Alleati.
Il confine tra storia e immaginazione si incrina, aprendo domande radicali su verità e manipolazione, sul destino e la possibilità di cambiare la storia…
Speculative fiction oggi
Oggi la speculative fiction include opere diversissime: dai romanzi climate-fiction, che immaginano un mondo devastato dal cambiamento climatico, alle distopie come “Il racconto dell’ancella”, che riprendono la tradizione per raccontare le derive patriarcali del presente.
La sua forza sta nella fluidità: è un genere che non chiude, ma apre, che non detta regole, ma invita a speculare.
“Membrana” di Chi Ta-wei: speculative fiction queer e visionaria
Pubblicato nel 1995 a Taiwan e tradotto in italiano solo di recente, “Membrana” è considerato un piccolo classico della speculative fiction asiatica. L’autore immagina un futuro dominato dall’ecologia artificiale e dalla tecnologia delle superfici: la pelle, lo schermo, la membrana diventano metafore del confine tra umano e non umano.
La protagonista, Momo, è una giovane estetista che vive isolata in un mondo subacqueo, mentre la superficie terrestre è diventata inabitabile a causa della catastrofe ecologica e le continue guerre di espansione dei Paesi.
Tutto nella sua vita passa attraverso membrane: schermi che filtrano il reale, cosmetici che ricostruiscono identità, pareti che proteggono e imprigionano. Il romanzo si tinge di riflessione filosofica e queer: il corpo stesso diventa un’interfaccia da manipolare, un confine fragile tra intimità e artificio.
La trama si sviluppa in un crescendo di scoperte: chi è davvero Momo? Da dove viene il suo isolamento? E cosa si nasconde dietro la società delle superfici che la circonda? “Membrana” è insieme distopia ecologica, parabola cyberpunk e racconto di identità fluide. Incarna perfettamente la forza della speculative fiction: partire da un dettaglio — la membrana che filtra — per trasformarlo in una chiave di lettura del nostro presente, fatto di schermi, identità digitali e crisi ambientale.