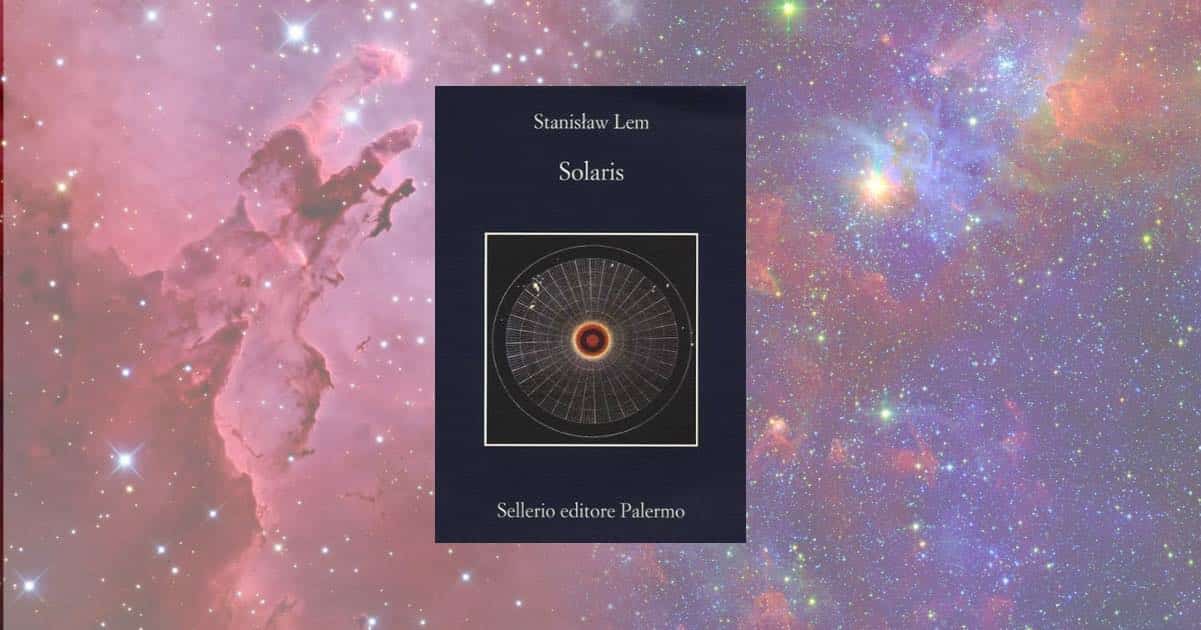Che cosa vediamo quando crediamo di incontrare l’Altro? È questa la domanda che ci pone Stanisław Lem con “Solaris” (1961), mettendoci di fronte non un alieno antropomorfo come quelli di Ridley Scott, ma un oceano planetario senziente: un’unica, sterminata entità in grado di reagire allo stimolo umano producendo “visitatori”, figure concrete dalle pieghe della memoria.
Il risultato è un libro che parla meno di stelle e più di limiti della conoscenza, identità, colpa, desiderio, lutto, un classico che la critica ha sempre letto come “opera profondamente filosofica su un’intelligenza radicalmente aliena” e sulle insufficienze del nostro sguardo: la base dello shi-fi moderno.
“Solaris”, un’indagine in orbita
Il giovane psicologo Kris Kelvin approda alla stazione orbitale su Solaris per valutare la situazione scientifica e psichica dell’equipaggio. Quello che trova è un ambiente spaesato e in rovina: due scienziati reticenti, un collega morto da poco, e soprattutto presenze che non dovrebbero esistere, delle materializzazioni perfette di persone amate, temute dai ricercatori.
Solaris sembra “rispondere” alle investigazioni umane con una contro–indagine: restituisce ai terrestri immagini incarnate del loro inconscio e li costringe a fare i conti con ciò che rimuovono. L’eroe scientifico diventa così paziente: l’esperimento è rovesciato, e il romanzo interroga il lettore su quanto di umano proiettiamo nell’ignoto.
Cosa rende Solaris unico
L’“alieno assoluto”: un oceano che pensa
Lem evita l’alieno “traducibile” in linguaggio umano. L’oceano è incommensurabile: non ci parla, ci reagisce. La scienza — qui una disciplina ironicamente chiamata Solaristica — accumula dati, modelli e dispute per decenni, ma resta ai margini del senso. È la più radicale critica al mito del contatto: cercavamo un dialogo, troviamo uno specchio che deforma.
Il laboratorio etico del ricordo
Le “creature” che l’oceano invia non sono cliché fantascientifici: sono relazioni che tornano in carne e ossa. Il romanzo mette alla prova l’idea stessa di responsabilità, e la categoria di verità emotiva e ci apre delle domande: possiamo ferire ciò che abbiamo, in qualche modo, evocato? Un simulacro che soffre è “meno vero”?
Un richiamo a questi interrogativi lo affrontano diversamente anche film come “Infinity Pool – Piscina infinita”, o “Mickey 17”, dove lo spettatore è portato a chiedersi se l’io originale ha più o meno diritti dell’io sofferente.
Fantascienza come filosofia narrativa
Ed è qui che irrompe nella scena la filosofia di Lem. Come hanno osservato letture autorevoli, Lem usa il genere per mettere in scena epistemologia e fenomenologia dell’incontro; “Solaris” è stato letto come una riflessione sull’umanesimo sotto stress: l’universo non è un museo per umani, e l’Altro non esiste per essere compreso da noi.
Lem contro il cinema: perché nessun film gli bastò
Di Solaris ricordiamo almeno due celebri adattamenti: quello di Andreij Tarkovskij (1972) e quello di Steven Soderbergh (2002). Tuttavia, autore e cinema non si sono incontrati.
Tarkovskij vinse il Gran Premio della Giuria a Cannes e firmò un capolavoro melancolico e metafisico; eppure Lem giudicò quel film troppo psicologistico e “terrestre”, lontano dalla sua idea di “Solaris”. Lo racconta con chiarezza un lungo dossier che ricostruisce il braccio di ferro Lem–Tarkovskij, dalle prime stesure del copione alle polemiche successive.
Soderbergh, tre decenni dopo, asciuga e intimizza ancora di più, scegliendo il melodramma filosofico: elegante, ma per Lem ancora distante dalla sua domanda dura sul fallimento gnoseologico.
La stampa anglofona ha spesso notato come i due film — pur bellissimi — spostino il baricentro verso l’amore perduto e la memoria, dove il romanzo resta più anti–antropocentrico.
La “questione traduzione”: un “Solaris” dimezzato
Per decenni il mondo anglofono ha letto “Solaris” in un’edizione tradotta dal francese (1970), non dal polacco: una versione accorciata e levigata, che lo stesso Lem definì insoddisfacente.
Solo nel 2011 è arrivata una nuova traduzione diretta dal polacco firmata da Bill Johnston, prima in audiolibro e ebook, e solo dopo, nel 2024, in cartaceo. È un passaggio decisivo: molte sfumature — lessico tecnico, ironie, densità filosofica — riemergono.
Lem, l’ingegnere della meraviglia
Polacco, cresciuto tra guerra e dopoguerra, Stanisław Lem (1921–2006) è stato romanziere, saggista, futurologo, critico del genere (celebre la sua polemica contro certa sci–fi americana), e insieme artigiano dell’immaginazione. “Solaris”, “La voce del padrone”, “Fiabe di robot”, “Cyberiada” compongono un’opera che ha unito rigore speculativo e gioia d’invenzione. Un profilo pubblicato dal New Yorker lo riassume bene: Lem voleva sbalordire, non solo spiegare; la sua letteratura è pensiero che narra.
“Non vogliamo altri mondi, vogliamo specchi”: la frase più citata (e fraintesa)
La massima più famosa attribuita a “Solaris” — spesso ricordata nelle recensioni e negli adattamenti — suona come un monito: gli umani usano l’universo per riflettersi. È l’atto d’accusa di Lem contro l’antropocentrismo della conoscenza. Nei film questa intuizione diventa melodramma della perdita; nel libro è un teorema amaro: l’universo non ha l’obbligo di essere leggibile in “umano”.