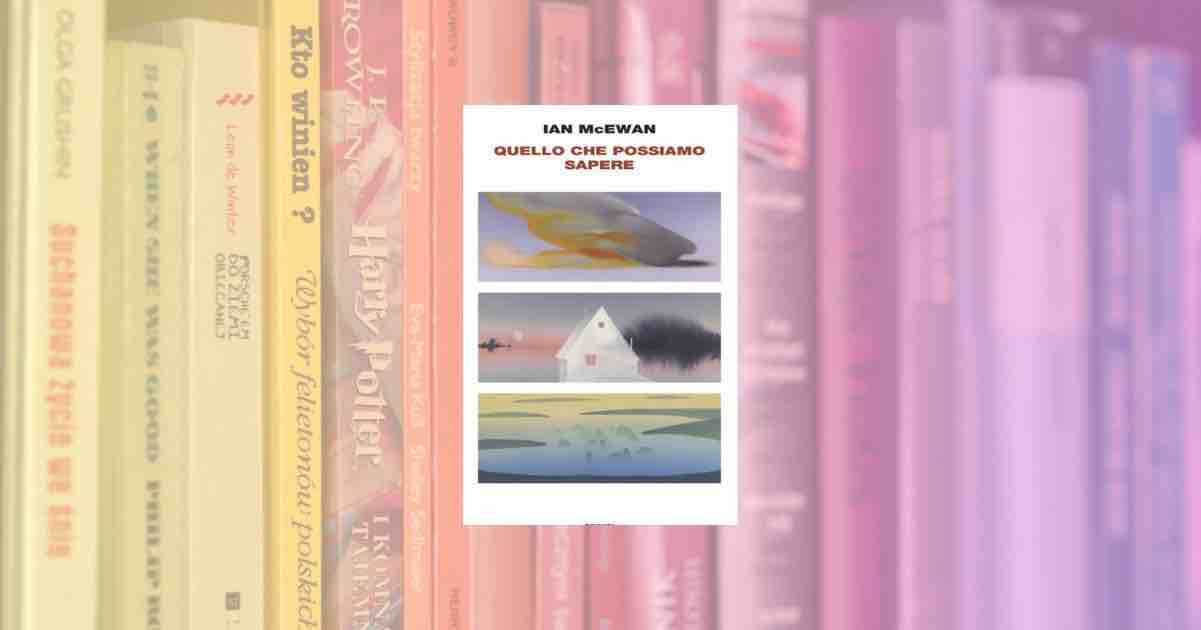«È come fantascienza senza la scienza: uno sguardo su dove potremmo finire se continuiamo così» (Ian McEwan).
“Quello che possiamo sapere”, un romanzo che parla davvero
All’inizio non c’è un detective, ma un filologo: Thomas Metcalfe, studioso del XXI secolo visto dal 2119, sopravvissuto a un mondo in parte sommerso da un “Grande Disastro”. La Bodleian, rifugiata in Snowdonia per scampare alle inondazioni, è diventata un avamposto della memoria: qui Metcalfe insegue la traccia di una poesia mai pubblicata — Corona per Vivien — declamata nel 2014 dal grande poeta Francis Blundy durante una cena amicale, poi svanita nel nulla.
La sua “indagine” è un viaggio tra carte, diari e dicerie: un caso letterario che diventa in fretta un caso morale e ci domanda “che cosa sappiamo delle vite altrui?” e, poco alla volta, prende le sembianze di un caso politico: “che cos’abbiamo fatto al pianeta, e a noi stessi, tra 2020 e 2100?”
Eco-speculativo?
Leggiamo di un mondo “ormai in gran parte sommerso dopo un Grande Disastro” e di un archivio trasferito per salvarlo dalle acque e subito ci viene in mente un genere che parla di disastro ambientale, ecosistemi distrutti e possibilità realistiche: l’eco-speculativo.
McEwan costruisce qui uno dei suoi dispositivi più eleganti: un romanzo d’idee che usa l’archivio come motore narrativo, facendo correre in parallelo la caccia al poemetto perduto e la caccia — impossibile — alla verità storica. L’effetto è doppio: romanzo d’amore e di spionaggio intimo (cominciano le domande interne del romanzo: chi era davvero Vivien? Quale segreto custodivano Blundy e il suo circolo?) e romanzo d’anticipazione, dove la climatologia e la geopolitica agiscono come retroscena continuo del cli-fi/eco speculativo.
Il progetto, nelle parole dell’autore, è un esperimento di prospettiva: osservare il nostro presente “da dopo”, quando la catena di eventi — pandemie, tensioni nucleari, crisi climatica — ha cambiato la scala del possibile. “Molto del libro si svolge nel 2119” e il “deragliamento” del secolo è raccontato come un accumulo di shock (“pandemie, conflitti regionali, un blackout prolungato”), non come un’unica apocalisse, chiarisce McEwan in un’intervista.
Un McEwan riconoscibile (e sorprendentemente nuovo)
Il ritorno alla macchina-romanzo
Chi ha amato “Espiazione” riconoscerà la passione per gli archivi, le lettere, le “carte” che distorcono o rettificano il passato. Qui la posta in gioco è più radicale: non soltanto “chi ha fatto cosa” (l’enigma micro), ma “che cosa potremo mai sapere di noi” (l’enigma macro) quando i supporti della memoria — biblioteche, server, giornali — si sfarinano. L’artigianato romanzesco è quello classico di McEwan: precisione di dettaglio, gestione della suspense, una lingua tersa che allinea i fatti finché la loro somma produce un brivido morale.
Non è la prima volta che lo scrittore sfiora il futuro: “Solar” affrontava il climate change satirizzandone i protagonisti, “Macchine come me” giocava con l’IA in un’Inghilterra alternativa, “Lezioni” ragionava sul tempo privato e storico. “Quello che possiamo sapere” fonde questi filoni e li piega a un giallo intellettuale che procede per dossier. The Guardian ha sintetizzato bene la mossa: McEwan “riporta le sue ossessioni etiche e filosofiche dentro una storia avvincente” e costruisce “un romanzo brillante, dalla portata audace”.
Una cornice che parla al presente
Nei materiali dell’editore statunitense (Alfred A. Knopf) il libro è presentato come “un’indagine romanzesca nella verità delle vite altrui e nel destino delle nostre democrazie”, con l’idea-chiave che il sapere sia sempre parziale, contestato, fragile. Il catalogo riunisce anche la rassegna delle prime recensioni americane (NYT, Washington Post, WSJ, LA Times), segno di un’accoglienza alta e controversa: “ambizioso e provocatorio”, “un’ipnosi morale in forma di mystery”, “il romanzo più politico di McEwan da anni”.
“Fantascienza senza la scienza”? Il patto con il lettore
McEwan ha definito questo libro “science fiction without the science” — la formula è felice: il dispositivo è fantascientifico (proiezione al 2119, mondo a bassa energia, biblioteche migrate in montagna), ma la materia resta umana, storica, politica. Più Ursula Le Guin che hard sci-fi: meno ingegneria, più antropologia del futuro. Lo scrittore, ripete, non sta “predicendo”: usa l’immaginazione come lente d’ingrandimento su un avvenire verosimile. “È il mio tentativo di guardare indietro al nostro tempo da un punto più in là,” dice, “per chiedere che cosa resterà conoscibile.”
Questa scelta, ha notato The New Yorker, produce un attrito interessante: il piacere del romanzo d’indagine convive con una meditazione epistemologica quasi saggistica. Invece di chiudere il caso, McEwan lo apre: what we can know è domanda, non risposta; e il finale, più che rivelare, ricompone in modo obliquo le biografie in gioco. (“McEwan ci lascia con un senso di conoscenza guadagnata e insieme insufficiente”, sintetizza la rivista).
Il banchetto del 2014 e la poesia scomparsa
Ottobre 2014: durante una cena battezzata “Secondo Immortal Convivio” — eco del leggendario banchetto del 1817 cui presero parte Keats e Wordsworth — Francis Blundy declama alla moglie Vivien una corona di sonetti che pare un manifesto amoroso e un testamento poetico. Nessuno la vedrà mai più. Tra i convitati circolano rivalità sentimentali, un liutaio di nome Percy, malattie che mordono le memorie, ambizioni represse. La Corona diventa subito leggenda.
2119: Thomas Metcalfe, filologo e sopravvissuto
Cent’anni dopo, Metcalfe s’incaponisce: archivi allagati, corrispondenze perse, lacune dovunque. Ma un indizio fragile — una lettera, una cassa, un ricordo — lo spinge a una “caccia al tesoro stevensoniana”, promette il materiale dell’editore. Il lettore segue Metcalfe attraverso un’Europa più sobria e più povera, dove il lusso del secolo passato è nostalgia e colpa. “Non è distopia cupa, ma un dopodramma realistico”, si è detto: McEwan ambienta la sua indagine in un mondo riconoscibile, spostato di due-tre scatti oltre l’oggi.
Il cuore segreto
Che fine ha fatto la Corona per Vivien? E cosa svela, se esiste ancora? Qui sta la delicatezza del libro: l’enigma letterario si lega a un crimine inespresso, a un compromesso morale, a un amore che non combacia con il racconto ufficiale. McEwan lavora sui doppi fondi della memoria privata (ciò che non si dice) e su quelli della memoria pubblica (ciò che si archivia, si espone, si cancella). Il colpo di scena — quando arriva — non chiude il senso; lo rilancia.
Primi riscontri
- Regno Unito: The Guardian ha dedicato al libro un’anteprima ampia già a inizio anno e poi una recensione al lancio: un McEwan “in forma smagliante”, capace di “trasformare il dubbio in materia narrativa” e di “tenere insieme” romance, giallo e romanzo d’idee. L’aspetto più lodato è la voce: un narratore che non spiega, ma orchestra indizi, come in un casebook d’altri tempi.
- Stati Uniti: L’Associated Press ha insistito sul taglio speculativo: è “fantascienza senza la scienza”, con “gran parte della storia nel 2119” e un elenco di traumi che somiglia alla nostra cronaca ingigantita. La stessa agenzia ha sottolineato l’uso politico del futuro: non allarmismo, ma “retrovisione” critica.
- Rassegna editoriale: Il catalogo Knopf raccoglie i pareri dei principali quotidiani americani (NYT, Washington Post, Wall Street Journal, Los Angeles Times): il consenso converge sull’ambizione e sull’eleganza dell’impianto; i dissensi (quando ci sono) toccano il rapporto fra trama e saggio — bilanciamento che alcuni lettori troveranno “più cerebrale che emotivo”, altri esattamente il contrario.
- Eco pop: Il lancio è finito anche sulla stampa generalista (People ha presentato il romanzo di McEwan fra i titoli-chiave d’autunno), segno che la sua narrativa “alta” continua a dialogare con un pubblico largo.
Le grandi domande
Che cosa resta conoscibile
Il titolo non è ironico: Quello che possiamo sapere delimita il raggio del nostro conoscere. McEwan lavora su tre soglie: ciò che è conoscibile in principio (esistono i documenti? sono leggibili?), ciò che è conosciuto di fatto (quali sono le versioni in competizione?) e ciò che vogliamo sapere (quale verità è socialmente tollerabile?). Il futuro di Metcalfe è un laboratorio moralmente preciso: un mondo più povero, più lento, più archivistico, dove ogni carta salvata ha il peso di una vita.
Verità, letteratura, responsabilità
Il romanzo, come spesso in McEwan, mette in scena il rapporto tra racconto e responsabilità. Espiazione interrogava il potere distruttivo di una narrazione sbagliata; qui la domanda è: chi ha il diritto di custodire (o occultare) la verità degli altri? L’amore, la malattia, la reputazione: ogni elemento intimo diventa “oggetto pubblico” quando entra in archivio. La lezione non è relativista: il libro non dice che “tutto è interpretazione”, ma che l’accesso alla verità è procedurale — ha tempi, strumenti, limiti.
Il clima come condizione narrativa
L’inondazione che seppellisce Oxford non è un effetto speciale: è l’infrastruttura del racconto. McEwan non compone un romanzo-clima nel senso stretto (non segue scienziati, policy o attivisti), ma usa il clima come condizione materiale della memoria: si legge diversamente in un mondo dove le biblioteche si spostano in montagna e la carta asciutta è un bene raro. È un’idea forte, quasi alla Ballard, ma filtrata da un’umanità dolente e concreta.
Come McEwan costruisce la tensione
Montaggio di indizi
La forma è quella del dossier: testimonianze, epistolari, ricostruzioni; il narratore orchestra i materiali con una progressione che ricorda i “procedurali lenti” del miglior McEwan. Ogni capitolo sposta di un millimetro la conoscenza, e la suspense nasce esattamente lì: nella microvariazione della luce su fatti noti.
Tempo doppio
Il romanzo alterna il presente di Metcalfe e il passato dei Blundy con una geometria regolare, ma non pedante. Il lettore è continuamente invitato a sovrapporre le due mappe: ciò che pensiamo di sapere del 2014 e ciò che possiamo sapere dal 2119, quando i testimoni sono morti e restano soltanto gli atti. In mezzo, l’ombra lunga del “Grande Disastro”, che deforma la prospettiva come una lente d’acqua.
Stile: la chiarezza che punge
La prosa è quella, inconfondibile, asciutta e musicale: frasi che non si mettono in posa ma accumulano pressione morale. The New Yorker ha parlato di “ipnosi”, e non è un’iperbole: McEwan non urla; affina. Il risultato è un realismo di precisione — a tratti chirurgico — in cui un aggettivo spostato cambia l’etica di una scena.
Confronti utili nel catalogo McEwan
Con “Espiazione” condivide il tema dell’errore interpretativo e dell’archivio come teatro morale; con “Lezioni” il desiderio di abbracciare archi lunghi, biografie che si incastrano nella Storia; con “Macchine come me” l’ipotesi controfattuale (qui proiettata in avanti); con “Solar” l’ossessione per le conseguenze non intenzionali delle nostre azioni collettive. E tuttavia “Quello che possiamo sapere” è un animale nuovo: meno satira, più elegia; meno allegoria, più storia nel senso storiografico.
Dove collocarlo nel panorama internazionale
L’uscita britannica (Jonathan Cape) e quella statunitense (Knopf) sono state accompagnate da interviste e anteprime a tappeto; il romanzo è entrato subito nelle liste dei “titoli caldi” di stagione. La critica più severa, specie negli USA, ha obiettato che l’intreccio “cede” talvolta al saggio; la critica più favorevole ha visto proprio in questo attrito la sua forza: un’opera che non risolve il mistero perché il mistero — la conoscibilità del reale — è la sua materia. La pagina di catalogo Knopf riassume bene l’arco delle letture, riportando giudizi dal New York Times e dagli altri maggiori quotidiani; la ricezione britannica (si veda The Guardian) insiste invece sulla naturalezza con cui McEwan torna al romanzo pieno dopo la lunga, autobiografica apertura di “Lezioni”.
L’edizione italiana
In Italia esce per Einaudi con il titolo “Quello che possiamo sapere”, traduzione di Susanna Basso (una collaborazione ormai storica nel catalogo McEwan). Le anticipazioni italiane hanno ripreso i tratti portanti del plot — la Coronaperduta, la Bodleian trasferita in Galles, l’ossessione di Metcalfe — confermando che l’edizione mantiene la struttura a “romanzo-archivio”. Per una ricognizione rapida delle opere dell’autore e della filiera italiana delle traduzioni, la voce aggiornata di Wikipedia (it) offre un quadro utile.
Perché leggerlo adesso
Perché parla del dopo senza il compiacimento della catastrofe; perché riconsegna alla letteratura un compito adulto: fare i conti con la conoscenza, non solo con l’emozione. Perché — come suggerisce l’AP — è un modo di leggere l’oggi “da un passo più in là”, quando ciò che oggi difendiamo come opinione è già diventato documento, e ciò che archiviamo o cancelliamo decide il profilo morale delle generazioni che verranno. “Gran parte del libro” vive nel 2119, ma il suo campo magnetico è qui, adesso.
Stampa
- “Science fiction without the science”: McEwan definisce così l’orizzonte del romanzo.
- The Guardian: ritorno “smagliante” al romanzo ad ampio respiro, dove le ossessioni etiche vengono “riportate in storia”.
- The New Yorker: “Un’ipnosi morale travestita da mystery; alla fine sappiamo di più, ma non abbastanza.”
- Knopf (rassegna): “Ambizioso, provocatorio, politicamente tagliente” (NYT/WaPo/WSJ/LA Times, estratti di catalogo).