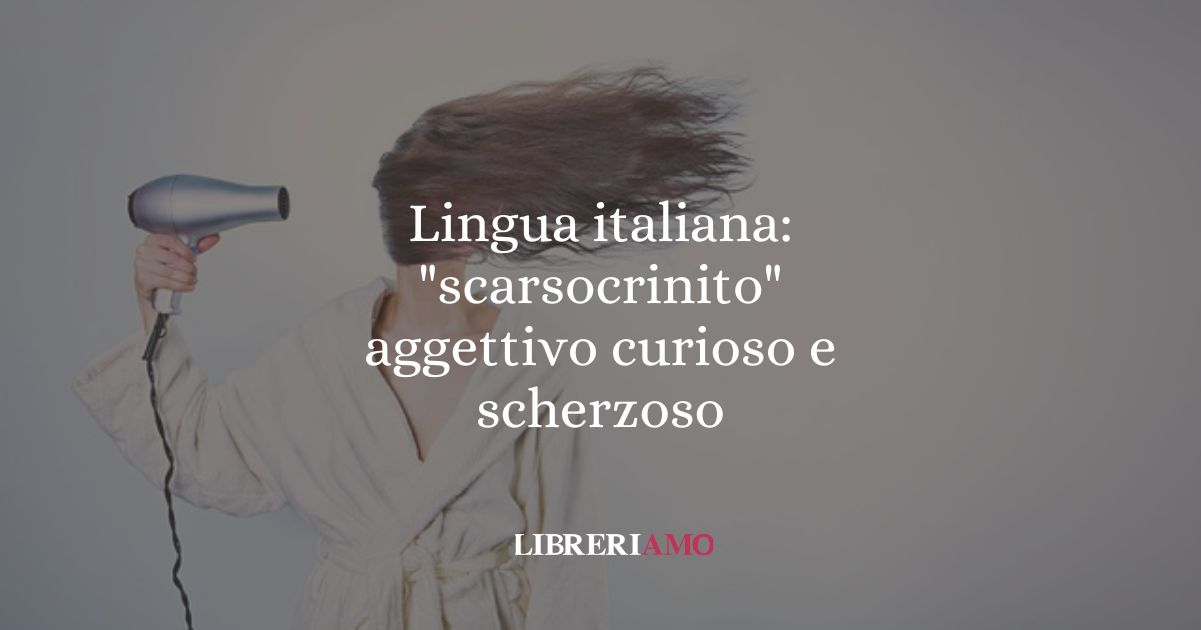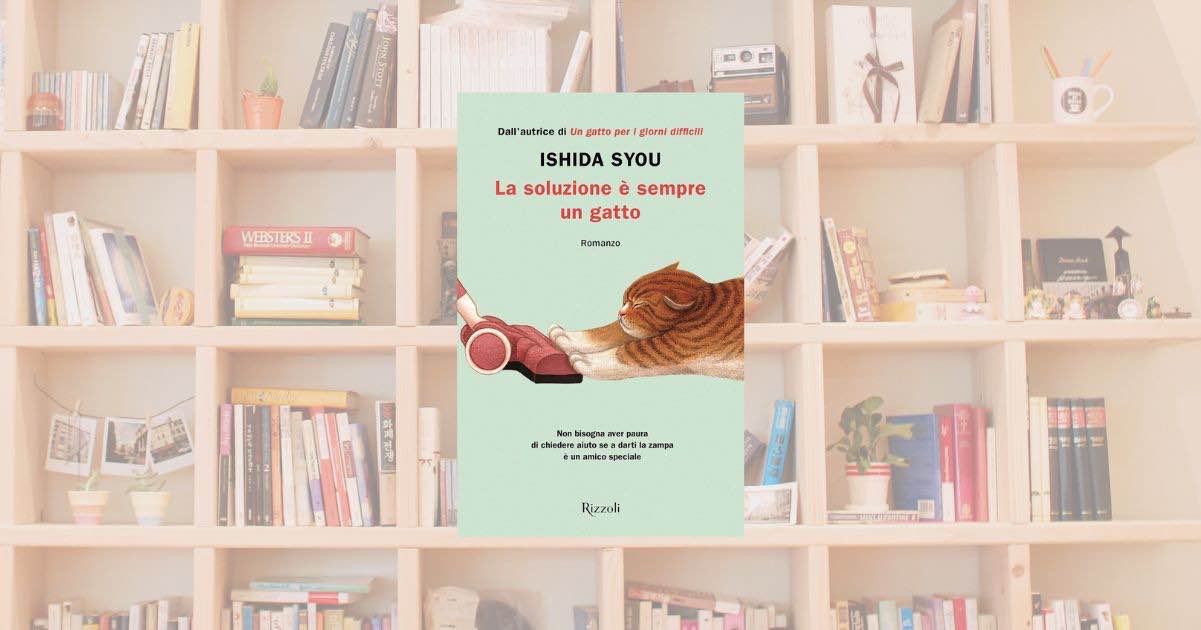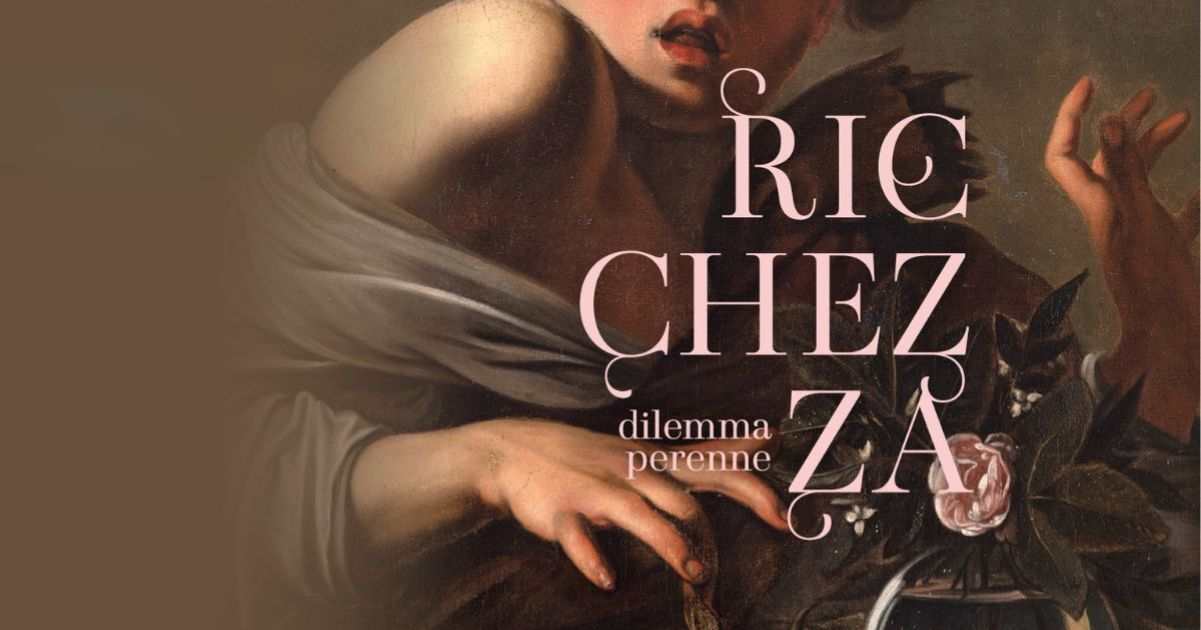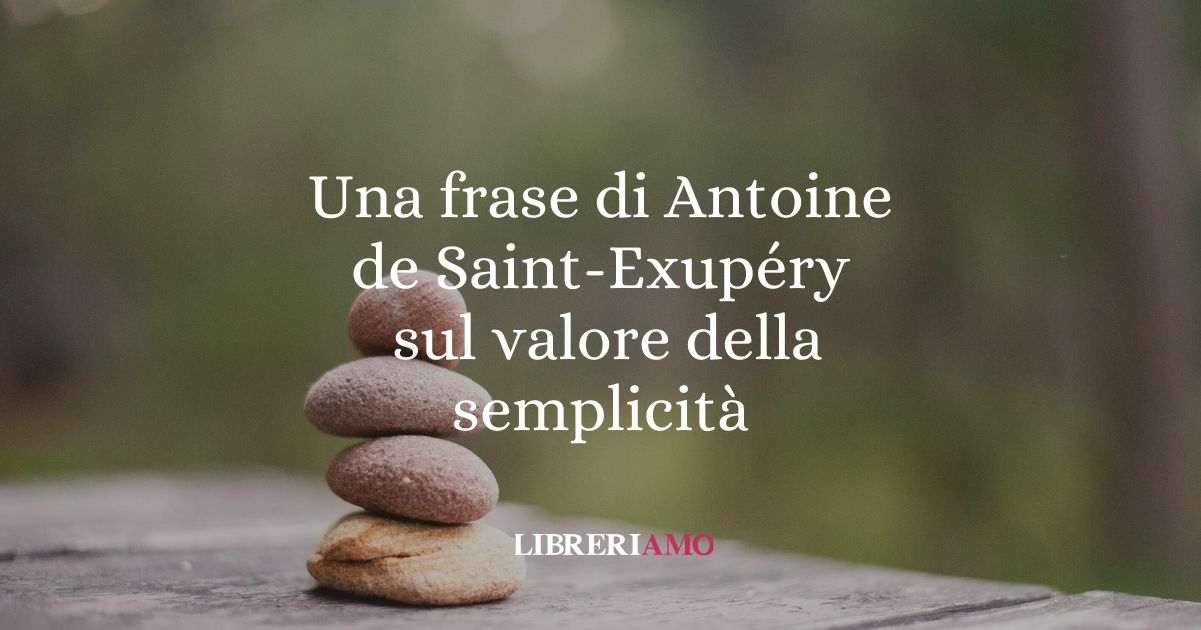Valeria Ancione, siciliana trapiantata altrove, ha esordito nella narrativa con il romanzo La dittatura dell’inverno (Mondadori 2015)
Valeria, a volte ai miei conterranei che come me abitano altrove chiedo com’è la Sicilia vista da lontano. Le va di rispondere?
Mi va sempre di parlare di Sicilia. La mia Sicilia è grande assenza, mancanza. Sono nata a Palermo, sono cresciuta a Messina, ho passato le estati della mia infanzia e qualche Natale di famiglia a Ragusa, dove mio padre lavorava con nonno, ecco, mi definisco molto siciliana. Andando via ho superato le rivalità cittadine, anche con i catanesi. Sono orgogliosa della mia provincia “babba”. Amo Messina dal profondo, fino alla commozione per quanto è bella e maltrattata, malridotta. Ho capito il senso della mia insularità quando sono andata via, quando ho toccato terra. E ho capito anche che non potevo vivere senza mare, quando non ce l’ho avuto più davanti agli occhi, perché Messina, più di ogni altra città siciliana, ovunque giri lo sguardo, il mare non te lo nega mai. E ahimé, ho capito anche che essere siciliano per gli altri sia sinonimo di mafioso, siamo mafiosi dentro e questo mi ha fatto male e mi ha fatto sentire sola. Però forse Falcone e Borsellino, miti moderni che appartengono a tutti, hanno cancellato con il loro impegno e il loro sacrificio, la distanza e soprattutto l’idea che la mafia sia solo affar nostro. Ecco, la mia Sicilia da lontano mi appartiene più che mai, ed è il punto a cui tendo.
Parliamo del suo esordio letterario. So che non si arriva alla pubblicazione con un sol balzo (dal manoscritto − e prima ancora dall’idea che poi è diventata parola scritta − al libro stampato). Le va di raccontare il suo percorso personale?
Ho iniziato il romanzo all’inizio del 2011. Avevo bisogno di scrivere, bisogno fisico. L’estate precedente avevo messo giù cose confuse. Poi ho pensato alla storia che volevo raccontare e mi sono seduta un po’ disordinatamente a scrivanie diverse, computer diversi, momenti diversi. Intanto la storia cresceva, mi coinvolgeva, mi chiamava e mi obbligava a trascriverla. Tanto che rispetto all’idea iniziale il racconto è mutato quasi da solo, io sono stata spettatrice e testimone: così mi sono sentita a un certo punto della scrittura. Ho terminato l’8 giugno del 2012. Quella era la data ultima, perché finiva la scuola e mi sarei ritrovata i ragazzi a casa, impossibile lavorare ancora. Lo scritto allora è passato al vaglio di una giuria casalinga per capire se si trattasse di un romanzo, se avesse un senso, un percorso. Quindi ho iniziato a chiedere come fare per la pubblicazione, senza grandi illusioni. La risposta più frequente è stata “scrivono tutti”. La più divertente “ti posso dare un consiglio? Scrivi roba per ragazzi, tipo fantasy”. Sono andata da chi mi aveva detto “quando finisci di scrivere dimmelo che ho amici, conosco gente, l’editore è mio fratello…” Sono scomparsi tutti. Ho inviato il romanzo a qualche casa editrice, non mi ha risposto nessuno. Nemmeno un “le faremo sapere o un no grazie non prendiamo titoli per quest’anno”. Poi l’ho affidato a un agente. Era novembre. E il 4 marzo 2013 mi ha chiamato Mondadori, ma mi sono dovuta mettere in coda ed è stato pubblicato il 20 gennaio scorso anche se stava per uscire nel 2014.
Nina, la protagonista del suo libro, ha quarant’anni, un marito, una casa a Roma e una a Ventotene, cinque figli, due gatti, tre corteggiatori più o meno intraprendenti identificati per professione e qualifica (il professore, il direttore, il dottorino), un’amica speciale, anzi un’amante, Eva, tre librerie da seguire, una delle quali con sala da tè. Nessuna amica del cuore, ci sono due figure femminili molto materne, la tata Olivia e la signora Flora, ma amiche no. Come mai? Certo, in una vita straripante di impegni e doveri, in cui Nina sanamente inserisce a forza qualche minuscola oasi per sé (la piscina, Eva, magari non in ordine di importanza), le chiacchiere con le amiche non sono proprio contemplabili. Ma forse la ragione è diversa e più sottile, più legata a un’idea del rapporto fra donne che io non so indovinare e che mi incuriosisce.
Complimenti, il riassunto è perfetto. È vero, non ci sono momenti di chiacchiere con le amiche, forse perché Nina non ne ha il tempo o forse perché io non avevo lo spazio per scrivere tutta la vita di Nina. Mi dà l’occasione per spiegare che La dittatura dell’inverno è il racconto di due inverni, due anni circa in cui tutto si sospende, né del prima né del poi, non è la vita di Nina. Eva è il suo mondo a parte e Nina vuole che quel mondo sia solo suo e di Eva, che è il suo segreto, la sua fuga, la stanza tutta per sé. C’è un momento in cui però, durante un picnic alla Villa, le amiche ci sono e si capisce l’intimità che le lega, la condivisione di tutto. Una di loro, con un filo di gelosia, chiama Eva “l’amichetta”, la conoscono, sanno che Nina prova un affetto speciale per lei ma non la frequentano. Forse Nina le evita proprio per non essere scoperta nella sua distrazione. Un’amica vede tutto. Nina però ha un rapporto speciale con le donne e si capisce in molti passaggi, brevi ma decisivi. Dice: «Non era la prima fidanzata che entrava in casa». Questo vuol dire che vive i rapporti di amicizia con le donne in modo intenso e passionale. E credo che le figure femminili del romanzo, da Olivia a Flora, dalla madre ad Amalia, per quanto appena tratteggiate, abbiano un peso rilevante. Per me è importante che si “notino”, che emerga un racconto lieve ma incisivo di certe donne. Che ovviamente esistono e si manifestano perché girano attorno a Nina, e che non avrei potuto approfondire né raccontare di più sennò avrei finito con lo scrivere Guerra e Pace.
L’inverno e l’estate, nel suo libro, rappresentano dittatura e libertà. Ma è dall’esterno che vengono le restrizioni alle emozioni? Non è dentro di noi la chiave che ci fa chiudere o aprire la porta alla passione, al cambiamento?
L’inverno priva Nina della luce, la costringe a coprirsi per il freddo, a inseguire il tempo che corre appreso a mille cose, mille impegni dei figli, richieste da soddisfare. Vive la vita per gli altri. La libertà dell’estate coincide con la libertà dei suoi ragazzi, la loro autonomia. Il tempo non ha limiti di tempo, non batte il tempo… Le emozioni però non hanno una stagione. Nina è investita da un’emozione dirompente quando è presa da tutte le cose che la fanno sentire imbrigliata nei ruoli, nel dovere di essere come gli altri la vedono. Eva è la leggerezza, come l’estate, non si aspetta niente, non chiede, prende quello che viene. E questo libera Nina dalle catene. E proprio sì, le restrizioni a vivere un’emozione vengono dai condizionamenti esterni, dalla cultura, dall’educazione, da certa morale, dagli impegni, ma certo è dentro di noi la chiave. Nina con timidezza la usa per entrare e uscire da un condominio nuovo. Alla fine non cambia se stessa, ma aggiunge qualcosa di straordinario alla sua esistenza. Un amore unico, che non si sostituisce agli altri amori, per i figli per esempio, ma la spoglia di tutto e si vede, in quello “specchio benevolo” che è Eva lei inizia a guardarsi e scoprire di essere altro, oltre.
E parliamo di Eva. Giovinezza, innocenza, generosità nel darsi, ma anche incomprensione della difficoltà per Nina di essere libera come lei. Nina spesso pensa a Eva come a una persona molto giovane, “piccola”. E, in una breve considerazione della protagonista sul dottorino, il più timido e discreto dei suoi corteggiatori, sembra di cogliere un rifiuto di comprendere il modo dei trentenni di stare al mondo. E lei cosa pensa dei rapporti fra generazioni diverse, della possibilità di dialogare e comprendersi al di là della barriera di qualche decennio?
Ho sentito dire che Nina è una donna di mezza età. Di mezza età a 40 anni??? E no, se i trentenni oggi sono giovani, a 40 anni non si può essere di mezza età! In generale penso che la distanza è dovuta più alle esperienze che si fanno che alla differenza di età. Il dialogo tra diverse generazioni è complicato. Quello con i figli poi… Gli adulti hanno sempre la pretesa di insegnare qualcosa e questo crea distanza. O la convinzione di fare o aver fatto meglio delle nuove generazioni e questo determina incomunicabilità. Ho voluto toccare anche questo tema dello scontro generazionale madre-figlia, Nina-Benedetta. La contaminazione che c’è oggi mi inquieta e mi affanna anche un po’: gli adulti fanno le stesse cose che fanno i ragazzi (per esempio l’uso di Facebook, il cellulare sempre in mano, Whatsapp, le unghie colorate) e non va bene. Siamo troppo diversi per essere uguali. Ma non è colpa di nessuno, viviamo quest’epoca e la maneggiamo senza cura. Tutto si mischia e si confonde, non si vedono più i confini e questo non avvicina, è solo un’illusione, in casa si parla sempre meno. Io non voglio essere “coetanea” dei miei figli, né voglio esserne una spia. Quando sento dire di genitori che hanno Facebook per controllare i figli inorridisco. Per il resto invece, ho qualche perplessità sulle relazioni dove la differenza di età è grande. Perché è incolmabile il cammino che uno ha fatto rispetto all’altro. Nel caso di Nina la lotta è tra la tenerezza che prova per Eva, piccolissima Eva, e il desiderio anche fisico di stare con lei. Ma Eva è bambina e donna e Nina spesso si lascia andare e diventa lei la più piccola, si fa accudire, coccolare, aiutare ma altrettanto spesso questo la mette a disagio perché si sente di sfruttare l’entusiasmo della ragazza che per lei farebbe tutto. Eva è affascinata da Nina, vuole essere come lei, perché le piace, vuole le sue rughe e i suoi capelli bianchi per annullare la differenza, ma vuole essere uguale essenzialmente perché per lei Nina è bella in ogni cosa che fa, in quello che pensa, nei suoi affanni e anche nel suo modo di amarla. È innamorata e anche ammirata. Nina d’altro canto vorrebbe essere Eva. Insomma, alla fine queste due donne sono una cosa unica, ognuna la proiezione di sé nell’altra. In generale però quando c’è una differenza importante in una coppia, ci si comprende certo, ma penso che si resti sempre distanti e che inevitabilmente i ruoli siano ancora più definiti. Non dico che non funzioni un rapporto di coppia, ma ha dei limiti.
Lei, Valeria, è una giornalista, scrive per il Corriere dello Sport. Io ho una teoria che mi piace ogni tanto verificare, e cioè che chi scrive per professione spesso finisce per aver voglia di cimentarsi con la narrativa, come se fosse uno sviluppo naturale, oppure come se a un certo punto si sentisse il bisogno di evadere dalle regole della scrittura professionale (di giornalista, pubblicitario, traduttore, giusto per fare alcuni esempi) e di cambiare stile, tono, metodo… Lei che ne pensa?
Io ho fatto la giornalista perché a vent’anni non ho avuto il coraggio di dire a mio padre che volevo fare la scrittrice. Così ho scelto un lavoro dove si scriveva. Un surrogato, lo chiamo. In realtà non ho scritto moltissimo nella mia carriera, non avendo fatto la cronista. Quindi il desiderio o il sogno sono rimasti intatti se non frustrati dalla consapevolezza di aver scelto un ripiego. Certo, scrivere un romanzo è stato però come liberarsi delle regole, delle 5 w, del limite delle righe che ora sono diventate battute, e dar sfogo alla fantasia. Il mio libro è finzione e in ogni personaggio io mi fingo. Il giornalismo dovrebbe essere invece racconto dei fatti e della verità. La mia scrittura però è la stessa e credo che 25 anni di giornalismo siano stati anche un’ottima palestra.
Scriverà (o sta già scrivendo) altre opere di narrativa?
Il secondo romanzo l’ho terminato e consegnato all’editore. D’altra parte, La dittatura dell’inverno l’ho terminato nel 2012, non potevo stare con le mani in mano ad aspettare. Come non riuscirò ad aspettare ancora. Ho tante cose da raccontare e tutte nascono quasi dalla fine: il titolo, che poi non è che l’inizio di una nuova storia.
Grazie, Valeria, per il suo tempo e le sue risposte.
Ogni intervista genera una riflessione e rende vivi i miei personaggi, quindi grazie a lei.
Rosalia Messina
4 luglio 2015
© RIPRODUZIONE RISERVATA