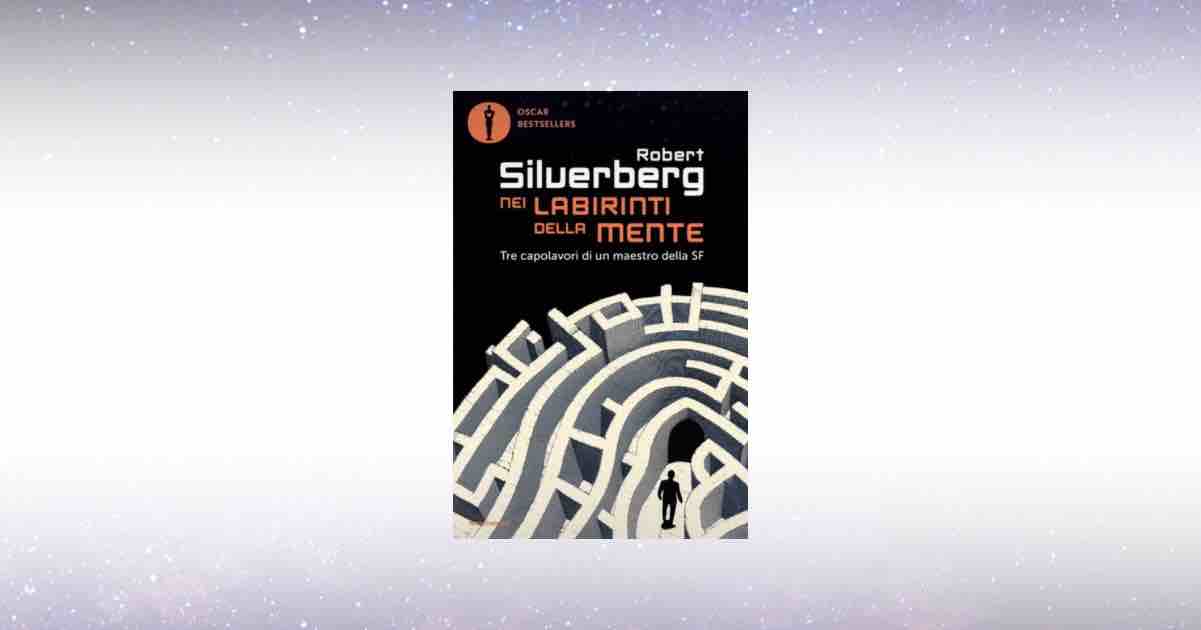Questa edizione riunisce “L’uomo nel labirinto” (“The Man in the Maze”, 1969), “Morire dentro” (“Dying Inside”, 1972) e “Il tempo delle metamorfosi” (“A Time of Changes”, 1971) sotto il titolo “Nei labirinti della mente”: un’opera concentrata del periodo più fertile di Robert Silverberg.
Perché “Nei labirinti della mente” è importante
Grazie a questa edizione scopriamo la New Wave, quella corrente che sfonda il muro della fantascienza e va oltre, smettendo di essere soprattutto gadget ed espansione coloniale per diventare indagine psicologica ed etica.
L’asse attorno la quale rotea l’intera indagine di Robert Silverberg non è l’astronave, tipico fulcro della fantascienza iniziale, bensì la coscienza; e lo conferma lo stesso autore in un’intervista di bilancio:
“Ero stanco dei vecchi trope; volevo i conflitti interiori» (Los Angeles Review of Books).
Ne esce così un trittico coerente: l’esilio dell’io, il dono che si spegne, la società che proibisce l’identità. È letteratura di frizione, ma ancora leggibilissima per chiunque, fatta di un linguaggio terso, con una struttura chiara e l’ambizione da romanzo “serio”.
Non a caso, “Il tempo delle metamorfosi” vinse il Nebula Award; e “Morire dentro” rimane per molti il capolavoro “letterario” di Silverberg.
“L’uomo nel labirinto”: l’empatia come condanna
Trama e nucleo tematico
Dopo un contatto alieno, un diplomatico interstellare di nome Dick Muller diventa intollerabile per gli altri esseri umani: una sorta di “emanazione psichica” si proietta addosso a chi lo incontra e la verità delle proprie bassezze — tra paure e colpe di varia natura — lo rende insopportabile. Muller decide così di auto-esiliarsi nella città-labirinto di Lemno, opera di una specie estinta, e diventa “l’orco” del suo stesso mito.
Tuttavia, anni dopo, il governo ha bisogno di lui per negoziare con una nuova razza aliena. Muller, però, è sospettoso: teme che lo stiano solo usando per uno scopo politico, e sa che non potrà mai reintegrarsi in un mondo che lo respinge.
È così che il labirinto esterno, nell’opera, riflette il labirinto interiore di Muller.
Come leggerlo
Il libro sembra parlare del post-trauma: chi ha visto “troppo” non può più vivere tra i suoi simili. L’idea della “puzza esistenziale”, spesso sintetizzata così dai lettori anglofoni, è centrale nelle discussioni critiche del romanzo.
Silverberg sposta l’orrore dal corpo alla mente: non è Gregor Samsa che “puzza” di insetto; è la coscienza a risultare insopportabile. Riletture recenti insistono sul carattere psicologico e “a basso tasso d’azione”: la posta è morale, non spettacolare.
In Kafka: la “puzza” come traccia del vivente, come colpa incarnata
Kafka non usa mai esattamente l’espressione “puzza esistenziale”, ma l’idea è già nel suo universo — specialmente ne “La metamorfosi” e ne “Il processo”.
Ne “La metamorfosi”, Gregor Samsa, trasformato in insetto, comincia a emanare un odore nauseante che costringe la famiglia a evitare la sua stanza. Quell’odore non è solo fisico: è il segno visibile (anzi, olfattivo) della colpa ontologica, della disumanizzazione che lo separa dagli altri.
Per Kafka, la “puzza” è la traccia del corpo come prigione, dell’essere che non riesce più a nascondere la propria verità.
L’uomo — o l’insetto, o l’impiegato — puzza perché esiste, perché è imperfetto, impuro, fallato.
Ma in Silverberg, la puzza è un modo per dire che la “condizione umana” non è mai neutra, che lascia sempre dietro di sé un residuo, un odore, una vergogna. Silverberg prende quella intuizione kafkiana e la rovescia nel linguaggio della fantascienza psicologica.
Nel suo caso, la “puzza esistenziale” non è più l’odore della colpa individuale, ma una frequenza mentale collettiva: un’emanazione psichica che mette a nudo la verità morale di tutti.
Dove Kafka parla di disgusto per la carne, Silverberg parla di disgusto per la consapevolezza.
In entrambi i casi, però, il risultato è lo stesso: l’emarginazione del soggetto che “puzza”, cioè che rivela qualcosa che gli altri non vogliono sentire.
L’inetto oltre l’umano: da Kafka a Silverberg
È l’inetto del primo Novecento — quello di Kafka, di Svevo, di Musil — è un uomo intrappolato nella propria coscienza di fallire.
Non è stupido né malvagio: è semplicemente troppo lucido per funzionare nel mondo. Gregor Samsa, Zeno Cosini, Ulrich non mancano di intelligenza: mancano di adattamento.
Vivono in un sistema che pretende efficienza e coerenza, ma la loro mente — ipersensibile, analitica, ansiosa — li condanna a una forma di paralisi. Con Robert Silverberg, la figura dell’inetto subisce una mutazione fantascientifica. Non è più il burocrate o il piccolo borghese che non riesce a trovare posto nella società; è l’essere potenziato — il telepate, l’esploratore, il conoscitore — che non riesce più a restare umano.
L’inetto kafkiano soffriva di inadeguatezza; l’inetto silverberghiano soffre di eccesso. Dick Muller, David Selig, Kinnall Darival sono tutti uomini “aumentati”, ma incapaci di convivere con le proprie capacità.
Il dono che li distingue li separa
Come Gregor Samsa, diventano mostri morali: non perché abbiano commesso un peccato, ma perché mostrano — troppo — ciò che siamo.
Dal fallimento borghese alla malattia della coscienza
Silverberg spinge alle estreme conseguenze ciò che Kafka aveva solo intuito: la vera malattia dell’uomo moderno è l’auto-consapevolezza.
Nei suoi romanzi, la mente non è più rifugio ma prigione, un labirinto in cui ogni pensiero rimanda a un altro, fino al collasso.
L’inetto novecentesco si vergognava del proprio corpo; l’inetto di Silverberg si vergogna della propria mente.
Se Kafka aveva fatto dell’angoscia una stanza, Silverberg la trasforma in un pianeta. Così la fantascienza diventa la nuova letteratura dell’inettitudine: non più confinata alla psicanalisi o alla morale, ma proiettata nell’universo.
Ogni telepate, ogni essere “evoluto”, ogni alienato di Silverberg è un uomo che ha perduto la grazia dell’inconsapevolezza — e proprio per questo non può più vivere tra i suoi simili.
L’inetto come profeta
In questa prospettiva, la “puzza esistenziale” è la nuova veste dell’antico destino di chi vede troppo: l’inetto diventa profeta indesiderato.
Non riesce a integrarsi, ma nemmeno a smettere di comprendere.
È il martire dell’intelligenza, l’uomo che paga il prezzo del pensiero.
Kafka lo condannava alla metamorfosi, Svevo alla psicanalisi, Silverberg lo rinchiude in un labirinto. Ma l’esito è lo stesso: la solitudine come ultima forma di lucidità.
“Morire dentro”: telepatia e lutto dell’identità
Trama e stile
David Selig, newyorkese di mezz’età, è un telepate che ha campato vendendo tesine agli studenti della Columbia. Ma il dono svanisce: a ondate, poi sempre più a lungo. Il romanzo è composto come un mosaico di flashback e confessioni; la prosa è volutamente “nuda”, scavata, spesso ironica contro se stessa.
Molti critici lo leggono come romanzo del middle age travestito da SF: perdere il potere significa perdere il sé.
L.A. Times, Fantasyliterature, e letture aggregate che lo definiscono il suo libro più “serio”.
Ricezione estera
Nel 2009 il Los Angeles Times ricorda la definizione — passata dal dibattito critico americano — di Dying Inside come “il romanzo perfetto di fantascienza per chi non ama la fantascienza”, e riporta la stima di Michael Chabon (“dazzling and tender”). Non è un best-seller di massa; è un classico “di culto”.
“Il tempo delle metamorfosi”: quando l’Io è un peccato
Trama e chiave etica
Sul pianeta Borthan, la religione dominante vieta l’uso dei pronomi personali e punisce ogni manifestazione esplicita dell’identità. Kinnall Darival, aristocratico, scopre attraverso una sostanza psicotropa (e l’incontro con un “forestiero”) una forma di rivelazione dell’Io che diventa eresia: confessione pubblica, rivoluzione privata.
L’Encyclopedia of SF sintetizza: “una società in cui il sé è peccato”; un romanzo che usa linguaggio e tabù come ingegneria sociale. Premio Nebula 1972.
Perché conta
È il più “teorico” dei tre: un laboratorio su linguaggio e coscienza (anticipa sensibilità da Le Guin a Atwood). È anche il più politico: mostra che il controllo dell’Io passa dalle parole.
Cosa scrive la stampa estera
- Los Angeles Review of Books: conversazione-bilancio in cui Silverberg rivendica la svolta interiore della sua SF tra fine ’60 e inizio ’70 — meno “battaglie spaziali”, più conflitti della mente. Utile come cornice d’autore.
- Los Angeles Times (Festival of Books / profilo): Dying Inside come classico “letterario” della SF, amato da scrittori mainstream e spesso consigliato a chi non legge il genere.
- Encyclopedia of Science Fiction: voci autorevoli su Silverberg e su A Time of Changes (“società dove l’Io è peccato”). Base di riferimento critica.
- FantasyLiterature: letture aggiornate che chiamano Dying Inside “beautifully written” e A Time of Changes “superb”, ricordando il Nebula (utile come specchio della ricezione “di lungo corso”).
- Worlds Without End (community con rassegna di premi/riassunti): The Man in the Maze descritto proprio con l’espressione “foul stench” mentale che isola Muller.
Dal fallimento privato alla malattia della coscienza
Nei tre romanzi raccolti (Muller nel labirinto; Selig in “Morire dentro”; Darival nel mondo proibizionista di Il tempo delle metamorfosi) la mente è un labirinto attivo: il dono isola, la lucidità brucia, la conoscenza diventa condanna sociale.
La fantascienza di Silverberg porta la tradizione dell’inetto “fuori stanza” e la proietta su scala cosmica: dalla nevrosi al destino, dalla psicanalisi all’esilio.
Da Zeno Cosini a Dick Muller: la coscienza come condanna
Zeno Cosini, con il suo sorriso ironico e la sua eterna autoanalisi, è l’antenato letterario dei personaggi di Robert Silverberg.
L’uomo che pensa troppo, che osserva se stesso fino a immobilizzarsi, è lo stesso che, un secolo dopo, non potrà più convivere con il peso della propria empatia.
La “malattia dell’anima” di Svevo diventa in Silverberg una “patologia dell’empatia”: Zeno non riesce a sopportare la propria coscienza, Muller non riesce a sopportare quella del mondo.
Entrambi scelgono l’esilio: Zeno dentro la propria mente, Muller nel suo labirinto. In entrambi, l’unica guarigione possibile è l’ironia — o la solitudine. Svevo aveva previsto la modernità dei nevrotici; Silverberg, quella dei telepati. Il risultato non cambia: conoscere troppo significa non poter più vivere normalmente.
Dall’ironia di Svevo alla vertigine della New Wave
La figura dell’inetto attraversa il Novecento come un sismografo della coscienza. Con Italo Svevo, è il borghese che scopre di essere troppo lucido per funzionare: Zeno Cosini vive di analisi, di differimento, di fumo come atto di procrastinazione.
Con Kafka, la lucidità diventa disgusto: l’uomo scopre di puzzare di sé stesso. E con Robert Silverberg, nell’età della New Wave, quella stessa lucidità si trasforma in potere mentale, ma anche in maledizione morale.
La New Wave degli anni Sessanta e Settanta — da Ballard a Le Guin, da Disch a Silverberg — prende l’inetto sveviano e lo proietta nello spazio interiore della fantascienza, dove il conflitto non è più con la società, ma con la coscienza espansa. Il laboratorio, la telepatia, il viaggio interstellare diventano nuove forme del sintomo. L’analisi psicologica si fa cosmologia: l’uomo non si limita più a osservare sé stesso, ma osserva l’universo come proiezione della propria mente malata.
Svevo aveva chiuso il secolo dell’ironia; la New Wave apre quello della vertigine. In entrambi i casi, l’eroe non è il vincente ma il consapevole — colui che sa troppo per poter ancora vivere serenamente. Nel passaggio da Trieste a Borthan, da Zeno a Muller, la letteratura scopre che la vera avventura non è attraversare lo spazio, ma sopravvivere alla coscienza. E così l’inetto, da nevrotico borghese, diventa profeta dell’intelligenza contemporanea: colui che continua a cercare un modo dignitoso di abitare l’inquietudine.