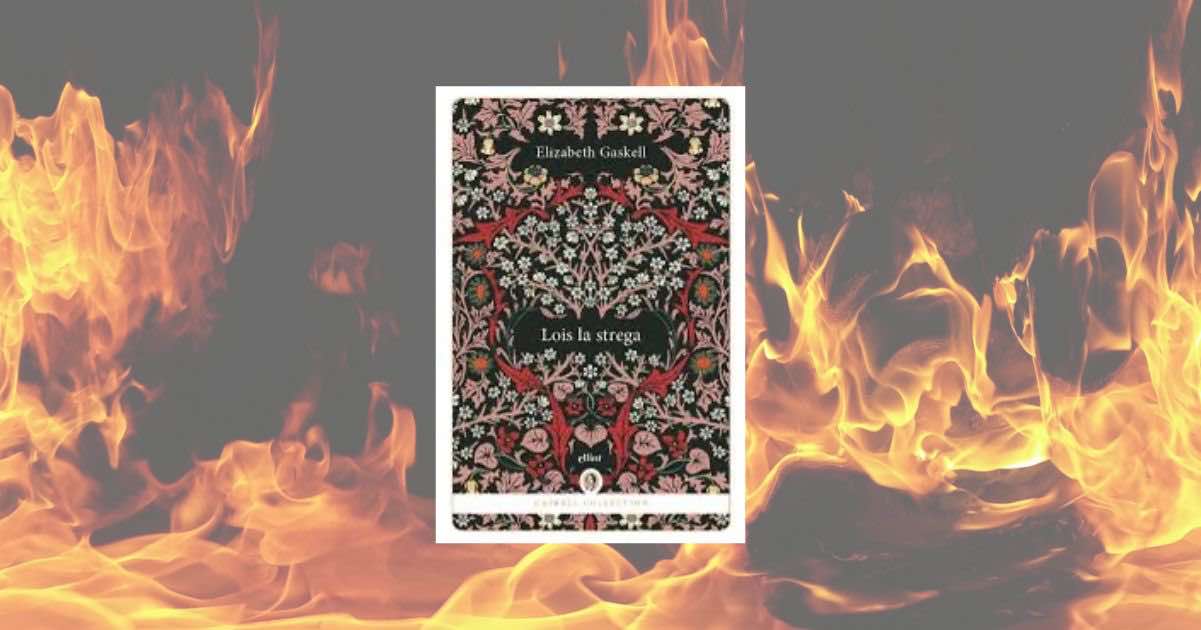Perfetto per la spooky season, “Lois la strega” è un classico a tinte gotiche pubblicato in tre puntate nell’ottobre 1859 sulla rivista di Charles Dickens, “All the Year Round”, e poi in volume con il titolo “Lois the Witch and Other Tales” nel 1861.
L’autrice, Elizabeth Gaskell, con quest’opera si è resa una “narratrice sociale” capace di piegare il gotico a un’indagine morale e storica di rara precisione, delineato un ritratto impietoso della sua comunità, schiacciata da paura e dogma religioso, il quale è facilmente portato a costituire un capro espiatorio in nome della “giustizia”.
Ma di cosa parla “Lois la strega”
Ci troviamo alla fine del ‘600, quando Lois Barclay rimane orfana e lascia l’Inghilterra per raggiungere il New England, dove l’aspettano gli zii, ahi-lei puritani…
È così che arriva a Salem, un posto in cui il sospetto è legge non scritta, e mette piede in una casa lacerata da gelosia, rancore e risentimento.
Lois, onesta e devota, ingenuamente fiduciosa, diventa un bersaglio facile. Basta poco: un fraintendimento, una “prova” inventata, un livido esibito ad arte. Nell’aria si addensa lo stesso clima che, nella Storia americana, porterà a 19 impiccagioni, una morte per tortura e incarcerazioni di massa (1692–1693).
Gaskell non cerca colpi di scena: costruisce passo dopo passo la logica del sospetto che travolge Lois, fino alla condanna.
Che cosa furono i processi di Salem
Nel 1692, tra Salem Village e i centri circostanti, denunce, “test” superstiziosi e testimonianze visionarie alimentarono una persecuzione che oggi leggiamo come emblema della caccia alle streghe. Non bruciarono persone al rogo nel Massachusetts (quella è una leggenda tenace): gli accusati furono impiccati; Giles Corey morì “pressato” sotto i pesi per essersi rifiutato di deporre; nel 1697 la corte proclamò un giorno di digiuno e penitenza; l’esonero ufficiale degli ultimi condannati arriverà solo nel 2001. La ricostruzione di Britannica resta la più agile per dati e sequenza.
Perché Gaskell sceglie Salem
Gaskell — che nel canone conosciamo per il realismo sociale — usa qui il gotico storico per mostrare meccanismi collettivi: come nasce un’accusa, come circola la diceria, come l’autorità religiosa convalida la paura.
Nel suo gotico non ci sono manieri e spettri: c’è la casa come primo tribunale, la parola come arma, il corpo femminile come scena del crimine.
Studi e schede critiche ribadiscono la centralità di questo testo nel filone “nero” di Gaskell (insieme a “The Old Nurse’s Story”, “The Grey Woman”), e ne collocano con nettezza la prima pubblicazione nel 1859 per Dickens.
Superstizione, patriarcato e desiderio di punire
Il racconto mostra come nasca un’isteria collettiva: l’accusa di stregoneria, più che un gesto di paura, diventa un linguaggio condiviso per normalizzare tensioni, desideri repressi e rancori personali. Il villaggio trova così un modo “accettabile” per dare forma alle proprie ossessioni, e Lois diventa il recipiente di quelle colpe che tutti vorrebbero espellere da sé. La sua condanna, prima ancora che religiosa o politica, è sociale e psicologica: è la vittima perfetta di una comunità che ha bisogno di purificarsi a scapito di qualcuno.
Come nella Salem reale del Seicento, dove la maggior parte degli accusati furono donne, anche nella novella di Gaskell il femminile è posto sotto giudizio. Il corpo di Lois, i suoi gesti quotidiani, persino il suo silenzio diventano “prove” da interpretare e distorcere. La scrittrice rivela così quanto la persecuzione sia un dispositivo di controllo morale: ciò che non si comprende, o che si teme, va represso. In questo modo, la condizione della donna si intreccia al tema più ampio dell’identità negata, di chi è spogliato del diritto di difendersi o di esistere fuori dalle regole.
Ma Gaskell non attacca la fede in sé, bensì il fanatismo che la corrompe. La religione, nel suo racconto, è un’arma a doppio taglio: può essere conforto o strumento di dominio. Quando la Scrittura diventa prova e l’autorità si trasforma in persecuzione, il sacro smette di liberare e inizia a punire. È in questo punto che il romanzo assume il suo significato più universale: la paura del male genera sempre altro male, e la fede, se non accompagnata da compassione, diventa solo un altro nome per il potere.
L’assedio domestico
La forza del racconto è nella camera chiusa familiare: zii, cugine, vicini, ministri di culto – ciascuno, nel microcosmo di Salem, è giudice e pubblico.
Una figura come Prudence, la cugina più giovane, incarna la malizia che diventa dottrina: basta un graffio, un livido, un capriccio e la macchina dell’accusa si mette in moto — “Witch Lois!” —, schiacciando ogni smentita.
Il passo “freddo” che fa male
Gaskell scrive senza enfasi. Sceglie il ritmo del resoconto: gesti minuti, sguardi, piccoli spostamenti. Questo “freddo” è deliberato: lascia al lettore la responsabilità morale della conclusione: un tratto che le edizioni moderne hanno messo in luce.
Ricezione e riscoperta
Nel Novecento e oltre, antologie e collane tascabili hanno riportato il libro nelle mani del grande pubblico; il testo è spesso incluso in raccolte come “Curious, if True. Strange Tales”, facilmente consultabili in digitale. Il mondo accademico continua a interrogarlo come studio di isteria sociale e politica del corpo femminile.
L’isteria collettiva vista come “altro”
“Lois la strega” ci mostra l’isteria di ieri, ma il corpo delle donne è messo alla gogna anche oggi. Prendiamo ad esempio “l’insegnante di Onlyfans”, la tempesta digitale che ha ricevuto, la gogna social di tutte quelle donne che sono state condivise sui social nei gruppi “Mia moglie”.
Allora bastava una parola sussurrata per scatenare la condanna, ma oggi basta un clic per dare il via all’orda di commenti: una foto condivisa senza consenso, l’orda barbarica che si scatena…
Il principio è lo stesso: trasformare una donna in simbolo del peccato per purificare la rabbia o la frustrazione altrui.
Le “streghe” del XXI secolo non vengono più portate al rogo, ma bruciate pubblicamente online: con le foto rubate, i commenti sessisti, le dicerie amplificate dal web, le campagne di odio.
Nel Seicento, la comunità di Salem aveva bisogno di identificare un capro espiatorio per placare le proprie paure; oggi, la rete diventa il nuovo villaggio, e il “falò”, le torture, sono mediatiche.
La dinamica del revenge porn — la diffusione non consensuale di immagini intime — nasce dallo stesso impulso che muoveva le accuse di stregoneria: punire la libertà femminile, controllare il corpo e la reputazione di chi sfugge alle regole patriarcali.
In entrambi i casi, l’accusa non riguarda ciò che è vero, ma ciò che serve al gruppo per mantenere il potere.
Ecco perché Gaskell è così moderna. Ogni volta che una comunità — reale o virtuale — si unisce per distruggere una donna in nome della sua “morale”, non stiamo vedendo il progresso, ma l’eco di Salem che ancora ci abita.