Arriva in Italia il nuovo libro di Polly Clark: “Oceano”, un viaggio nel mare del dolore e della rinascita
Un romanzo viscerale sul mare, l’amore e la perdita: “Oceano” di Polly Clark esplora i legami umani come tempeste interiori da attraversare per rinascere.
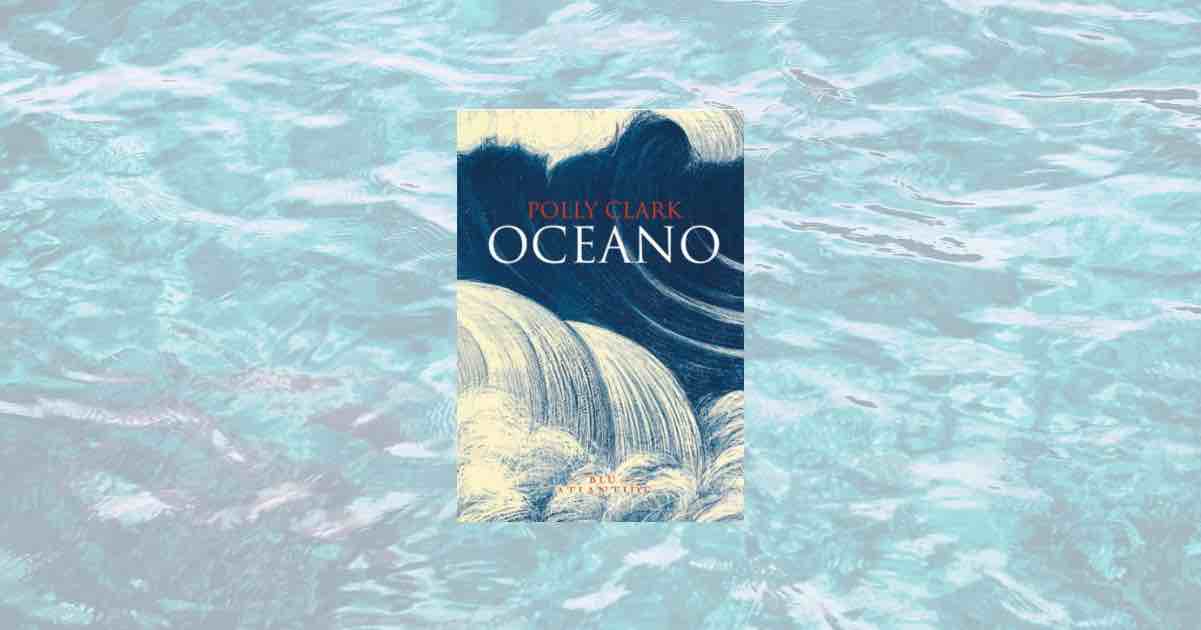
Blu Atlantide porta in Italia “Oceano” di Polly Clark, tradotto da Francesca Bigotti, un romanzo ampio, sensuale e perturbante, che unisce il respiro dell’epica marina all’intimità dei legami familiari.
Ambientato tra Londra e l’Atlantico del Nord, “Oceano” segue Helen e Frank, una coppia che si è innamorata in mare e che in mare tenta di salvarsi quando la terraferma — tra routine, lavoro, lutti e nuove responsabilità — si fa instabile.
Una notte fatale, un salvataggio misterioso e l’ossessione di Helen per lo sconosciuto che l’ha tratta in salvo diventano scintilla narrativa e metafora: siamo composti d’acqua, ma il mare che ci abita sa essere anche corrente contraria.
Sulla quarta anglofona circolano endorsement che rendono bene la natura ambivalente del libro: Jane Campbell parla di “a visceral and lyrical novel, speaking to anyone who has loved and feared losing their love” (“un romanzo viscerale e lirico, che parla a chiunque abbia amato e temuto di perdere il proprio amore”).
Louis de Bernières lo definisce “strange, wonderful and passionate” (“strano, meraviglioso e appassionante”), mentre Amanda Craig sottolinea “an intense, fierce portrait of a mind, a marriage and a family in a storm” (“un ritratto intenso e feroce di una mente, un matrimonio e una famiglia in piena tempesta”).
Anche la presentazione Waterstones insiste su questa doppia lama – paesaggio esterno e paesaggio psichico – che il romanzo orchestra con ritmo e densità emotiva.
“Oceano”, il mare come luogo della verità
Helen e Frank si sono conosciuti da ragazzi a bordo della Innisfree. Lì hanno imparato a navigare il mare aperto, lì hanno trovato una lingua comune. Oggi vivono a Londra con il figlio Nicholas e aspettano un secondo bambino; in superficie, la vita procede su binari rassicuranti.
Poi, un evento traumatico squarcia il quotidiano: Helen sopravvive grazie all’intervento di un uomo che appare dal nulla e scompare subito dopo. Da quel momento, il suo desiderio di rivederlo cresce fino a trasformarsi in fissazione, un desiderio così potente da erodere il rapporto con Frank e il legame con il figlio.
Quando l’ossessione diventa isolamento, Frank propone un estremo contraccolpo: tornare in mare. Rimettere insieme l’equipaggio — con Nicholas e Sindi, una giovane affidata alla coppia —, salpare di nuovo e attraversare l’Atlantico come quando tutto è cominciato. La traversata non è solo un ritorno romantico alla giovinezza: è il tentativo disperato di rimettere a fuoco se stessi in un ambiente che non concede sconti.
Il mare, nei capitoli più tesi del romanzo, si fa giudice imparziale: costringe a scegliere, a misurare la distanza tra ciò che diciamo di essere e ciò che siamo quando la bussola impazzisce.
I messaggi del romanzo
I temi che attraversano “Oceano” si intrecciano come correnti sottomarine, portando in superficie tre nuclei centrali: il lutto, l’ossessione e la cura.
Fin dalle prime pagine, Polly Clark introduce una spaccatura netta, una fenditura tra “i vivi e i morti” che abita il cuore della protagonista. L’ossessione di Helen per il misterioso salvatore non è soltanto un impulso romantico o un capriccio dell’immaginazione: è il volto che cerca di dare all’inaccettabile, il tentativo disperato di trasformare la perdita in significato. La sua indagine verso l’altro diventa, in realtà, una domanda rivolta a se stessa: se il caso le ha restituito la vita, che cosa deve fare di quel dono?
Questa ricerca, però, entra in conflitto con la dimensione domestica e con il ruolo di madre e compagna. Helen, spinta da un desiderio che non riesce a controllare, finisce per trascurare chi la ama, vittima di un dolore che si trasforma in narcisismo involontario, una forma di cieca autodifesa che consuma anche gli affetti più sinceri. Clark non giudica, non impone morale o risposte: osserva da vicino come il lutto e il desiderio possano deformare la percezione fino a farci diventare estranei a noi stessi.
E poi c’è Frank, presenza discreta ma decisiva, che incarna la possibilità di una cura diversa. Non è l’uomo che tenta di salvare la donna “per amore”, ma colui che sceglie di curare senza possedere, accettando il rischio del fallimento. Nella sua idea di partire di nuovo, di tornare in mare, si riconosce una fiducia sottile e profonda: che la condivisione, anche nella tempesta, possa essere una forma di rinascita. Clark sembra dirci che l’amore maturo non guarisce negando il dolore, ma navigandoci dentro, consapevole che il mare – come la vita – può guarire o condannare, a seconda di come si sceglie di affrontarlo.
Lo stile di Clarck
La prosa di Polly Clark tiene insieme densità poetica e concretezza: gli oggetti — cime, vele, carte nautiche, correnti — non sono semplice scenografia: diventano lessico sentimentale.
Quando la Innisfree sbatte contro onde corte e vento contrario, la frase si fa scabra, sincopata; quando una bonaccia sospende il tempo, Clark lascia entrare un lirismo acqueo, mai ornamentale, che ricorda la grande tradizione del romanzo marino (da Conrad a O’Brian) ma la ripiega su coordinate domestiche.
Non stupisce che le schede delle librerie britanniche insistano sulla capacità di Clark di “mostrare cosa può fare una grande narratrice quando si sente completamente libera” (“shows what a great novelist can do when she’s completely free”), come recita la citazione attribuita a Louis de Bernières nel paratesto editoriale britannico.
Il paratesto, qui, è interessante di per sé: la campagna editoriale oltremanica posiziona Oceano come romanzo mainstream letterario — accessibile, ma capace di morsi stilistici — puntando su blurbs di autori e critici noti e su una sinossi che privilegia personaggi e atmosfera rispetto al puro plot.
Un romanzo “marino” senza nautica decorativa
Spesso la letteratura di mare cade in due trappole: l’infodump tecnico o, al contrario, il mare come sfondo. Clark evita entrambe: le manovre non sono spiegate per compiacere, ma quando entrano in scena decidono la psicologia. L’abilità nel tenere la rotta diventa misura del controllo, il meteo è lo stato d’animo, la navigazione notturna è quell’ora in cui non si può mentire a se stessi. Così, quando i personaggi si parlano male, è perché il vento è girato davvero.
Figure secondarie
Il romanzo non si chiude nel duetto adulto. Nicholas, undicenne, è scritto con attenzione rara: non è un bambino “funzionale”, ma una coscienza che registra e reagisce. Sindi, la ragazza presa in affido, è forse la scommessa più rischiosa e riuscita: portatrice di un’altra ferita, infrange la retorica della “famiglia che guarisce” e mostra come i legami siano processi, non soluzioni.
Ricezione e paratesto: come l’hanno presentato i media
Le presentazioni delle principali librerie britanniche e irlandesi (Waterstones e Guardian Bookshop) mettono l’accento proprio su intensità e tempesta domestica, citando gli endorsement di Amanda Craig, Jane Campbell e Louis de Bernières.
In particolare: “an intense, fierce portrait of a mind, a marriage and a family in a storm” (Amanda Craig) e “a visceral and lyrical novel” (Jane Campbell) sono le due etichette che ritornano più spesso nel materiale editoriale consultabile online.
“Con una scrittura densa e appassionata riesce a descrivere l’altalena psicologica dei protagonisti, accompagnandoli alle avversità della navigazione nell’immensità dell’Oceano Atlantico.”
(“With a dense, impassioned prose, Clark captures the protagonists’ psychological see-saw against the adversity of Atlantic navigation.”)
Ciò che funziona (molto)
“Oceano” vince quando affronta il desiderio come forza naturale. L’ossessione di Helen non è un vezzo romantico, ma una corrente fredda che scorre sotto il matrimonio e lo mette alla prova. Clark è bravissima a non moralizzare: ci fa sentire la tentazione, il sollievo, la vergogna, la fame, l’incanto. E quando sposta la scena a bordo, il romanzo evita l’autoindulgenza: il mare chiede competenza, attenzione, coraggio – e ciò riporta i personaggi alla concretezza dei gesti, li salva dall’astrazione.
Sul piano stilistico, Clark calibra un lirismo fisico (sale sulla pelle, odore di gasolio, ferro bagnato) con una struttura a onde: creste di pathos seguite da piane di riflessione che permettono al lettore di respirare senza perdere tensione.
Una nota sull’autrice
Polly Clark, poetessa e romanziera britannica, è nota per “Larchfield” (2017) e “Tigre” (2019), romanzi accolti con favore dalla critica per la combinazione di immaginazione lirica e indagine psicologica. Con “Oceano” sposta il baricentro su una storia familiare e marittima, ma conserva il suo marchio: la tensione tra natura selvaggia e civiltà domestica.