“Le donne muoiono” Un classico necessario di Anna Banti
Romanzo dopo romanzo, Anna Banti ha dato voce alle donne dimenticate dalla storia. La raccolta “Le donne muoiono” è un classico potente e necessario da riscoprire oggi.
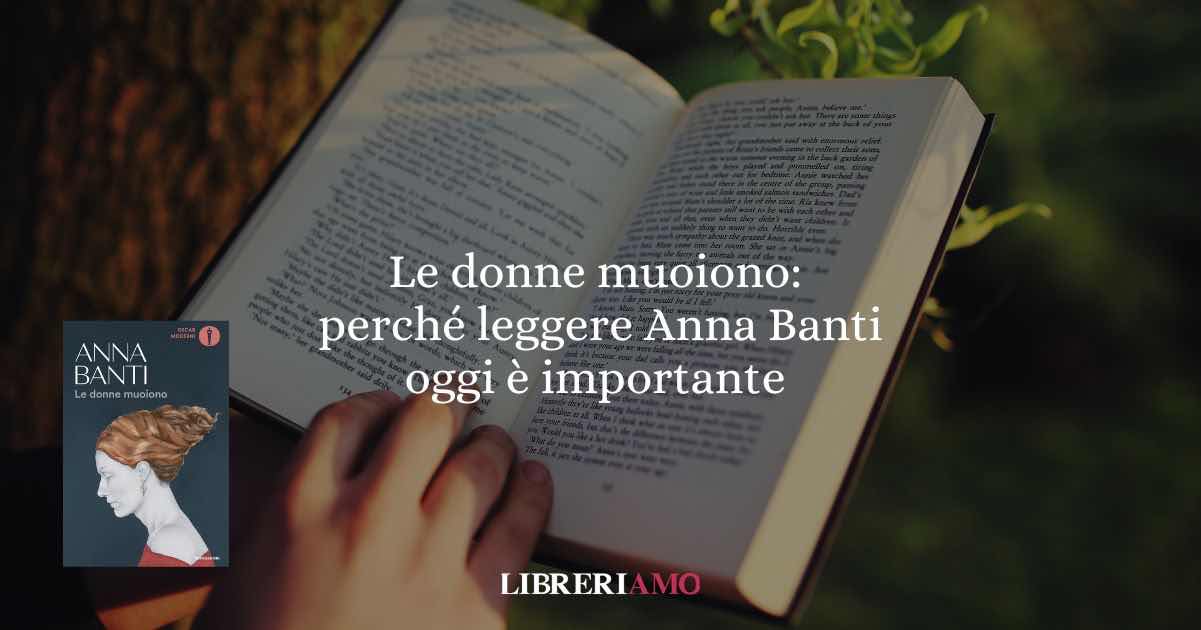
C’è un filo sottile, teso e incandescente, che attraversa tutta l’opera di Anna Banti: la consapevolezza che la storia, l’arte e la memoria non sono mai neutrali.
Che spesso, anzi, dimenticano, eludono, ignorano tutto ciò che riguarda le donne. “Le donne muoiono” è il titolo emblematico di una delle sue opere più potenti: una raccolta di racconti scritti tra il 1936 e il 1950, pubblicata nel 1951 e vincitrice del Premio Viareggio. E non è soltanto un titolo: è una condanna, un monito, una dichiarazione di poetica e politica allo stesso tempo. Questo libro si impone come un classico da leggere, studiare e custodire.
Chi è Anna Banti la scrittrice che ha ridato voce alle donne
Anna Banti è lo pseudonimo di Lucia Lopresti Longhi (Firenze, 1895 – Ronchi, 1985), scrittrice, saggista e storica dell’arte italiana. Sposata con il celebre critico d’arte Roberto Longhi, fu redattrice della rivista Paragone e affermata voce della cultura del Novecento.
La sua opera fonde lirismo e rigore critico, raccontando la storia, l’arte e la condizione femminile con uno sguardo visionario e profondo. Celebre il romanzo “Artemisia” (1948), dedicato alla pittrice Artemisia Gentileschi, esempio della sua capacità di riscrivere la storia delle donne con empatia e forza narrativa.
Tra i suoi libri più noti: “Il coraggio delle donne”, “Noi credevamo”, “Campi elisi”, “La monaca di Sciangai”, “Il bastardo e il memoir” “Un grido lacerante” (1981).
Fu anche autrice di importanti studi su artisti come Lotto, Velázquez e Monet, unendo scrittura creativa e sguardo critico in una forma del tutto originale e anticipatrice.
“Le donne muoiono” un classico dimenticato? No, un classico trascurato
La raccolta è un vero mosaico di voci e ambientazioni. I racconti si muovono tra epoche storiche diverse, città lontane e universi immaginari, ma a unificarli è sempre il punto di vista femminile.
Un punto di vista che non è mai semplicemente “di genere”, ma diventa gesto politico, rivolta narrativa, esigenza di riscrittura. Nel racconto I porci, ad esempio, due fratelli fuggono da Roma saccheggiata dai Vandali, e la loro nuova esistenza assume un tono quasi fiabesco, distorto dalla fuga e dalla perdita.
In Lavinia fuggita, tra le orfanelle dell’Istituto della Pietà di Venezia, emerge una giovane dal talento musicale straordinario, in una storia che unisce la potenza della vocazione artistica alla brutalità delle istituzioni.
Ma è soprattutto nel racconto che dà il titolo al libro, “Le donne muoiono”, che si tocca uno dei vertici della raccolta: ambientato nel futuro, nel XXVII secolo, immagina una civiltà in cui le donne non ricordano le vite passate, e in cui solo l’arte diventa la possibilità di una memoria e di una sopravvivenza.
La domanda che il libro ci impone
Cosa accade quando a una donna viene negato il diritto di creare? È questa la domanda che Banti insinua in ogni pagina. Non è un tema “superato”: ancora oggi, il mondo dell’arte e della letteratura continua a portare i segni di una tradizione maschilista che ha invisibilizzato le creatrici, relegandole ai margini o ricordandole solo per il loro legame con uomini celebri.
Banti non offre soluzioni semplici. I suoi racconti sono densi, complessi, spesso enigmatici. Ma proprio per questo restano vivi, urgenti.
Come scrive Giuliana Misserville, questa raccolta “pone interrogativi attualissimi”, e ci costringe a chiederci quanto sia stato davvero superato il dominio patriarcale nel mondo della cultura.
Una scrittura raffinata, spietato, modernissima
La prosa di Anna Banti è tanto precisa quanto inquieta. Non cerca mai l’effetto, ma lavora per sottrazione, per allusione. Ogni racconto è una piccola architettura, dove lo stile si fa sostanza.
Non c’è nulla di retorico, nulla di urlato, ma tutto vibra di una forza sottile, malinconica, a tratti feroce. Come ha scritto Gianfranco Contini, queste pagine vanno “avvicinate solo alle più supreme della Woolf”. Un paragone altissimo, che rende giustizia a un’autrice spesso dimenticata, o relegata a un ruolo secondario nel panorama letterario italiano.
Tutt’ora continuiamo a interrogarsi su identità, memoria, giustizia di genere. “Le donne muoiono” è più che un libro: è una lente, uno specchio, un faro.
È un testo che ci parla del passato per interrogarci sul presente e sul futuro. Ci mostra come la letteratura possa essere non solo testimonianza, ma anche un atto di memoria.
Anna Banti non ha scritto per piacere, ha scritto per dire, per redimere, per ricordare. Le sue donne muoiono, sì, ma lasciano dietro di sé una traccia indelebile: nella lingua, nell’arte, nella nostra coscienza di lettori.
Altre opere di Anna Banti
Le opere di Anna Banti tracciano un percorso letterario unico, in cui la scrittura diventa strumento di riscatto per le donne dimenticate dalla storia. Con una prosa raffinata, colta e visionaria, l’autrice racconta storie di resistenza, desiderio e dolore. Le sue protagoniste sono creature complesse, “umiliate, offese e risentite”, che trovano nella parola letteraria l’unico spazio per affermare la propria esistenza.
“Il coraggio delle donne” (1940)
Opera composta da cinque racconti che celebrano la forza femminile in tempi e contesti di oppressione. Banti esplora il coraggio quotidiano di donne comuni: Amina, che sfida il marito violento; Felicina, schiacciata da un destino imposto; Sofia, che sceglie l’indipendenza.
Il libro fu per l’autrice un “primo gesto di libertà”. Attraverso una scrittura intima e lucida, l’autrice mette in luce i vincoli storici e sociali che imprigionano le donne tra Ottocento e Novecento.
“Le mosche d’oro” (1962)
Considerato il romanzo più ambizioso e sperimentale di Banti, narra la vicenda parallela di Libero Marcocci, pittore italiano di origini contadine, e Denise Ravier, giovane donna borghese e inquieta.
Dopo una relazione in una Parigi bohémienne degli anni ’50, i due si separano. Libero torna in Italia con il figlio, Denise si perde in cliniche e hotel di lusso.
La struttura narrativa incrocia le loro voci, riflettendo sul mito della libertà individuale, sulle dinamiche di genere e sulle rovine interiori del dopoguerra.
“La camicia bruciata” (1973)
Ambientato nella Toscana medicea, il romanzo segue la figura di Marguerite Louise d’Orléans, sposa di Cosimo III de’ Medici, donna ribelle e passionale.
Con una narrazione dialogica, Banti indaga l’intimità esistenziale delle donne di corte, oltre i limiti della storiografia ufficiale. In parallelo si racconta anche Violante di Baviera, creando un “ambiente narrativo di sorellanza”.
Il romanzo si propone come opera di interpretazione storica e riflessione femminile sul potere e sulla clausura matrimoniale.
“Artemisia” (1947)
Romanzo biografico dedicato alla pittrice seicentesca Artemisia Gentileschi. Racconta una vita segnata dal talento artistico e dalla violenza subita, con particolare attenzione al celebre processo contro il suo stupratore e alla sua ascesa nel mondo dell’arte.
Il manoscritto originale andò perduto nei bombardamenti del 1944; Banti lo riscrisse interamente. Il risultato è un romanzo modernista e visionario, dove la voce dell’autrice si intreccia con quella della protagonista. Un inno alla forza femminile e alla rivendicazione del proprio destino.
“Itinerario di Paolina” (1937) e “Sette lune” (1941)
Primi romanzi in cui emerge la cifra stilistica di Banti: indagine psicologica, atmosfere rarefatte, attenzione per le voci femminili. “Itinerario di Paolina” segna il debutto del suo pseudonimo, mentre “Sette lune” prosegue idealmente la narrazione, con la protagonista Marisa Alessi come nuova incarnazione del desiderio di libertà e soggettività.
“Un grido lacerante” (1981)
L’ultima opera, profondamente autobiografica. Un romanzo-memoriale che racconta l’esperienza di lutto e sopravvivenza dopo la morte del marito, Roberto Longhi.
Attraverso riflessioni intime e ricordi condivisi, Banti si interroga sul senso della propria esistenza di critica e scrittrice. È anche un libro sulla memoria, sull’arte, e sulla responsabilità di “custodire” una vita e un’eredità culturale.