La letteratura italiana non fa più la rivoluzione. Fa solo storie da vendere?
Cosa racconta davvero la narrativa di oggi? Il saggio “La letteratura circostante” di Gianluigi Simonetti analizza la letteratura italiana tra romanzi e cliché.
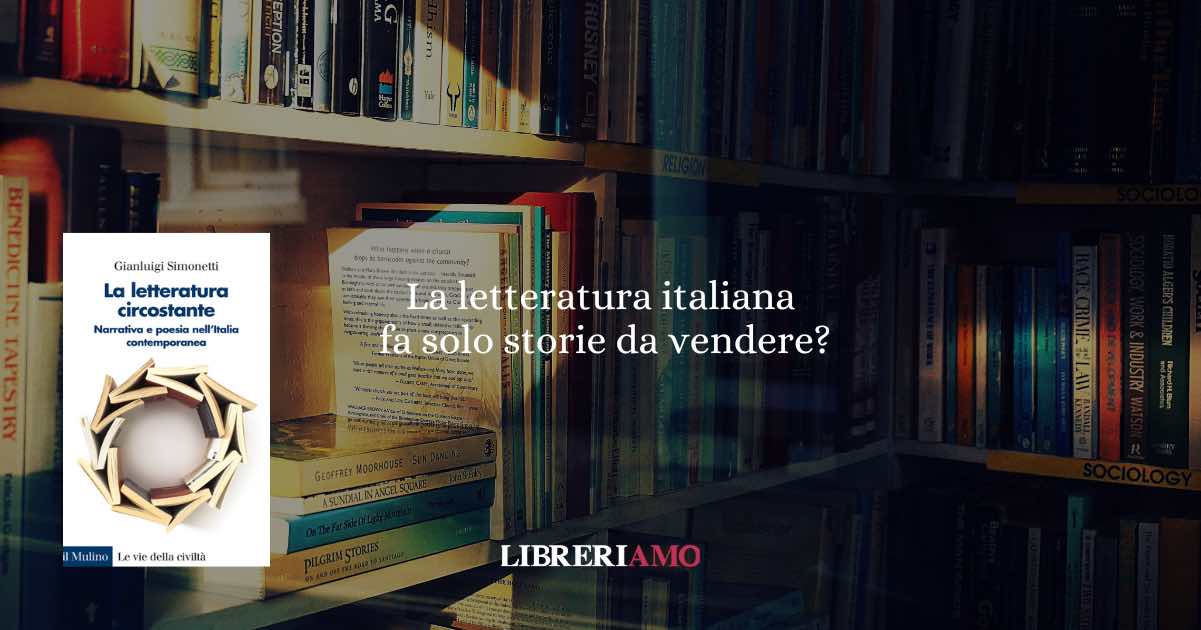
C’è stato un tempo in cui i romanzi italiani volevano cambiare il mondo. Oggi, nella maggior parte dei casi, vogliono solo vendere copie. Lo dice con chiarezza La letteratura circostante (Il Mulino) di Gianluigi Simonetti, saggio che smonta miti e illusioni sulla narrativa e la poesia italiana contemporanea e la letteratura italiana.
Non è un libro per nostalgici del Novecento, né un attacco alla “cultura pop”. È, piuttosto, una diagnosi lucida e spietata: la letteratura italiana è diventata un fenomeno di massa, fluido, veloce, piacevole, spesso mediocre. E noi, lettori affamati di storie, ne siamo complici felici.
In questo contesto, la letteratura italiana si trova a dover affrontare sfide inedite e opportunità uniche.
Curiosità: I 3 romanzi-simbolo della nuova letteratura italiana secondo Simonetti
Branchie di Niccolò Ammaniti (1994): romanzo di culto anni ’90, frammentario e pop
L’abusivo di Antonio Franchini (2001): stile diretto, realtà borderline
La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano (2008): dolore personalizzato, successo da 1 milione di copie
La letteratura italiana è ancora degna di questo nome? O produce solo beni di consumo?
Una cartografia del nostro paesaggio narrativo
Gianluigi Simonetti, docente di Letteratura italiana contemporanea e collaboratore di testate come il Sole 24 Ore, ci accompagna in un viaggio critico tra romanzi bestseller e opere dimenticate, tra capolavori discussi e testi “mediocri ma rivelatori”.
Il suo approccio è inedito: non si limita a giudicare i “grandi”, ma analizza tutto il campo letterario, compresi i prodotti che la critica tende a ignorare.
Perché è lì, nei libri da scaffale, nei romanzi da 10.000 copie l’anno, che si gioca il vero rapporto tra scrittura e società.
Libri veloci per lettori stanchi
Una delle tesi centrali del saggio è che la narrativa italiana, tra anni Novanta e Duemila, ha cambiato ritmo. I romanzi hanno perso i tempi morti, si sono fatti corti, episodici, rapidi.
Una scrittura “passante”, pensata per attraversare il lettore, non per trattenerlo. Simonetti parla di “letteratura come sistema passante”: non più un luogo di scontro, ma un’esperienza a bassa intensità, da vivere quasi senza fatica.
Il romanzo non cerca più la verità: cerca attenzione. Non scuote, ma scorre. E questo ha cambiato tutto.
Dal sapere all’evasione
Un tempo il romanzo era lo strumento della critica sociale. Oggi è un prodotto d’intrattenimento. Simonetti lo dice senza mezzi termini: la letteratura italiana ha smesso di voler insegnare.
Ora vuole solo emozionare. Il libro analizza come ciò sia avvenuto, e perché. Tra i fattori chiave: la televisione e il cinema come modelli narrativi, la pubblicità come stile espressivo (Moccia, in questo senso, è un caso da manuale), l’uso sempre più spregiudicato di cliché emozionali, la creazione di scrittori “di categoria”: giovani, serializzati, identificabili, vendibili.
Anche i temi più seri (terrorismo, borgate, lutto, malattia) vengono trattati come strumenti di engagement emotivo. Il dolore si consuma in superficie, la politica scompare. Non si scrive per cambiare, ma per rassicurare.
L’io come brand: scrittori giovani, social, riconoscibili
Un altro punto forte del libro è l’analisi delle “scritture di categoria”: non conta più cosa scrivi, ma chi sei mentre lo scrivi. Sei un’esordiente under 30? Una voce queer? Un outsider del Sud? Sei già una categoria vendibile.
Simonetti racconta la nascita del “giovane scrittore” come marchio editoriale, tra fiction autobiografica e brand personale. Il testo diventa un pretesto per l’identità, e l’identità un’etichetta che aiuta a vendere.
Il risultato? Una narrativa autoreferenziale, omogenea, spesso seriale, dove si scrive come si posta su Instagram: per essere notati più che per essere letti.
E la poesia?
La seconda parte del saggio è dedicata alla poesia italiana contemporanea, e il quadro è meno commerciale ma non meno inquieto. Simonetti descrive un universo frammentato, fatto di voci disperse, tentativi, ironie malinconiche.
La poesia, oggi, non ha più un centro. È “circostante”, come tutto il resto: sopravvive nei blog, negli slam, nei social, nei libri a tiratura limitata. Non muore, ma si disperde. Ogni tanto riappare, potente e vera, ma subito scompare nel rumore.
Perché questo libro è importante
Perché La letteratura circostante ci dice cose che nessuno ha il coraggio di dire. E le dice bene. Leggendolo scopriamo: perché molti libri di successo sembrano scritti con lo stampino, perché certi autori “seri” vendono pochissimo, perché anche l’evasione è una scelta politica, perché la critica è sempre più debole, perché abbiamo bisogno di storie, anche se mediocri Simonetti non demonizza il presente, ma lo legge con occhi aperti.
E ci invita a fare lo stesso: cosa chiediamo davvero alla letteratura? Verità, oppure consolazione?