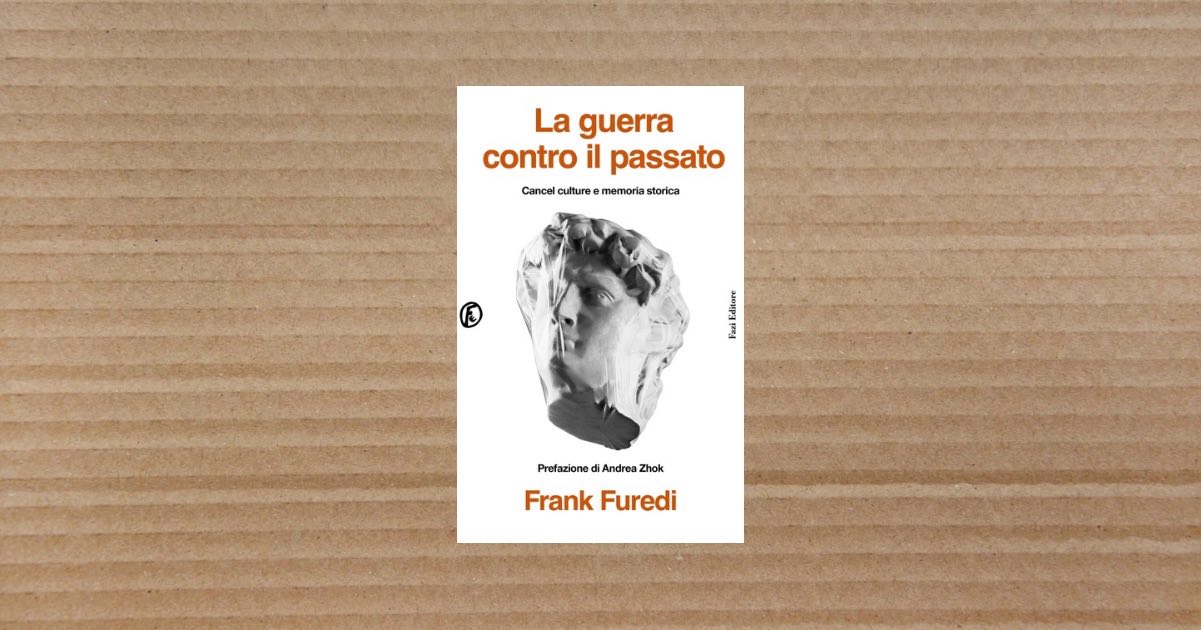“La guerra contro il passato”: cancel culture, memoria storica e perché leggerlo oggi
Arriva in Italia per Fazi “La guerra contro il passato. Cancel culture e memoria storica” di Frank Furedi, con la prefazione di Andrea Zhok e la traduzione di Riccardo Cristiani, un saggio che vuole comunicare il disagio di studiosi e accademici di fronte alla crociata culturale presente nel mondo occidentale angloamericano, che mira a delegittimare il passato. E qui possiamo citare statue abbattute, programmi “decolonizzati”, liste di “parole proibite”, opere rilette solo come colpe…
L’editore sintetizza così la posta in gioco: “l’intero retaggio storico dell’Occidente è diventato un campo di battaglia” e contaminare il passato rende “quasi impossibile dare un senso alla vita nel presente”.
Il volume italiano dialoga con l’edizione inglese — “The War Against the Past, Polity” del 2024 —, un saggio militante che invita a “combattere” la delegittimazione della storia occidentale e dei suoi ideali, dalle radici classiche all’Illuminismo.
Frank Furedi
È un sociologo, professore emerito all’Università del Kent, nonché autore di oltre venti saggi su paure sociali, cultura del rischio, autorità e istruzione, che negli ultimi anni ha concentrato la ricerca sul conflitto culturale e sui linguaggi della “guerra culturale”.
L’architettura del saggio (e la prefazione italiana)
La tesi centrale è il rifiuto del presentismo, perché giudicare ieri con i metri morali di oggi porta a confondere lo studio storico e la giustizia postuma; tant’è vero che questo stesso presentismo viene lamentato da molti nella scelta di riadattamento di opere come quelle di Roald Dahl.
Nella prefazione è Andrea Zhok a chiarire il punto: molte campagne non incidono sulle conseguenze materiali (proprietà, capitali, riparazioni), ma si concentrano su correzioni simboliche — abbattere statue, emendare testi, imporre “disclaimer”, ridefinire canoni — una vendetta simbolica postuma che rischia di agire “arbitrariamente sulle forme di vita presenti”. È il cuore etico-politico dell’edizione italiana che le pagine introduttive esplicitano con esempi, dal “politicamente corretto” ai revisionismi spicci nei prodotti culturali (cinema, tv, manuali).
Furedi insiste dicendo che cancellare, anziché comprendere, significa addestrare all’amnesia storica, scollegando generazioni dal loro lessico comune (tradizioni, opere, categorie). Da qui la sua difesa di studio contestualizzante, pluralità interpretativa, senso della complessità.
Il lavoro di mappatura
Furedi parla di casi, soprattutto britannici e nordamericani, che rendono tangibile il fenomeno: toppling di statue, “decolonisations” curricolari, trigger warnings, riscritture — come nel caso di Dahl.
Il giudizio di Kirkus Reviews coglie bene l’operazione: un “furious attack on the extremes of political correctness” (“un attacco feroce agli eccessi del politicamente corretto”), in cui Furedi denuncia una “grievance archeology” ossessionata da torti storici riletti con le lenti dell’identità contemporanea.
La cornice morale
Furedi chiede di studiare il male del passato senza trasformarlo in atto penale retroattivo, perché — lo ha ribadito anche in interventi pubblici e interviste di lancio italiane — attaccare il passato finisce per legittimare identità prive di ancoraggio, spostando l’attenzione dai problemi concreti a battaglie simboliche.
Per Polity, è “un libro importante” perché ricostruisce come si sia sviluppata la “rabbia contro il passato”.
Dove il libro è discutibile (ed è un bene dirlo)
Bisogna ammettere, tuttavia, che ha un focus anglocentrico e che non si può leggere questo libro partendo con il presupposto che stia parlando interamente del mondo. Vero è che l’America è un po’ “il centro del mondo” ormai, ma non si deve giudicare questa cultura della cancellazione come un pericolo per l’Italia. Il campionario è ricco ma prevalentemente UK/USA.
Bisogna comunque identificare l’autore. Furedi è da anni una figura controversa del dibattito britannico (libertarismo culturale, rete di Spiked): per alcuni è un merito (difesa radicale della libertà di espressione), per altri un bias. Conoscerlo aiuta il lettore italiano a collocare il libro.
Come scrive Furedi secondo la critica
La prosa è assertiva, combattiva, saggistica: più a tu per tu che manuale; un libro “posizionato” scandito da tesi, casi, contro-argomentazioni. Secondo Kirkus Reviews (USA) è “A furious attack on the extremes of political correctness.” (Un attacco feroce agli eccessi del politicamente corretto).
Jonathan Sumption su History Reclaimed (UK) dice del libro: “racconta come è maturata la nostra rabbia contro il passato” e perché serve una difesa della storia contro la vergogna programmata.
Nel materiale stampa di Polity e in schede di libreria internazionali (Target), accanto al giudizio di Kirkus, compaiono endorsement e brevi note di lettura che sottolineano la necessità di un confronto franco con la storia.
Che cosa aggiunge la prefazione di Andrea Zhok
La prefazione è un vero e proprio capitolo aggiuntivo della nostra edizione italiana. Zhok definisce questa temperie una “guerra contro il passato” che si alimenta di correzioni interpretative più che di riparazioni reali; denuncia la “logica del risarcimento morale” e del “risentimento organizzato” che produce un clima emotivo in cui persino espressioni storiche vengono ritenute offensive a posteriori. La sua tesi conclusiva è chiara: l’alternativa non è assolvere il passato, ma comprenderlo — e salvare così la capacità critica del presente.