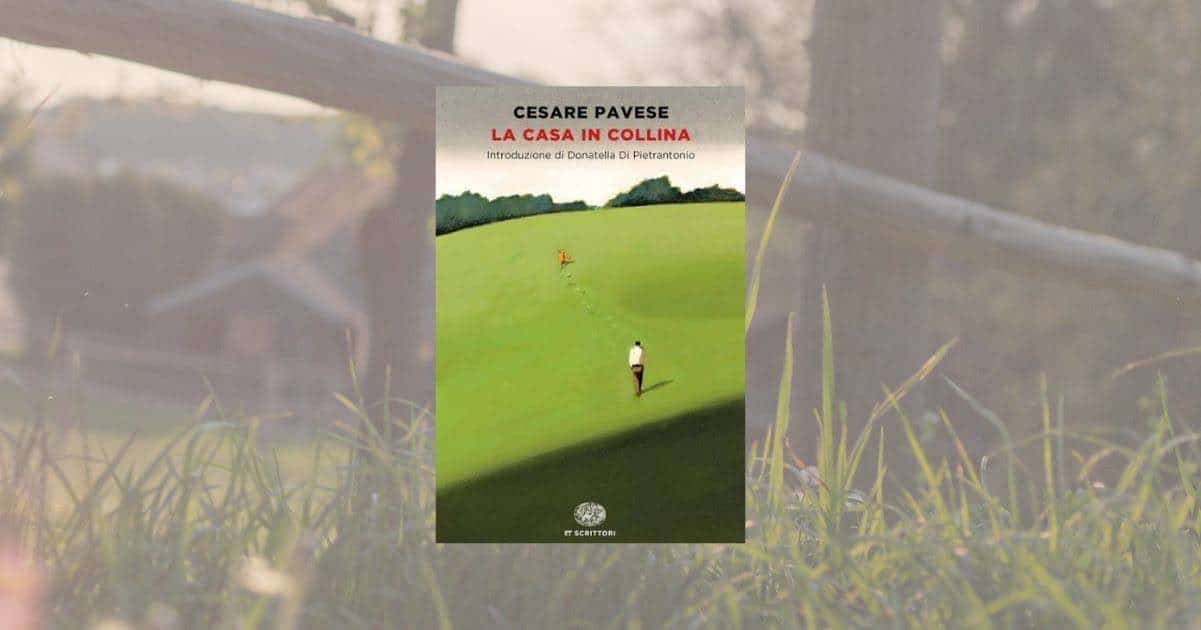“La casa in collina” è uno di quei classici impossibili da dimenticare: scritto nel 1948 da Cesare Pavese, mette in scena il momento in cui la Storia esilia il mito.
Un classico che illumina sulla responsabilità
Parla di Corrado, professore di chimica a Torino, che si rifugia “in collina” durante la guerra: un altrove fatto di piccoli rituali e di rassicurazioni che il tempo bellico manda in frantumi.
Corrado sceglie la collina mentre la città è sotto le bombe, perché pare come resistere; ma l’8 settembre, l’armistizio, la RSI spingono Corrado fuori dal nascondiglio. Tutto intorno, gli altri scelgono per lui: Cate, i compagni dell’osteria, persino Dino, il figlio di lei; e Corrado è costretto a guardare in faccia le proprie esitazioni.
Quel movimento dal mito alla storia – dai cicli naturali alle date incise – è il cuore del libro. Non a caso “La casa in collina” esce insieme a “Il carcere” nel volume Prima che il gallo canti (Einaudi, novembre 1948): due racconti lunghi che dialogano su solitudine, responsabilità e guerra.
“Ogni guerra è una guerra civile”
La frase più citata del romanzo – “Per questo ogni guerra è una guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chiede ragione” – non è uno slogan: è la diagnosi morale di un testimone che non riesce a sottrarsi allo sguardo.
Pavese lega colpa e somiglianza: il caduto non è un altro assoluto, è uno di noi che torna a chiedere conto.
Questa consapevolezza attraversa tutta la trama: Corrado vede (la retata all’osteria, gli amici portati via, le scelte degli altri), tace, esita, e quel silenzio si fa senso di colpa. Il romanzo non è un atto d’accusa ai “codardi” né un manifesto dell’eroismo: è, tuttavia, il referto di un nascondimento impossibile, come nota Matteo Marchesini nell’introduzione Feltrinelli: Corrado è “l’alter ego pavesiano più credibile e spietatamente ritratto”, un uomo che vede sfumare la giovinezza “senza approdare alla maturità”, costretto a misurarsi con chi – mentre lui si ritraeva – ha imparato ad affrontare la vita.
Casa e collina: luoghi-simbolo
La collina è più di uno scenario: è l’illusione di poter sospendere la storia nel ciclo naturale; la casa – rifugio di Elvira e della madre – è il recinto della sicurezza e anche della chiusura.
Studi e profili didattici sottolineano come Pavese usi questi due poli per misurare il passaggio dal tempo circolare delle stagioni al tempo lineare degli eventi — bombardamenti, 25 luglio, 8 settembre —, compromettendo l’idea che il “ritiro” basti a salvare la coscienza.
Il paesaggio non consola: rende più acuto il contrasto. Quando arriva l’armistizio e l’occupazione, l’idillio si incrina: Corrado assiste di sghembo alla violenza, “fuori campo” rispetto al pericolo, e proprio questa asimmetria – esserci e non esserci – apre la ferita morale.
Legami e responsabilità
Pavese concentra tutto sul microcosmo: una donna del passato (Cate), un ragazzo (Dino) che forse è di Corrado, un gruppo di amici, un’osteria. Le relazioni che potrebbero restare “private” diventano prove etiche: cosa fare quando gli altri scelgono?
Dino – attratto dalla Resistenza – è lo specchio che costringe Corrado a riconoscere la propria inerzia. Non ci sono figure monolitiche: ogni personaggio è un carattere in movimento, persino chi appare marginale diventa indice di una postura morale.
La “nuova maniera” di Pavese
“La casa in collina” è una tappa della “nuova maniera” pavesiana: la riflessione sul mito – cara a Pavese fin da “Feria d’agosto” – viene convertita in narrativa nel vivo della storia contemporanea.
Nel saggio di Giulia Carlesi (“Rutgers”) l’operazione è delineata con chiarezza: l’interesse per il mito non è fuga, ma strumento per guardare agli eventi senza cedere al razionalismo che dominava i tardi anni Quaranta. Il risultato è un ibrido modernissimo: racconto “di guerra” che rifiuta la retorica eroica e mette in crisi il lettore sul piano etico.
Che tipo di “romanzo di guerra” è “La casa in collina”?
Non certo un romanzo d’azione, neppure un diario partigiano, non una celebrazione. È – per usare un’etichetta utile – un romanzo di responsabilità. Il conflitto non si consuma solo tra eserciti, ma dentro chi osserva, dentro chi esita.
“Prima che il gallo canti”: la coppia con Il carcere
Accostare “La casa in collina” a “Il carcere” (racconto del confino che risale a fine anni Trenta) chiarisce la traiettoria: dall’isolamento imposto al ritiro scelto, dalla solitudine alla responsabilità. L’edizione unitaria accentua la domanda morale: di fronte alla Storia, posso davvero restare fuori?
Ricezione e letture recenti
La fortuna del romanzo è rimasta costante: molti commenti contemporanei insistono su come Pavese problematizzi l’impegno senza sconti — della serie che non tutto è bianco o nero, nemmeno in guerra; ma proprio per questo il giudizio interiore diventa più severo. Altri interventi divulgativi tornano sui temi cardine (senso di colpa, responsabilità individuale, città/collina), segno che il libro continua a essere un laboratorio etico prima ancora che un classico scolastico.