“La capanna dello zio Tom” e la lunga strada verso la liberazione
In occasione della Giornata per l’abolizione della schiavitù, (ri)scopriamo insieme “La capanna dello zio Tom”, il romanzo che cambiò l’America.
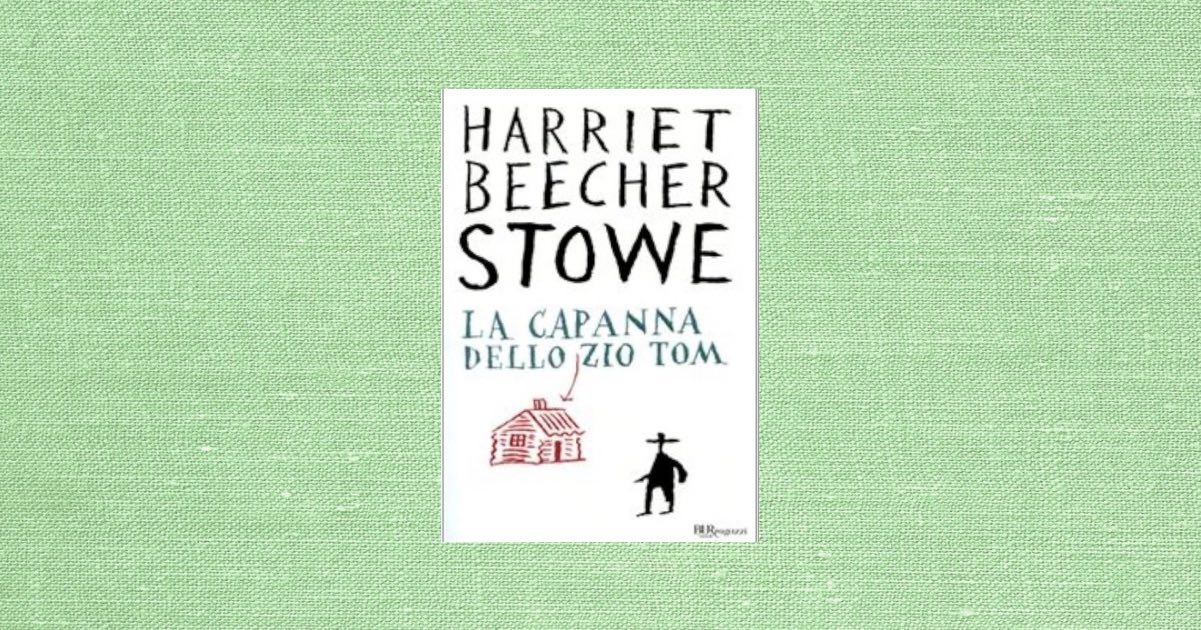
Ci troviamo nel pieno dell’Ottocendo, quando una donna bianca — ed è importante precisarlo — s’interessa alle convenzioni ipocrite degli Stati Uniti del Nord con tutta l’intenzione di mandarle all’aria: lei è Harriet Beecher Stowe, fervente cristiana e abolizionista, la quale cambierà per sempre la coscienza americana con “La capanna dello zio Tom” e sconvolgerà Abramo Lincoln nel giorno del loro incontro, tant’è che pare lui abbia detto “Così questa è la piccola signora che ha scatenato questa grande guerra”.
Quando la letteratura abbatte le catene
Stowe è una donna, una “signora”. Non è un non è un prete, non è un soldato, non è un uomo. Non è niente. Ma ha in mano qualcosa di ancora più potente: la parola scritta. Pubblicato nel 1852, “La capanna dello zio Tom” — titolo originale “Uncle Tom’s Cabin” — diventa presto un caso editoriale, culturale, politico; e, nel tempo, anche un libro scomodo e controverso, a tratti perfino travisato.
Oggi, nel giorno in cui si celebra la liberazione dalla schiavitù — 23 agosto —, vale la pena soffermarsi su di lui con occhi attenti e consapevoli, perché scritto in un periodo in cui davvero uomini e donne lavoravano nei campi e perché racconta con il cuore la profondità della ferita schiavista e la complessità del cammino verso la libertà.
Un libro nato da un’ingiustizia
Stowe scrive per reagire a una legge, il Fugitive Slave Act del 1850, che obbliga i cittadini degli Stati del Nord a consegnare i fuggitivi del Sud: una legge che legalizza l’orrore e che le smuove le viscere.
Da cristiana — e sottolineiamo da cristiana, non per le altre religioni — non può fare a meno di opporsi, perché tutti gli uomini sono uguali, nascono liberi e sotto il solo controllo di Dio e del libero arbitrio. Indignata, inizia fare l’unica cosa che può fare: scrivere a puntate una storia che restituisce umanità agli schiavi e demonizza l’istituzione schiavista attraverso i suoi protagonisti; perché certamente non può da sola mettere a ferro e fuoco l’intera società e ribaltarla con un forcone in mano.
Di cosa scrive?
Al centro della narrazione c’è Tom, uno schiavo nero dal cuore puro, cristiano — come lei e come i bianchi del Nord — e umile. Attorno a lui si muovono figure che incarnano ogni sfumatura morale dell’America di metà Ottocento: dai padroni “benevoli” del Kentucky a quelli sadici della Louisiana, fino ai fuggitivi George e Eliza, che sfidano la morte per una vita libera.
Ma è Tom, con la sua fede incrollabile e la sua resistenza passiva, a rappresentare il vero fulcro etico del romanzo.
La schiavitù come struttura sistemica, non solo morale
Il romanzo non si limita a denunciare la crudeltà fisica della schiavitù. Stowe mette in scena un sistema sociale e religioso che la giustifica, un’intera civiltà che la normalizza. Lo fa mostrando padroni che si ritengono buoni cristiani ma vendono famiglie intere per ripagare i debiti. Donne del Nord che si commuovono ma non muovono un dito. Predicatori che benedicono le frustate in nome dell’ordine.
Non è solo la brutalità di Simon Legree, l’aguzzino finale, a fare orrore. È la banalità del male quotidiano, dei compromessi, dell’indifferenza. “La gente pensa che la schiavitù sia una sfortuna personale”, sembra suggerire Stowe, “ma in realtà è un sistema collettivo che coinvolge tutti”.
Il martirio di Tom: fede e resistenza
Tom è una figura difficile da inquadrare per il lettore contemporaneo. È buono fino all’ultimo respiro, perdona i carnefici, accetta la sofferenza come Cristo. Questa rappresentazione ha generato, nel tempo, il termine spregiativo “zio Tom”, usato per indicare un nero servile e remissivo. Ma questa lettura è parziale e ingiusta.
Tom non è un personaggio privo di forza. Al contrario: rifiuta di tradire i suoi compagni, anche sotto tortura. Resiste con la fede, non con le armi, e muore per difendere la libertà altrui. In questo, è un martire. Il suo corpo è schiavo, ma il suo spirito no. E Stowe lo sa: sceglie proprio un uomo come lui per scardinare i pregiudizi di un pubblico bianco, cristiano e conservatore.
Scrive: “Morire è una cosa facile per un cristiano. Solo, Signore, aiutami a essere fedele fino alla fine.” È questa la vera forza di Tom: la sua incorruttibilità morale.
Una rivoluzione silenziosa
“La capanna dello zio Tom” vende 300.000 copie solo nel primo anno. Diventa un manifesto dell’abolizionismo, un libro odiato nel Sud e letto con le lacrime nel Nord. La sua influenza è tale che, anni dopo, Abraham Lincoln accoglie l’autrice dicendo: “So you’re the little lady who wrote the book that started this great war.”
Non è una frase da prendere alla lettera, ma ci dice molto sul potere della letteratura quando si schiera. Stowe non è neutrale: non cerca il compromesso, denuncia, commuove. Costringe a vedere e cambia qualcosa.
La tratta degli schiavi: memoria e consapevolezza
Nel giorno dedicato alla commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione, il romanzo assume un significato ancora più potente. Ricorda non solo la violenza delle catene, ma anche la dignità di chi ha resistito. Parla delle madri separate dai figli, dei corpi venduti come merce, delle fughe attraverso il fiume ghiacciato, del sangue sparso nei campi.
Ci costringe a chiederci: cosa vuol dire oggi “liberazione”? Basta abolire la schiavitù per essere liberi, o esistono forme più sottili di sottomissione, ancora presenti nei sistemi economici, nelle disuguaglianze razziali, nel razzismo sistemico?
Leggere o rileggere “La capanna dello zio Tom” significa rimettere al centro il valore della memoria.
Un’eredità scomoda ma necessaria
Non tutto, nel romanzo, è immune da critiche. La scrittrice è una donna bianca che ha scritto per persone bianche. Alcuni personaggi sono stereotipati e certe scene indulgono in un sentimentalismo oggi difficile da digerire, troppo cristiano e didascalico. Ma il cuore dell’opera resta forte: è un atto politico, un testo scritto per cambiare il mondo, che ci interroga ancora oggi.
A ogni modo, Harriet Beecher Stowe ha osato raccontare l’inenarrabile e ha scelto di farlo con le armi della parola, dell’emozione, della giustizia morale. In tempi in cui la schiavitù era legge, lei ha gridato che era peccato e lo ha fatto attraverso una storia di dolore e speranza.
Per questo “La capanna dello zio Tom” resterà un classico indimenticabile.