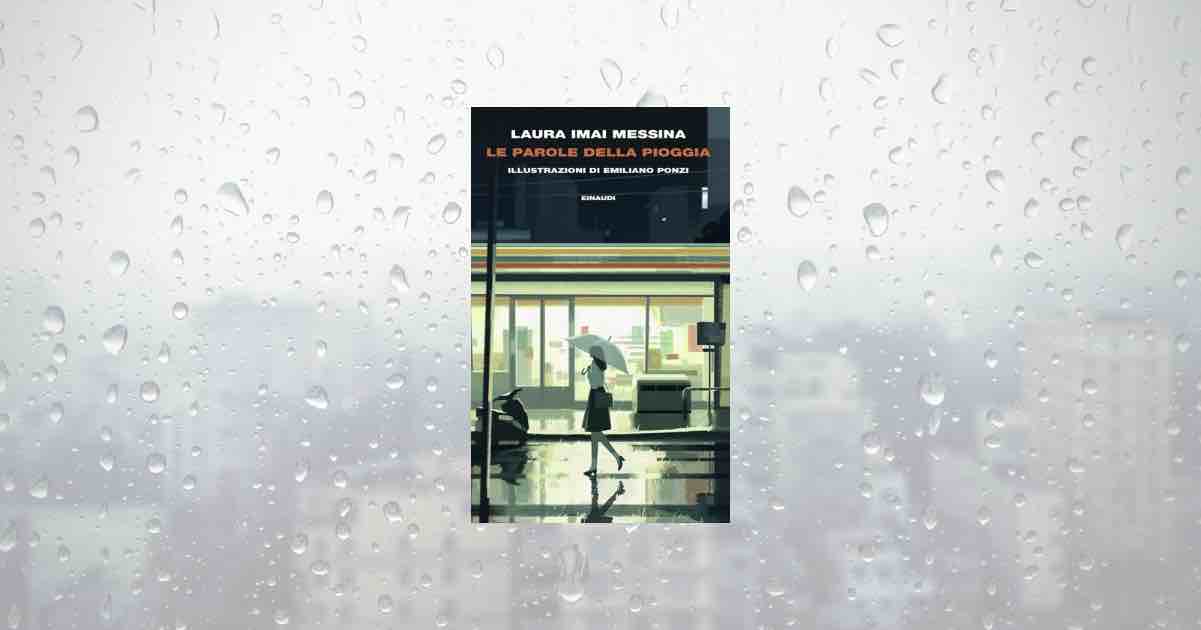“Le parole della pioggia” è una delle uscite più attese di questo autunno: Supercoralli Einaudi, illustrazioni di Emiliano Ponzi e tantissima atmosfera. In questo nuovo libro di Laura Imai Messina si parla di una Tokyo nei giorni di pioggia, un ombrello condiviso e una ragazza.
L’aria che si respira è quella di una “fiaba metropolitana”, nata dalla pratica dell’ascolto sotto un ombrello condiviso, dove il mondo si ferma e le parole trovano lo spazio per cadere piano assieme alla pioggia.
Una grande attesa
L’idea attorno alla quale è costruito il libro è molto semplice, ma narrativamente potente: a Tokyo, Aya e altre “donne-ombrello” camminano accanto agli sconosciuti nei giorni di pioggia. L’ombrello non è solo un oggetto, ma è una stanza mobile: sotto di esso si dicono segreti, si sospende il ritmo della città, si nomina il non detto; uno spazio sicuro, come le mura di una stanza.
Il romanzo procede per incontri: micro-storie che si sfiorano, un dizionario emotivo della pioggia che fa del clima una grammatica. L’effetto è una metereologia degli affetti, dove la condizione atmosferica diventa condizione psichica.
Cosa aspettarsi da “Le parole della pioggia”
Non un giallo, non un romance, non un plot guidato dai colpi di scena. “Le parole della pioggia” è un romanzo di soglia (slipstream), dove la pioggia reagisce come “collante magico” e l’ombrello segna la soglia fisica tra lo spazio reale — una Tokyo piovosa — e quello alterato — dove i dialoghi sembrano avvenire in una dimensione senza tempo.
In “Le parole della pioggia” si entra e si esce da vite altrui sotto un telo che asciuga i rumori. Il rischio, ovviamente calcolato dall’autrice, è di frustrare chi cerca una trama ad alto voltaggio; il guadagno è la tenuta lirica di un libro che lavora per ritorni d’immagine e risonanze acustiche.
Stile: tra haiku urbano e realismo sentimentale
La scrittura di Messina è riconoscibile: lessico limpido, immagini nitide, sintassi che rallenta per far spazio al respiro. Qui l’autrice spinge ancora di più sulla “poesia d’uso”: frasi brevi come haiku urbani, una prosodia che apre varchi ai disegni di Ponzi (non mero abbellimento, ma contrappunto). È un libro da guardare oltre che da leggere.
Continuità e scarti rispetto ai libri precedenti
Chi arriva da “Quel che affidiamo al vento” (romanzo che ha dato a Messina una risonanza internazionale) ritroverà il pudore emotivo, la centralità del lutto come apprendimento, l’idea di luogo simbolico (allora la cabina del vento, oggi l’ombrello). Ma qui c’è meno narrazione lineare e più atmosfera: meno “viaggio”, più sosta.
L’angolo estero: cosa hanno scritto fuori (e come ci aiuta a leggere il nuovo)
“Le parole della pioggia” arriva ora prima in Italia, quindi non esistono ancora recensioni su NYT, Guardian, TLS specifiche per questo titolo; ma la chiave per capirlo è negli occhi esteri posati sui libri precedenti — ed è una lente che funziona.
Kirkus Reviews definiva “Quel che affidiamo al vento” “a wonderful, gentle, hopeful story” che accompagna i protagonisti nel tempo, imparando a far convivere dolore e gioia. È una sintesi perfetta anche per il nuovo: mitezza, speranza, lentezza come strumenti etici.
Il Christian Science Monitor ne parlava come di un romanzo “quieto, saggio” ambientato nel Giappone post-tsunami: quiete e saggezza sono i due assi su cui “Le parole della pioggia” costruisce la propria camera d’ascolto.
The Times (UK) sottolineava la sobrietà e l’assenza di sentimentalismo della prosa (“so restrained and unsentimental”), tratto che torna qui nella castità retorica delle scene sotto la pioggia.
L’aggregatore Bookmarks registrava all’epoca un consenso critico “Rave” su sette testate, utile come indicatore della credibilità d’autrice che oggi consente a Messina di pubblicare un libro meno “narrativo” e più “ambientale” senza perdere lettori.
Questo corpus estero non “parla” del nuovo romanzo, ma parla di lei: dell’etica della voce, della disciplina con cui tiene lontano l’enfasi, della capacità di trasformare un luogo (cabina, ombrello) in dispositivo morale. È la stessa grammatica che ritroviamo, traslata, in “Le parole della pioggia”.
Leggere “Le parole della pioggia” per paragoni (utili)
Il confronto qui non è un gioco di citazioni: serve a misurare la qualità del gesto.
- Con “Quel che affidiamo al vento”: ieri il vento che porta le parole ai morti; oggi l’acqua che ammorbidisce le parole dei vivi. In entrambi i casi, un medium che rende dicibile l’indicibile. (Per la diffusione internazionale del precedente: schede e presentazioni editoriali).
- Con “Le vite nascoste dei colori”: il codice sensoriale si sposta dal cromatico all’acustico (la pioggia come suono, ritmo, cadenza).
- Con la tradizione giapponese (Banana Yoshimoto, Kawabata): stessa leggerezza ferma, ma filtrata da una sensibilità italiana per l’immagine.
- Con “Baricco” (prima maniera): simile controllo melodico della frase, senza compiacimento.
Che cosa regge (e cosa no)
Regge la coerenza: tema, struttura e lingua stanno insieme. Regge l’idea spaziale dell’ombrello come stanza etica. Può invece dividere il lettore la rarfazione del plot: chi cerca archi forti potrebbe desiderare più conflitti; chi accetta la narrativa atmosferica troverà una pienezza sottile.
L’autrice, il ponte, la città
Laura Imai Messina è italiana (Roma, 1981), vive in Giappone da vent’anni: ponte naturale tra due immaginari. Pubblicata in oltre venti Paesi con il precedente bestseller, porta in “Le parole della pioggia” la sua scrittura di contatto: poche frasi “capo-corda”, molte figure concrete, nessun sentimentalismo.
Sotto la pioggia la città acquisita si decanta: restano i rumori di fondo, scompaiono i cartelloni. L’ombrello funziona come filtro dell’immagine: togli, non aggiungere. È un’estetica che Messina pratica da anni: sottrarre per far emergere la voce.
Citazioni estere (dai libri precedenti) utili come lente critica
“A wonderful, gentle, hopeful story… Through sorrow and grief, they learn how to let happiness reside side by side with their memories of loss.”
“Una storia meravigliosa, lieve, piena di speranza… Attraverso il dolore e il lutto, i protagonisti imparano a lasciare che la felicità conviva con i ricordi della perdita”
(Kirkus Reviews, su “Quel che affidiamo al vento”)“A quiet, wise novel set in the aftermath of Japan’s tsunami.”
“Un romanzo quieto e saggio, ambientato nel dopo-tsunami giapponese”
(Christian Science Monitor)“So restrained and unsentimental… despite the subject matter.”
“Così misurato e privo di sentimentalismo… nonostante l’argomento”
(The Times (UK), recensione di “Quel che affidiamo al vento”)“Rave based on seven reviews.”
“Entusiasmo unanime (“Rave”) basato su sette recensioni.”
(Bookmarks, consenso critico internazionale)
Queste voci non recensiscono il nuovo romanzo; servono da cornice autorevole per leggere oggi lo stile e la poetica di Messina.
Verdetto critico
“Le parole della pioggia” è un libro minuto e resistente. Non cerca l’epica, ma una micro-epica dei gesti: camminare insieme, prestare un ombrello, cedere il proprio ritmo all’altrui fiato. Se lo si accetta per ciò che è — un’opera di ascolto — restituisce una intensità rara. Se lo si giudica per ciò che non vuole essere — un romanzo a tesi, a colpi di svolte — sembrerà “troppo poco”. Noi scegliamo la prima strada.
Non fa rumore, eppure rimane, come certe piogge sottili che, dopo ore, scopri di avere addosso.