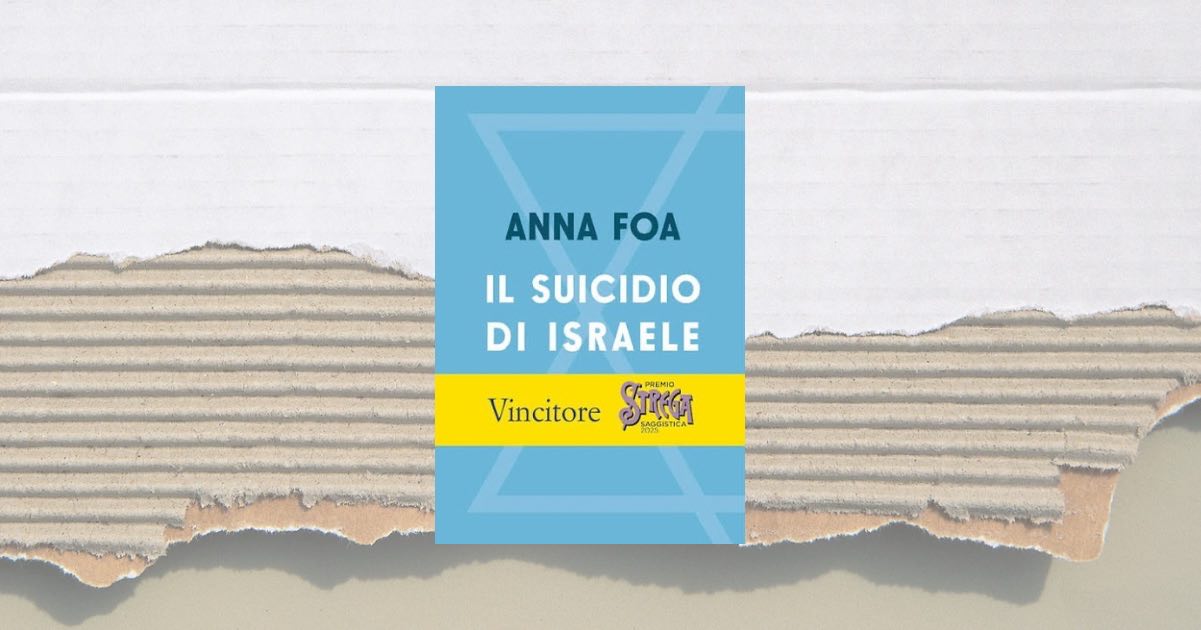Storica dell’ebraismo e della modernità europea, Anna Foa firma per Laterza un saggio breve, uscito nell’ottobre dello scorso anno (2024), che ha acceso il dibattito pubblico italiano: “Il suicidio di Israele”.
Un libro controcorrente
Il volume ha vinto la prima edizione del Premio Strega Saggistica 2025 e il Premio De Sanctis – Saggistica 2025, imponendosi come uno dei testi più discussi dell’anno nel campo della non-fiction civile.
Il titolo, volutamente duro, serve a generare subito polemica e riassume la tesi di un “suicidio” politico e morale causato dalle scelte dell’attuale leadership israeliana che non solo hanno seguito la tragedia del 7 ottobre 2023, ma la vera e propria guerra a Gaza — che è andata sempre più degenerando.
Perché, nonostante la resistenza di molti israeliani e l’ambivalenza di larga parte della diaspora ebraica, la leadership ha trovato comunque modo di scavare sotto i suoi stessi piedi. Lo sintetizza la scheda editore, riprendendo le parole dell’autrice: “Quello che succede oggi in Medio Oriente è per Israele un vero e proprio suicidio. Un suicidio guidato dal suo governo…”.
Antisemitismo, antisionismo e chiarezza lessicale
In interviste e presentazioni, Foa chiarisce una distinzione che attraversa il volume: l’antisemitismo è diverso dall’antisionismo. Il primo va contrastato senza ambiguità; il secondo, quando è critica politica a governi e politiche, non coincide con l’odio verso gli ebrei: è una cornice concettuale che il libro propone per disinnescare cortocircuiti linguistici e riportare la discussione entro un lessico verificabile.
Foa parla da storica e da studiosa dell’ebraismo. Nelle interviste ha chiarito di voler offrire uno strumento di orientamento, scritto “per i giovani e per chi non riesce a spiegarsi la tragedia in corso”, evitando semplificazioni propagandistiche.
È anche in questa circostanza che rivendica una distinzione netta fra antisemitismo e antisionismo, sottolineando come il primo cresca anche in relazione alla guerra, ma non coincida con la critica politica allo Stato d’Israele.
La sua posizione non “tifa” una parte contro l’altra; piuttosto ricostruisce genealogie: l’evoluzione dei sionismi — non uno ma molti, dal progetto originario al filone liberale, fino alla crescita del movimento oltranzista dei coloni e all’assassinio di Rabin —, il rapporto fra sicurezza e diritti, la lunga ombra dell’occupazione e la crisi della democrazia israeliana.
È una storia delle scelte più che dei soli eventi. La stampa civile italiana ha letto il saggio come un “richiamo a percorrere la stretta via della pace”, un invito a sostituire la reazione militare con una strategia politica.
Cosa c’è nel libro
Foa ricorda che, prima dell’attacco di Hamas, Israele attraversava una crisi istituzionale: grandi manifestazioni contro la riforma della giustizia, polarizzazione sociale, logoramento dei contrappesi. La guerra, sostiene, ha agito come acceleratore di fratture già aperte. La risposta militare dopo il 7 ottobre è stata letta come errore strategico e morale, causando un ciclo infinito di violenza e stringendo Israele in un vicolo cieco: rafforza circuiti di odio, isola il Paese e spegne l’orizzonte politico.
Hamas non si sconfigge con le armi, ma con la politica
Una delle frasi più citate del libro suona forte oggi 21 settembre, Giornata Internazionale della Pace: “non saranno le armi a sconfiggere Hamas, ma la politica”. Per l’autrice, la sicurezza di Israele non è separabile dai diritti dei palestinesi: senza fine dell’occupazione e senza un percorso credibile verso uno Stato palestinese, ogni tregua resta un intervallo instabile. Questa tesi ricorre nelle presentazioni e nelle letture critiche che hanno accompagnato il volume.
Israele, la diaspora e la democrazia
Il ruolo della diaspora ebraica
Il libro osserva l’ambivalenza di una parte della diaspora (USA, Europa): tra solidarietà identitaria, imbarazzo e crescenti episodi di antisemitismo alimentati dal clima globale. Foa invita a tenere combattere l’antisemitismo senza però equivocarlo con ogni forma di antisionismo e senza trasformarlo in scudo per qualunque politica, distinguendo tra critica dello Stato e ostilità verso un popolo o una religione.
Una distinzione necessaria, che serve a evitare che il dibattito pubblico prenda le sembianze di una tifoseria.
Premi e riconoscimenti
Premio De Sanctis Saggistica 2025
Nel maggio 2025 “Il suicidio di Israele” vince il Premio De Sanctis – Saggistica: comunicati e rassegne indicano Anna Foa tra i quattro premiati (con Paolo D’Angelo, Sandro Veronesi, Lucio Caracciolo). Il sito della Fondazione e la stampa nazionale riportano motivazioni e palmarès. Il valore (anche simbolico) dei premi.
Premio Strega Saggistica 2025
Il 20 giugno 2025 vince la prima edizione del Premio Strega Saggistica (22 voti su 55) a Taobuk — Taormina International Book Festival: un riconoscimento che ha dato al saggio una cassa di risonanza nazionale. La notizia è confermata dal sito ufficiale del premio e ripresa da testate come la Repubblica e ilLibraio.
Le parole che usiamo
La vittoria del De Sanctis Saggistica (maggio 2025) e allo Strega Saggistica (Taormina, giugno 2025) hanno dato al libro una cassa di risonanza che esce dal recinto accademico. Lo stesso comitato Strega ha sottolineato come la scelta segnali il bisogno di riflessione in una discussione pubblica spesso lacerata da tifoserie. Testate nazionali hanno parlato di vittoria “dal significato politico forte” come invito a ripensare le parole che usiamo quando diciamo “pace”, “sicurezza”, “diritti”.
La Giornata della Pace
Per la Giornata della Pace, “Il suicidio di Israele” è una lettura utile e scomoda. Utile perché fa ordine nella storia e nella tragedia, scomoda perché obbliga a scegliere le parole e a non confondere critica politica con ostilità identitaria.
Il messaggio di fondo è semplice e radicale: i diritti non sono a somma zero. Ogni discorso serio su Israele — la sua esistenza e sicurezza — deve includere quelli dei palestinesi; altrimenti, ciò che oggi appare come sicurezza non è che un intervallo instabile. È in questa prospettiva che il libro di Foa diventa, domani più che mai, un testo per la pace: non per la pace come slogan, ma per la pace come politica concreta.