“Il silenzio è la voce che ho scelto” di Mona Arshi: emozionante slice of life tra mutismo, diaspora e salute mentale
“Il silenzio è la voce che ho scelto” di Mona Arshi (8TTO): coming-of-age delicato su mutismo, diaspora e salute mentale. Trama, temi e perché leggerlo.
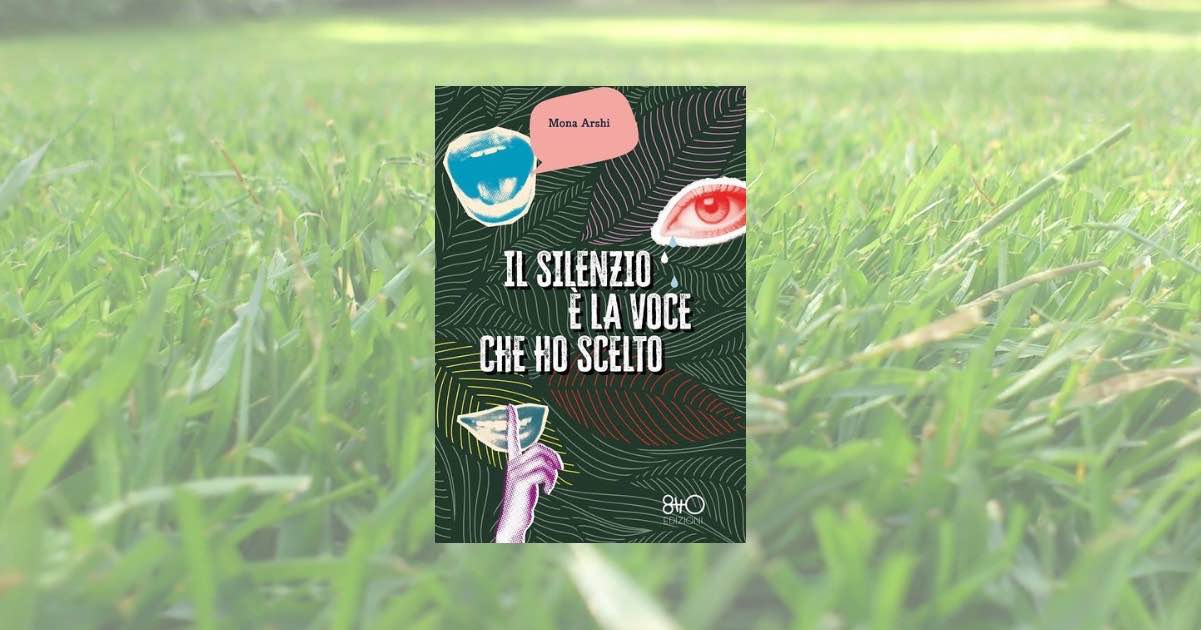
La voce di Ruby: il silenzio che parla
Ruby è ancora una bambina, quando smette di parlare: una decisione presa dopo quella che può sembrare una sciocchezza — un inciampo di pronuncia sulla parola “sorella” — che resterà tuttavia ben salda dentro di lei; una protezione, un confine da non valicare per nessuna cosa al mondo.
Cresce in una periferia inglese, figlia di immigrati indiani, e osserva il fragile equilibrio della propria famiglia con gli occhi di chi sa scrutare oltre la superficie.
La madre attraversa fasi di sofferenza psichica, tra immobilità domestica e ricoveri; la sorella Rania incarna energia e indipendenza; attorno si muove una costellazione di figure memorabili tra cui la nonna Biji, che fa il suo ingresso con pozioni mediche e racconti, la Zia Numero Uno, severa e ribelle, e vicini e compagni, che rendono visibile la tensione fra tradizione e modernità.
Mona Arshi ci regala un romanzo di formazione attraverso la voce interiore di Ruby, una voce potente, che è taciuta per scelta e che procede con un itinerario frammentato: il racconto progredisce con sbagli, dubbi, piccole attese… Ruby non parla, ma pensa, osserva e registra: è una narratrice affidabile, perché ammette i propri sbagli, le incertezze, le sfumature e le contraddizioni del vissuto anche con ironia, riuscendo a essere spietata con se stessa — ricordiamo l’esempio del suo primo amore.
L’autrice: una poetessa nel romanzo
Mona Arshi è nata a West London, dove vive; ha lavorato per un decennio come avvocata per i diritti umani con il gruppo Liberty, poi ha conseguito un master in scrittura creativa alla University of East Anglia. È approdata alla letteratura attraverso la poesia: l’esordio, “Small Hands” (2015), ha vinto il Forward Prize; versi e interviste sono usciti su The Times, The Guardian, Granta, The Times of India, e hanno perfino viaggiato nella metropolitana di Londra. Questo retroterra spiega molto de “Il silenzio è la voce che ho scelto”: precisione lessicale, immagini nette, ritmo interno; la pagina respira come fanno i testi poetici, alternando densità e sospensioni.
Struttura e forma: il ritmo che trattiene
Pubblicato per la prima volta in Italia da 8TTO Edizioni e tradotto da Cristina Cigognini, “Il silenzio è la voce che ho scelto” alterna capitoli più brevi e capitoli più lunghi: una scelta stilistica che mantiene alta l’attenzione di lettori con tempi di lettura discontinui e evita la frattura di senso. I blocchi brevi funzionano come istantanee — lampi che fissano un gesto, un odore, un silenzio —, quelli più lunghi sviluppano scene e relazioni — con Farah, per esempio. Il risultato è una continuità emotiva: anche quando si interrompe la lettura per ore o giorni, la storia resta in mente, come se il filo non si spezzasse.
Questa modulazione di ritmo è uno dei punti di forza del romanzo: invoglia chi ama lo slice of life, quel modo di raccontare la vita per frammenti significativi che dialoga bene con i lettori più giovani e con chi legge “a finestre” nella quotidianità.
La voce (interiore) di Ruby
Ruby ha scelto il silenzio, ma non è assente nel romanzo. Lei interpreta ogni situazione che la circonda, decifra i gesti delle persone e restituisce al prossimo ciò che questi gli ha dato in precedenza. Per esempio, la sua relazione simbiotica con Rania è centrale nel testo subito dopo quella con la madre. Le due sorelle appaiono come facce della stessa medaglia: una trattiene, l’altra spinge; una protegge con il tacere, l’altra protegge con l’azione. La dinamica non smette di evolvere fino al termine del libro, dove resta la sensazione di una solidarietà strutturale: qualunque cosa accada, l’una è presenza per l’altra.
La scelta di non medicalizzare in modo esplicito il silenzio (pur suggerendo un mutismo selettivo o una risposta al trauma) evita gabbie interpretative. Il lettore è spinto a leggere il tacere come linguaggio alternativo, non come difetto da correggere; e questo decentramento è parte della forza etica del libro.
Famiglia, diaspora, periferia
Il romanzo esplora con continuità la vita di una famiglia della diaspora indiana in UK. Non c’è una retorica del “qui vs. lì”: c’è una rete di legami che tirano in direzioni diverse. La madre vive la distanza dalla terra d’origine come ferita carsica; il giardino diventa spazio simbolico in cui il ricordo prende forma: piante, profumi, rituali minimi che riattivano appartenenze. Laddove la casa, a tratti, paralizza, il giardino cura — è un altrove raggiungibile dove i gesti ripetuti rimettono ordine nel caos — o quantomeno cura fino a un certo punto…
La periferia inglese è raccontata con sguardo concreto, senza caricature: scuole, autobus, vicinato. Qui Arshi dà misura al tema dell’invisibilità sociale: essere ignorati, confusi per altro, letti come problema o eccezione. Ruby reagisce con la vigilanza: impara a osservare i microsegni che anticipano le crisi della madre, si muove per tempo, resta attiva. Non è un’eroina, e proprio per questo funziona: è una ragazza che resiste.
La madre: salute mentale ed ereditarietà
Il libro affronta con tatto il tema della salute mentale genitoriale. La madre attraversa esaurimenti, ricadute, periodi di ospedale; ci sono “pasticche contro la solitudine” e “pasticche contro i geloni”: l’ironia lieve con cui Ruby descrive l’accumulo di pillole fa emergere smarrimento e paura. Il nodo dell’eredità è implicito: cosa si riceve da chi soffre? La risposta del romanzo evita scorciatoie: non si eredita un destino, si ereditano fratture e domande; sta a chi cresce decidere quale posto dare a quei traumi nello scaffale della memoria.
Perché leggerlo
L’edizione italiana di 8TTO Edizioni porta in catalogo un romanzo che unisce temi sociali a una ricerca formale che viene dalla poesia. È una combinazione non scontata nel panorama italiano: una letteratura accessibile e curata, capace di parlare ai lettori forti come a chi cerca storie empatiche con una protagonista giovane.
“Il silenzio è la voce che ho scelto” è un coming-of-age delicato e preciso: un libro breve che resta a lungo con il lettore perché non urla, e proprio per questo si incide sotto pelle.
La voce interiore di Ruby è potente, la dinamica con Rania costruisce una sorellanza credibile, il rapporto madre-figlia affronta fragilità e eredità senza determinismi, il giardino come luogo di cura riannoda terra e memoria. Insomma, è un’opera che consigliamo di leggere assolutamente e che grazie alla scelta di alternare capitoli brevi e lunghi rende la lettura scorrevole senza perdere profondità.
È un romanzo che invita a ripensare il peso delle parole e il valore del tacere: a volte il gesto più sonoro che possiamo compiere è ascoltare.