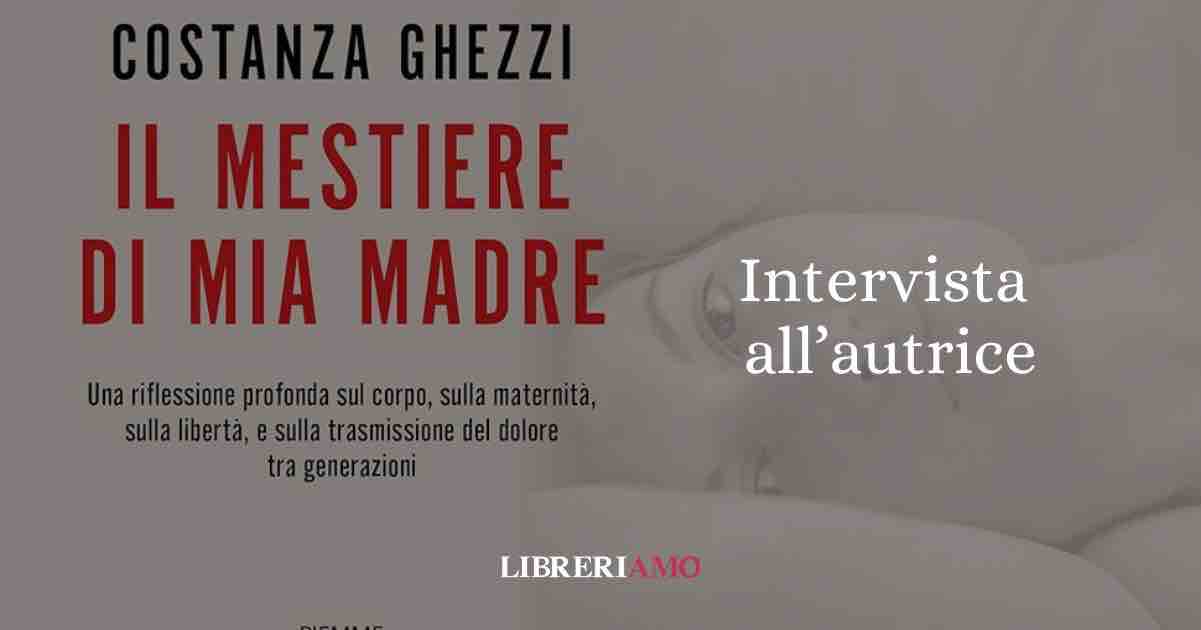“Il mestiere di mia madre”, esordio di Costanza Ghezzi, è uno di quei libri che riportano alla luce le ferite e le rinascite delle donne italiane del dopoguerra, restituendo alla parola “libertà” il suo significato più autentico e più scomodo: quello di una conquista che si paga cara.
Attraverso due protagoniste, Lucetta e Flaminia, madre e figlia separate da un destino ma unite da un amore feroce e incomprensibile, Ghezzi costruisce un romanzo di formazione, un racconto di emancipazione e un atto d’amore verso tutte le donne che, in silenzio, hanno dovuto inventarsi da zero.
Con una scrittura cinematografica, empatica e lucida, “Il mestiere di mia madre” (edito da Piemme) si inserisce nella tradizione della narrativa femminile italiana più profonda, quella di Elsa Morante, Lalla Romano, Donatella Di Pietrantonio, ma con una voce nuova, che guarda al passato senza indulgere, e al presente con un senso di giustizia poetica.
“Il mestiere di mia madre” di Costanza Ghezzi
“Il mestiere di mia madre” è un romanzo che attraversa generazioni, geografie e silenzi, per ricordarci che la libertà femminile non nasce da un gesto eroico, ma da una serie di scelte quotidiane, spesso invisibili e solitarie.
Con la sua prosa limpida e visiva, Costanza Ghezzi costruisce un ponte tra la memoria e il presente, tra la miseria e la grazia, tra la colpa e la redenzione.
Lucetta e Flaminia non sono solo personaggi: sono archetipi di una femminilità che rifiuta la pietà e sceglie la verità, anche quando fa male. Questo romanzo ci insegna che il “mestiere” più difficile, e più necessario, resta quello di diventare sé stesse.
Il romanzo
“Il mestiere di mia madre”, esordio narrativo di Costanza Ghezzi, è uno di quei libri che lasciano un segno profondo: un racconto di formazione al femminile che attraversa l’Italia del dopoguerra per indagare cosa significhi davvero sopravvivere, amare e appartenere a sé stesse.
Siamo nella Sicilia del secondo dopoguerra, in una terra dove la miseria si mescola all’orgoglio, e la libertà è un miraggio che si paga caro. Lucetta, la protagonista, è una giovane donna nata “per malasorte” in un luogo che non le somiglia. Dopo un padre morto in guerra, un patrigno violento e un marito rozzo e possessivo, comprende che l’unica possibilità di salvezza è fuggire.
Così, quando incontra Gregorio Palermo, uomo di città, le basta un’occhiata per capire che quella è la sua occasione: lascia tutto e parte per Roma, decisa a fabbricarsi da sola la propria fortuna. Ma Il mestiere di mia madre non è solo la storia di Lucetta. È anche, e forse soprattutto, quella di Flaminia, sua figlia, cresciuta in un istituto di suore, nutrita di abbandoni e di attese.
Ogni mese Lucetta torna, bellissima e inafferrabile, la porta a mangiare una carbonara e poi sparisce di nuovo, inseguita da uomini e da voci maligne. Le suore la giudicano, la condannano, ma Flaminia la osserva con un misto di rabbia e devozione, incapace di comprendere dove finisca la madre e dove cominci la leggenda che la circonda.
Ghezzi racconta queste due figure femminili con una voce viva, sensuale e cinematografica. La sua scrittura ha un ritmo pulsante, alterna la grazia al furore, e restituisce in modo autentico la forza delle donne che hanno dovuto reinventarsi in un mondo che non concedeva loro spazio. Lucetta è un personaggio magnetico: peccatrice e santa, fragile e indomita, una donna che rifiuta la morale imposta e sceglie la propria strada, anche a costo della vergogna.
Flaminia, invece, rappresenta l’altra metà della medaglia: quella che cerca di comprendere, di perdonare, di riconoscere in quella madre irraggiungibile un frammento di sé. Il romanzo attraversa due Italie, quella rurale e immobile della Sicilia e quella febbrile e affamata di Roma nel dopoguerra, con un linguaggio che fonde oralità e lirismo. Ghezzi ha la capacità rara di trasformare la miseria in poesia, di rendere epici i gesti quotidiani.
Le sue pagine sono abitate da personaggi secondari vividi, da dialoghi vibranti e da descrizioni che sembrano incise nella luce meridionale. Ma ciò che rende Il mestiere di mia madre così potente è la sua dimensione universale. È una storia che parla di libertà e di colpa, di amore materno e di desiderio di riscatto.
Lucetta e Flaminia incarnano due generazioni di donne che, pur separate da un destino crudele, sono unite da una stessa urgenza: esistere senza chiedere permesso. Il “mestiere” del titolo diventa allora una metafora: non è soltanto quello della madre che sopravvive vendendo il proprio corpo, ma quello di ogni donna che impara a costruirsi un’identità, a prezzo del giudizio altrui.
Con questo romanzo, Costanza Ghezzi si impone come una voce nuova e necessaria della narrativa italiana contemporanea. Il suo stile è corposo, empatico, vibrante di pietà e di rabbia. Ci regala due protagoniste che rimangono nel cuore: una madre splendida e terribile, una figlia mite e ferita, entrambe in cerca di un modo per amare e perdonare.
“Il mestiere di mia madre” è un viaggio tra le ombre e le luci della femminilità, un romanzo che unisce il realismo di Elsa Morante alla sensibilità contemporanea di Donatella Di Pietrantonio, raccontando la libertà come un gesto scandaloso e necessario. Una storia che profuma di terra e di mare, di peccato e di redenzione, e che ci ricorda che, a volte, diventare madri e diventare sé stesse sono la stessa, ardua conquista.
Intervista a Costanza Ghezzi
Lucetta è una donna che sfida le regole del suo tempo, una figura insieme scandalosa e fragile. Come è nata l’ idea di questo personaggio e quanto ha attinto alla realtà o alla memoria personale?
L’idea di Lucetta nasce da un personaggio reale, la madre di una mia amica. È stata questa amica, un giorno di quattro anni fa, a raccontarmi la storia della sua famiglia e a chiedermi di scriverla. Ricordo ancora le prime emozioni: sono rimasta subito colpita un po’ da tutto, ambientazioni e personaggi, cadute e ascese, e soprattutto dall’accoglienza della mia amica nei confronti di sua madre.
Raccontava con un tono di voce sereno e pacificato anche episodi durissimi. Il mio lavoro si è basato su quel racconto che mi sono sentita libera di romanzare, facendo vivere con me i personaggi, ascoltando le loro voci. La mia più grande soddisfazione sono state le sue parole quando ha letto il libro finito. Le conservo come un dono prezioso.
Il romanzo attraversa due Italie molto diverse: la Sicilia rurale e la Roma del dopoguerra. Quanto la geografia, con i suoi contrasti, ha influenzato il destino delle sue protagoniste?
La geografia è a un tempo fondamentale e accessoria, nel senso che non volevo fare un romanzo sociale ma raccontare una relazione. Naturalmente, le relazioni si svolgono in contesti sociali e storici particolari e i personaggi del libro sono condizionati nella loro adesione o ribellione al tempo e alla geografia in cui agiscono.
Ma a me stava a cuore soprattutto indagare la natura di queste personalità, e in questo ho cercato di andare a fondo senza mai essere troppo indiscreta su altri aspetti della loro vita interiore o sociale. La relazione era al centro del mio interesse. Per risponderle sulla Sicilia rurale e la Roma del dopoguerra mi sono anche appoggiata a storie personali della mia famiglia e di altre amiche. Quella era un’Italia molto dura, per la quale non mi capacito di sentire una qualche nostalgia.
È il lato romantico che cerco si silenziare ogni volta che posso. Per questo nella scrittura mi sono data la disciplina di non indulgere mai verso il passato e ho cercato di raccontarlo in modo distante, spogliandolo di ogni sentimentalismo. C’è una critica, certo, verso il mondo maschilista e violento del Dopoguerra, ma è una critica non troppo rabbiosa o sprezzante, è una critica fredda, quasi nello spirito di una cronaca.
Madre e figlia sembrano vivere due vite parallele, unite da un filo di silenzio e incomprensione. Che tipo di amore lega Lucetta e Flaminia?
È possibile amare davvero senza capirsi? Non credo che Lucetta e Flaminia non si capiscano. Piuttosto credo che non si cerchino e rappresentino nel modo in cui si suppone che le persone debbano cercarsi e rappresentarsi l’un l’altra. La loro relazione rompe lo schema normativo che popola il nostro immaginario madre/figlia, cioè, con la supposta naturalità di un rapporto che se non segue la norma è patologico.
Per me non è così. Esiste la varietà e può essere accolta. Tutto ciò che non mi uccide mi fa crescere, diceva Nietzsche. Quando si proietta un canone di come un rapporto dovrebbe essere c’è sempre il rischio di esaltazioni e di delusioni: ma non è il loro caso. Proiezione e distanza cerebrale non attenuano i loro sentimenti, semmai – e questo credo sia la particolarità del romanzo – generano un tipo di affetto più curioso e intrigante, non intimo e non invasivo. Cercare di capire l’altra persona significa rispettarla.
Non esiste un canone dell’esser madre o dell’essere figlia. Nella mia vita privata sono anche madre e spesso mi chiedo se sto facendo la cosa giusta con i miei figli. Ma è una domanda che cerco di non caricare di troppo peso e di superare con il senso dell’umorismo.
“Il mestiere di mia madre” è anche un racconto sull’emancipazione femminile in un’Italia che ancora non permetteva alle donne di scegliere. C’è un messaggio che vorrebbe arrivasse alle lettrici di oggi?
Mentre scrivevo non ho pensato specificamente a quello. Ho pensato all’emancipazione e alla libertà della persona umana e al fascino dei ribelli. Anche lo schiavista è schiavo dello schiavismo. Non è un ribelle, è un conformista che detesta la libertà. Un uomo che cerca una schiava si perde l’occasione di avere accanto una donna libera e di essere libero lui stesso. Lucetta è ribelle e libera, tuttavia non è il mio ideale di persona.
Flaminia mi è più vicina: è una persona che sa fare i conti con la realtà senza rimanerne schiacciata. Sa guardare avanti e il suo orizzonte è quello della gentilezza d’animo. Se invece di aver scritto il libro, lo leggessi per la prima volta, forse accoglierei la sua domanda di una storia di emancipazione e alle lettrici direi che c’è ancora molto da fare nella cultura e nella scuola e in ogni ambito per creare una vera cultura dell’uguaglianza e delle pari opportunità.
E della pari dignità. E di una cultura del rispetto della libertà. Proprio ieri la mia amica Isabel Herguera ha partecipato a un foro sulla partecipazione delle donne ai bandi culturali nei Paesi Baschi. Qualche mese fa, il Governo Basco ha provato a fare un bando senza quote per le donne, pensando che la situazione fosse già culturalmente paritaria. Si sbagliavano: la partecipazione è stata quasi solo di maschi. Insomma, c’è ancora molto da fare per cambiare modo di pensare. Non bisogna adagiarsi sugli allori: c’è ancora molta gentilezza d’animo da promuovere nei cuori.
Il titolo è potente e ambivalente: “ Il mestiere di mia madre” è quello del corpo, ma anche quello della sopravvivenza. Quando ha capito che sarebbe stato il titolo giusto per la storia?
Fare il mestiere significava prostituirsi. Il titolo è nato il primo giorno, quando la mia amica per la prima volta mi raccontò la storia di sua madre. Non l’abbiamo più cambiato, né lo ha fatto la casa editrice. Sono ancora convinta che sia un ottimo titolo.
Nei suoi capitoli convivono miseria e poesia, ferocia e tenerezza. Com’è riuscita a trovare l ’ equilibrio tra la durezza della realtà e la grazia del linguaggio?
Quella sono io o, almeno, ero io nei giorni in cui scrivevo. Posso riconoscermi nella parte della domanda che si riferisce alla durezza della realtà e alla grazia del linguaggio e la ringrazio per il generoso complimento. Non mi riconosco del tutto nella miseria e poesia, e forse neppure nella ferocia e tenerezza.
Nel romanzo ci sono violenze, brutalità e forse sì anche un po’ di miseria umana, ma fanno parte di un modo di pensare e comportarsi che appartengono a tipologie di persone per le quali sentivo più pena che disprezzo o odio. Sul linguaggio: per scrivere il romanzo ho usato un tavolo bianco, sgombro, e ogni tanto guardavo due quadretti piccoli sul muro cercando di non guardare mai alle mie spalle dove si trovano grossi quadri, la libreria, i divani e pile di libri da leggere.
Tutte cose che smuovono troppo le mie emozioni e mi inducono a usare superlativi. Forse, proprio quel tavolo e quel muro bianchi hanno determinato il colore del mio linguaggio.
Flaminia è una delle voci più delicate e dolenti del romanzo. È lei, in fondo, che ci consegna la possibilità del perdono. Quanto le è costato scriverla?
Immaginare e scrivere Flaminia non mi è costato uno sforzo particolare: dal primo giorno penso di averne inquadrato lo spirito e personalità. Ho provato una simpatia immediata, nel senso greco di syn pathos, affinità d’emozione. La sua sensibilità, comunque, ha qualcosa della mia amica, qualcosa di me, e qualcosa di come mi piacerebbe essere.
Dicono che scrivere sia fare autoritratti. Beh, non credo che sia così sempre, ma qualcosa di vero c’è. A me proprio non riesce di escludermi nella mia scrittura o, come dicono, fare esercizi di stile. Quando per sfida con me stessa ho provato a imitare la scrittura di qualcun altro, ho fallito: finivo sempre per rispecchiarmi. Meglio rimanere sé stesse, e non aver paura di mettere a nudo anche le nostre paure, bassezze e pigrizie. Fa parte delle regole del gioco: comunicare significa confessarsi.
Il romanzo è attraversato da figure maschili violente o assenti, ma anche da uomini che diventano occasioni di fuga. Crede che la libertà delle donne passi ancora oggi attraverso lo sguardo degli altri?
Una cosa è l’Europa, altra cosa è il mondo. Una cosa sono le classi con una educazione elevata e mezzi economici solidi e una cosa le classi umili. Una cosa è crescere in una famiglia e in una società laica e altra cosa in un contesto religioso. Una cosa è nascere in una famiglia che ama i libri e altro è crescere in una famiglia che non ama i libri.
Osservando il mondo, vengono i brividi. Siamo ancora alla preistoria della pari dignità e del rispetto per la libertà delle donne. Anche i dati europei sono, comunque, avvilenti. Le donne fanno una maggior fatica ad affermarsi. Sono ancora considerate da milioni di persone, come esseri umani di serie B. Decine di migliaia sono ancora normalmente picchiate, ridicolizzate, umiliate, violentate.
E anche giudicate per la loro condotta sessuale. Sono passati cinquanta anni da quando si è cercato di scalfire la cultura plurimillenaria della supremazia maschile. Ma la resistenza mentale è ancora grande in troppe persone. Il mondo conserva ancora tracce di questa supremazia e, come dice Simone de Beauvoir, dell’appropriazione del neutro da parte dei maschi.
I tasti del pianoforte sono fatti per le dita maschili. Il dosaggio dell’aspirina è fatto per il corpo maschile. La forza necessaria per aprire una bottiglia d’acqua è quella naturale di un maschio. Per la donna, l’adattamento è un pochino più difficile in tutto.
Ed è anche chiaro che se l’uomo è il riferimento, ad esempio, di come si cammina correttamente, il modo di camminare della donna viene percepito come ridicolo. E ci sono quelli che ridono vedendo camminare le donne, come fossero scimmie.
I microtraumi e le umiliazioni quotidiane per una donna sono sempre dietro l’angolo, e spesso provengono dalle persone più inaspettate, come gli sguardi molesti che molti uomini si sentono in diritto di rivolgere alle donne.
Il suo stile è estremamente visivo, quasi cinematografico: si muove per scene, dettagli, ritmi. Ha immaginato la storia anche come una potenziale sceneggiatura o adattamento visivo?
Mentre scrivevo ero presa dal solo romanzo e non pensavo a un adattamento cinematografico, però, mi immaginavo scene, volti, voci, e suoni, vestiti, arredamenti. E poi ho immaginato i paesaggi e i silenzi e i sogni dei personaggi.
Qualche volta mi sono anche immaginata delle musiche e ho messo su qualche vecchia canzone del tempo per ispirarmi. Quello del cinema è un mondo che non conosco anche se ho una coppia di amici che si dedicano ai film di animazione e mi sembrano molto felici. Penso che sì, da questa storia potrebbe venire fuori un film profondo e originale.
“Bisogna fabbricarla da sé, la fortuna”, dice Lucetta. È questa la frase che riassume il romanzo? O, secondo lei, c’è un ’ altra parola che definisce meglio il cuore della storia?
La frase che lei ha citato racchiude la filosofia di Lucetta e può sembrare brutale, ma in realtà riflette la consapevolezza, che sarà poi anche di Flaminia, che la possibilità di essere felici passa da noi stessi e solo noi possiamo renderci liberi. Altre parole: la comprensione e il rispetto.
Comprensione e rispetto che Flaminia cerca con determinazione e che riesce a raggiungere diventando adulta. Un altro concetto importante: non fare del passato un fardello. Ci si può voltare ogni tanto e scorgerlo dietro le spalle, ma l’importante è proiettare in avanti la mossa successiva.