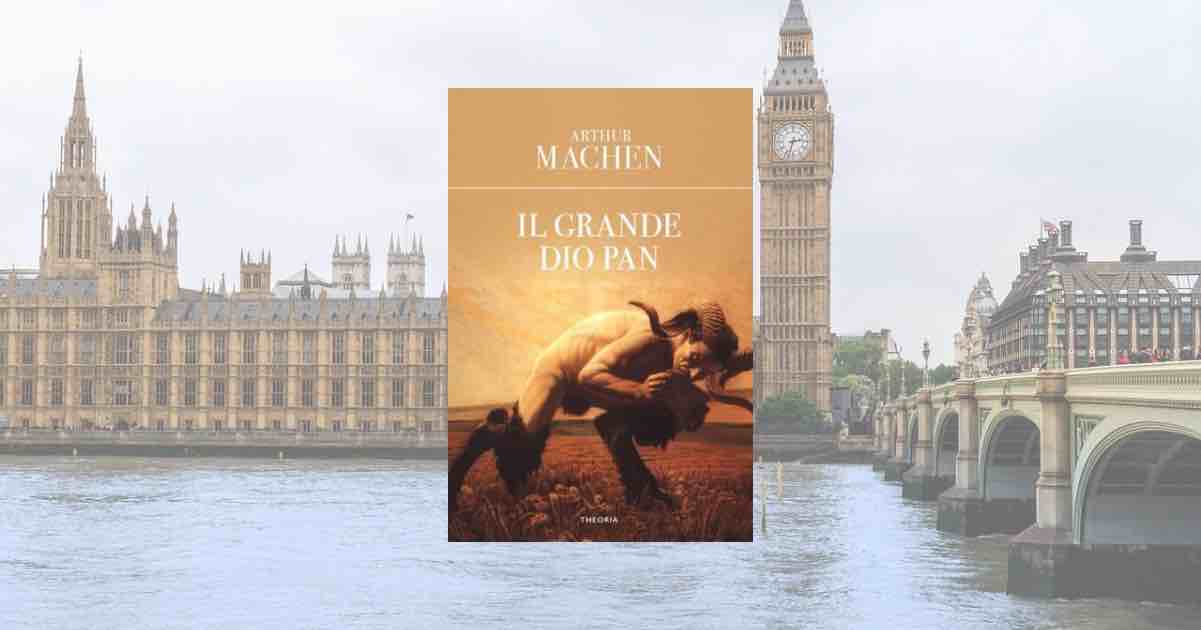C’è un brivido che non ci lascia mai, e che a pochi passi da Halloween si fa sentire: non è il grido sguaiato del mostro, ma il sospetto. Il sospetto che esista una crepa, sottilissima, proprio dietro la carta da parati, pronta ad aprirsi per far passare qualcosa di immensamente più antico e oscuro di ogni diavolo cristiano.
Pochi libri hanno saputo dare la forma esatta a quella fessura come “Il grande dio Pan” (1894) di Arthur Machen: un racconto lungo che non si accontenta di mostrare l’orrore, ma lo inocula sotto la pelle; non spiega il pagano, lo lascia filtrare nella nostra realtà.
La Londra fin-de-siècle, con le sue certezze scientifiche e la sua morale ferrea, si illudeva di aver domato la natura. Ma Machen dimostra che basta un esperimento maldestro, un solo taglio sul velo della mente, per spalancare una porta; da quella porta entra l’Arcadia primordiale — selvaggia, sessuale, amoralmente fertile — che dilaga nei salotti e nei bassifondi della città.
È un orrore urbano e pagano, femmineo e perturbante, letterario fino all’ossessione; e letto oggi suona perfino più moderno di ieri.
Non stupisce che Stephen King lo consideri “uno dei più grandi racconti horror della lingua inglese di tutti i tempi” e che vi abbia attinto per “N.” e “Revival”: l’idea-madre è proprio questa porta che si spalanca dove credevamo che il mondo fosse chiuso.
“Il grande dio Pan”
Machen apre le danze con un vero e proprio manifesto dell’orrore ontologico: un medico di stampo “illuminista”, Raymond, si avventura in una terrificante operazione sul cervello di una giovane donna con l’obiettivo di “sollevare il velo” e costringerla a vedere la dimensione che sta oltre il sensibile. L’esperimento, prevedibilmente, fallisce: la ragazza precipita nella follia.
Da qui, il romanzo (strutturato come un mosaico di lettere e testimonianze che si inseguono) salta avanti negli anni e ci porta nella Londra moderna. Qui si muove una figura femminile magnetica e inafferrabile, Helen Vaughan, che attraversa indisturbata salotti e bassifondi. Ogni suo passaggio lascia una scia oscura: suicidi inspiegabili, crisi isteriche, quadri indicibili, esistenze intere distrutte. La sua natura esatta, la sua origine non umana, è la vera e inquietante indagine che si cela dietro le pagine.
H. P. Lovecraft, che a Machen deve l’architettura della sua cosmic horror, definì perfettamente il metodo narrativo: “Nessuno potrebbe render conto dell’accumularsi di suspense e dell’orrore ultimo con cui ogni paragrafo abbonda senza seguire l’ordine preciso degli indizi graduali che Machen dispiega”. È una “stregoneria narrativa” che si fa strada per piccole, incessanti scosse, fino all’agghiacciante svelamento finale.
Filosofia della fessura
“Il grande dio Pan” è molto più di un racconto dell’orrore: è una spaventosa ipotesi sulla natura stessa del reale. Machen suggerisce che il mondo non sia affatto una superficie chiusa e stabile, ma una sottile membrana. Non appena la si forza — con la hybris della scienza, l’eccesso del desiderio o l’arte che vuole vedere troppo — questa membrana si lacera; e dalla fessura si riversa un principio attivo, un’eccedenza più antica e indifferente alla nostra morale.
Lo chiamiamo “Pan” solo per comodità, ma è l’idea della natura indomabile: non Bene e non Male, ma la forza selvaggia che precede il linguaggio. L’esperimento del medico Raymond è la nostra arroganza moderna che tenta di scrutare l’ignoto; e Helen Vaughan è la prova vivente che il pagano non muore, ma semplicemente cambia stanza.
Da qui l’angoscia contemporanea del libro: ciò che irrompe non è un mostro da sconfiggere, ma il mondo com’era prima di noi, e che attende di tornare.
Perché fece scandalo nel 1894
All’uscita, “Il grande dio Pan” venne considerato indecente, decadente, pericoloso. La stampa lo bollò come “incubo incoerente di sesso” (Westminster Gazette), “il più acutamente e intenzionalmente sgradevole che abbiamo mai visto in inglese” (Manchester Guardian), “granguignolesco, macabro e noioso” (Lady’s Pictorial).
L’art-critic Harry Quilter, sulla Contemporary Review, lo chiamò “una storia perfettamente abominevole”, accusando Machen di seminare nefandezze oltre le parole e invocando addirittura un giro di vite censorio contro editore e autore.
La violenza delle reazioni dice molto del testo e del suo tempo. Sotto la superficie di scandalo morale, Pan tocca le ansie del fin de siècle: il crollo delle certezze positiviste, il “ritorno del pagano” nella città industriale, la minaccia della “New Woman” che rompe i ruoli. Non stupisce che la copertina di Aubrey Beardsley contribuisse all’effetto dirompente, né che solo decenni dopo — negli anni Venti — la critica abbia riconsiderato Machen come classico dell’orrore.
Oltre il gotico: Machen e la nascita del “weird”
Machen appartiene a quel momento in cui il gotico cede il passo a qualcosa di nuovo: il weird — la prima onda — dove l’orrore coincide con una crepa ontologica più che con un mostro tradizionale.
Lovecraft lo mette in cima al suo canone, e non solo per Pan: “Il fascino del racconto sta nel modo di raccontarlo… il lettore sensibile arriva alla fine con un brivido riconoscente”; e ancora: la figlia “non umana” di Helen, gli ibridi, la topografia pagana del Galles e di una Londra scavata da culti sotterranei segnano l’immaginario di “Il richiamo di Cthulhu” e “L’orrore di Dunwich”.
Gli studiosi sottolineano come Machen getti un ponte tra rovine romane e metropoli moderna, tra folklore gallese e ansie metropolitane: la “porta” si apre nei boschi, ma l’epidemia di suicidi accade nei club e nelle vie di Londra. È la geografia doppia del weird.
Il cuore nero: desiderio, genere, potere
Al centro arde Helen Vaughan: creatura di fascinazione e rovina, artista della catastrofe intima altrui, femme fataleche dissolvendo i confini del corpo smonta il genere come costruzione. Da qui l’antico scandalo: non è (solo) pruderie vittoriana, ma paura che il sesso sia una porta cosmica, che il femminile sia soglia e non contenitore.
Critiche femministe hanno riletto il testo come campo di battaglia tra il discorso medico-maschile — che “apre il cranio” per vedere oltre — e una energia altra che non si lascia dissezionare: la soggettività di Helen diventa l’arma con cui l’ordine patriarcale viene intaccato.
Non è un caso che vari critici abbiano visto in Pan un precursore non dichiarato di Dracula: sequenza di eventi solo apparentemente slegati che convergono su un agente maligno unico; paura di sesso, donne, alterità; epilogo ambiguo. Un dossier d’indizi che sottrae, più che spiegare.
Come funziona la paura: tecnica e ritmo
Il genio di Machen non risiede in ciò che ci mostra, ma in ciò che decide di nasconderci: l’autore non descrive mai direttamente il mostruoso, ma ne lavora l’ombra, costringendoci a intuire l’orrore dalle reazioni distorte di chi lo ha incrociato.
Un volto che si deforma alla semplice vista di “qualcosa” nel bosco; un artista che, dopo un incontro misterioso, dipinge tele di sabba infernali e indicibili: è così che la minaccia si manifesta, per riflesso e per contagio.
Lovecraft, grande estimatore e debitore di Machen, insistette sulla forza della cumulazione: non c’è un singolo, grande colpo di scena, ma una marea nera di indizi che sale progressivamente, tassello dopo tassello. L’effetto finale è una “stregoneria narrativa” che trasforma quelle che i critici contemporanei definirono “coincidenze forzate” in un unico, maligno incantamento.
È un’estetica dell’allusione, un meccanismo più vicino al crescendo di un notturno musicale che al gore esplicito. Ed è esattamente questo approccio “freddo” e mentale a rendere Machen un maestro che ha insegnato al terrore di tutto il secolo successivo.
Il dio prima del diavolo
Per capire l’immaginario di Machen bisogna guardare al Pan originario. Nella mitologia greca, Pan è dio dei pascoli e dei boschi, metà uomo metà capra, legato a musica, fertilità, sessualità, a volte crudele nei suoi inseguimenti. È un dio arcadico, rustico, più vicino alle grotte che ai templi. Da lui deriva l’etimologia di “panic”: la paura improvvisa che aggredisce chi si smarrisce in luoghi selvatici.
C’è poi la leggenda antica registrata da Plutarco: durante il regno di Tiberio, un marinaio udì una voce ordinargli di annunciare a riva: “Il grande dio Pan è morto”. La storia, riletta dai primi cristiani, diventò simbolo della fine del paganesimo e della nascita di un nuovo mondo. Machen scrive proprio lì: nel punto in cui il pagano non è affatto morto, ma dorme, pronto a filtrare nel presente come contaminazione.
Lettura politica
La vera intelligenza di Machen sta nell’evitare l’allegoria rigida: Pan può essere letto come critica alla hybris scientifica — il chirurgo che “gioca con energie che non capisce”; come parabola anti-moralistica — la morale reprime ma non dissolve il sacro oscuro; come storia di una città che copre sotto la civiltà antiche caverne.
L’effetto non è tesi, ma ambivalenza radicale: Pan è natura primordiale, ma anche idea; è corpo, ma anche linguaggio; è simbolo—dirà un personaggio—di “forze così terribili che l’anima dell’uomo deve appassire e morire”. È il perturbante freudiano prima di Freud, la cosmic horror lovecraftiana prima di Lovecraft.
La ricezione postuma: da Lovecraft a King, passando per il cinema
Dopo l’onda d’urto del 1894, Machen fu rivalutato nel Novecento. Lovecraft lo canonizza in Supernatural Horror in Literature, influenzandone a sua volta la generazione. Nel secondo Novecento e nel contemporaneo, Stephen King non smette di citarlo: “N.” è definito da lui “un riff su Machen”, “Revival” riprende l’idea dell’esperimento che spalanca l’Altrove. Il suo giudizio resta definitivo: “Il grande dio Pan” è vertice assoluto del terrore letterario.
Sul versante visuale, studiosi di cinema hanno osservato come la figura del fauno ambiguo e potenzialmente minaccioso — lontana dal domestico Mr. Tumnus — abbia ispirato Guillermo del Toro nel delineare il suo “Il labirinto del fauno” — ossia “Pan’s Labyrinth”: il titolo inglese accentua proprio quel dialogo con la tradizione fin-de-siècle che include Machen
Perché questo classico vittoriano dovrebbe finire sul vostro comodino proprio oggi?
La risposta è nella sua sconcertante modernità. “Il grande dio Pan” parla la nostra lingua: è un testo su corpi e identità in perenne metamorfosi, sulla scienza usata come strumento di desiderio e sulla città intesa come teatro del sacro che attende solo di riemergere. In parte si accosta a “Povere creature” di Alasdair Gray, in parte costeggia le opere di King e quelle di Lovecraft.
È una meditazione sul prezzo che siamo disposti a pagare per la conoscenza, e su ciò che scegliamo di vedere, o ignorare. A questa profondità tematica si aggiunge la sua forma avanguardistica: la costruzione a dossier (voci che si inseguono, testimonianze che combaciano a scatti) anticipa le narrative investigative e il true crime, ma lo fa ponendosi al servizio dell’indicibile anziché della spiegazione razionale.
Infine, è l’orrore “freddo” che Halloween esige: c’è carne e sangue, certo, ma la paura che distrugge è mentale, ontologica. È il gelo che non ti fa urlare, ma che ti costringe a dubitare che il mondo sia davvero come lo vedi. Come disse Lovecraft, “le eventuali imperfezioni si dissolvono di fronte alla sua stregoneria d’insieme”.
Obiezioni e punti deboli
Chi si avvicina a Machen per la prima volta può imbattersi in alcune resistenza strutturali: una prosa ottocentesca che privilegia l’allusione all’azione esplicita, e una serie di coincidenze narrative a volte troppo comode. Sono difetti riconosciuti, persino da Lovecraft, che tuttavia difendeva il “potere d’insieme” dell’opera.
Il nodo più problematico — e per questo intellettualmente più stimolante — risiede però nel rapporto tra sesso e genere. La demonizzazione del desiderio femminile e dell’androgino riflette senza filtri le ansie repressive dell’epoca vittoriana. Leggere “Il grande dio Pan” oggi significa guardare quelle paure all’opera, farne critica, comprenderne l’origine storica e, nonostante ciò, lasciarsi ancora agghiacciare dalla sua forza oscura.
Chi è, in fondo, il “Grande Dio Pan”?
Dimenticate il diavolo cristiano e il satiro libidinoso dei fumetti. Per comprendere la reale portata dell’orrore di Machen, bisogna risalire al Pan originario. Pan non è un’entità malvagia, ma la natura quando la si guarda troppo da vicino: una forza fertilissima e ferina, armonica e predatoria, che rappresenta il fuori che irrompe improvvisamente nel dentro della civiltà.
I Greci lo veneravano in grotte e balze, fuori dalla polis; gli antichi etimologi legarono il suo nome non solo al “pastore”, ma anche all’etimologia stessa del panico: quel terrore cieco che afferra all’improvviso chi si smarrisce nei luoghi selvatici.
È qui che Machen innesta il suo incubo. Egli rievoca la leggenda registrata da Plutarco, secondo cui una voce annunciò ai marinai: “Il grande dio Pan è morto”. Una storia che, riletta dai cristiani, simboleggiò la fine del paganesimo. Ma Machen ci svela l’agghiacciante verità: il selvatico non è affatto morto; dorme, pronto a filtrare. La sua risposta è netta e finale: non lo abbiamo sepolto, gli abbiamo solo dato un’altra porta per tornare tra noi.