“Giornale di uno straniero a Parigi”: il ritorno di Malaparte nella città amata
“Giornale di uno straniero a Parigi” (1947-49) scritto da Malaparte. Il ritorno nella “seconda patria”, tra salotti e periferie. Uno sguardo feroce e lirico.
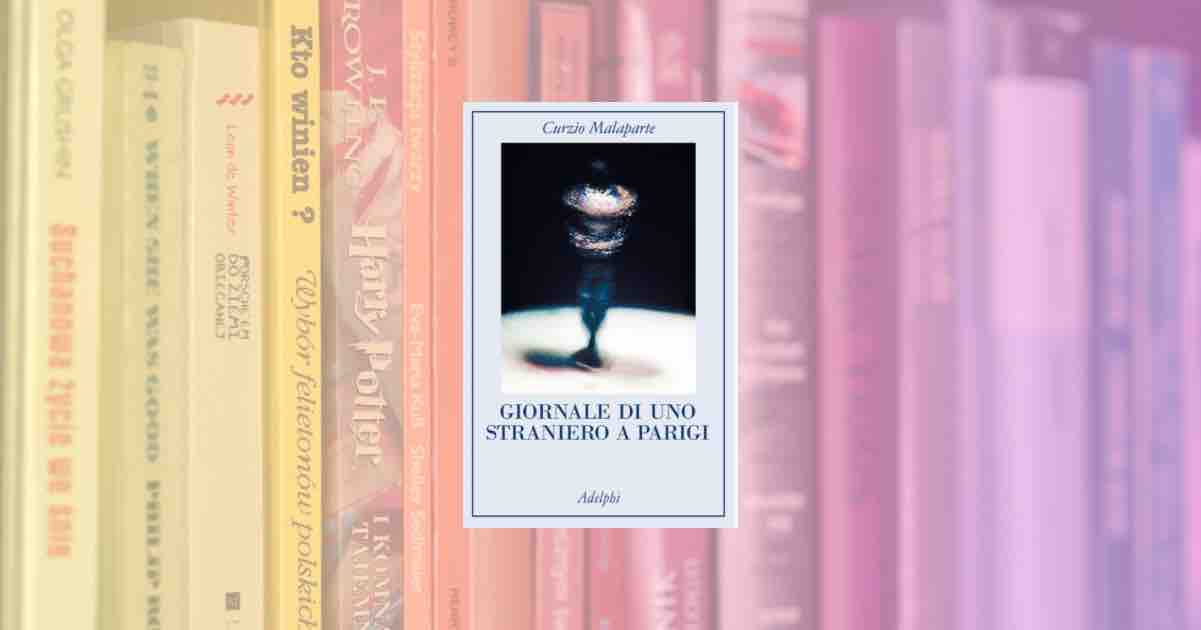
Nel 1947 Curzio Malaparte torna a Parigi dopo quattordici anni di assenza; tuttavia egli lo definisce un “esilio”: è come se la Francia fosse la sua seconda patria — una patria “anzitutto letteraria”. Il diario che tiene fra il giugno del ’47 e la fine del ’49 – postumo dal 1966 – è il ritratto di una città che ama e che allo stesso tempo lo respinge, quello di uno scrittore che tenta di rientrare in un sistema di relazioni culturali che non lo riconosce più.
Proprio in questi giorni, Adelphi lo ha riproposto in una nuova edizione italiana (curatissima), e noi di Libreriamo siamo certi che sia l’occasione perfetta per puntare di nuovo l’obbiettivo su un autore controverso e magnetico come lui.
“È in virtù di Chateaubriand che, talvolta, mi sento francese”. Una dichiarazione di poetica e di fedeltà culturale.
Un’opera postuma, un tempo preciso
La genesi editoriale
Il diario fu pubblicato postumo da Vallecchi nel 1966, a cura di Enrico Falqui; all’epoca Malaparte era già morto da qualche anno (1957). La nuova edizione Adelphi (edita a fine ottobre 2025) riporta in catalogo un libro che, nel frattempo, ha avuto una seconda vita internazionale: dalla traduzione francese del 1967 (Denoël) all’edizione inglese NYRB del 2020, curata sulle versioni italiana e francese.
Il calendario del racconto
Le pagine coprono il biennio 1947–1949: il ritorno dopo guerra, carcere e confino; il tentativo di riprendere un dialogo con i salotti e con gli scrittori della rive gauche.
Il tempo del libro è quindi quello dell’immediato dopoguerra, con una Parigi stanca e ancora divisa, a cui Malaparte contrappone il suo sguardo “da straniero di due patrie”.
Di cosa parla: un diario di incontri e ferite
Salotti e periferie, Camus e i cani
Il “Giornale di uno straniero a Parigi” è un registro di incontri: Jean Cocteau, diplomatici, attori, giornalisti. Ma anche infermiere sul quai de l’Oise, ragazzini in piscina, baristi, cani. Le pagine alternano il ritratto glamour allo scarto di compassione per i vinti del dopoguerra.
Emblematico l’episodio con Albert Camus: l’accoglienza è fredda, quasi ostile; Malaparte immagina l’autore de “La Peste” pronto a fargli pagare il passato fascista. “E mi confermai nella idea che Camus volesse farmi fucilare per provare a sé stesso d’esser capace di atti eroici etc. – scrive, figurandosi Camus — “E mi figurai la scena: io bendato, legato sopra una sedia, al poteau d’exécution, e Camus solo davanti a me, con un fucile in mano”. La scena, più teatrale che realistica, dice bene la frattura morale che lo separa dagli esistenzialisti.
Accanto ai grandi nomi ci sono i cani, compagni di una bizzarra liturgia notturna: Malaparte racconta di mettersi ad abbaiare con loro. “Non mi piace che mi si prenda per un eccentrico. Credo non vi sia nulla di più naturale, quando si amano i cani, che abbaiare con loro”, ribatte a un pranzo con André Lichtwitz. Grottesco? Forse. Ma è il modo dello scrittore di dire: in questa città mi parlano gli animali, non gli uomini.
E, dopotutto, cosa può esserci di più grottesco dopo aver letto di un finto parto nella Napoli occupata dagli Alleati, o della sirena che viene servita a tavola come un pesce qualunque? Malaparte è uno scrittore che sorprende, vero, ma lo fa sempre con una ragione.
L’“io” che naufraga
Adelphi sintetizza il punto con lucidità: questo è il racconto di un “io destinato al naufragio” in un’epoca che non gli appartiene più. I salotti che un tempo lo ammiravano sono “un riverbero del passato”; negli sguardi di Mauriac coglie “un oscuro rimprovero”, in quelli di Camus “incomprensione se non odio”. Il sospetto di collaborazionismo pesa sul suo rientro, benché la biografia politica di Malaparte sia tortuosa e mai pacificata.
Malaparte a Parigi: seconda patria, patria impossibile
La Parigi reale del dopoguerra
Il contesto urbano è netto: quartieri poveri, volti scavati dalle privazioni, luci che si spengono presto, un’élite culturale che difende i propri confini etici. La critica francese ha notato l’attenzione di Malaparte per le silhouette popolari, soprattutto nelle zone periferiche; il suo è un occhio da reporter che però non rinuncia alla metafora.
Il mito personale
A questa Parigi “vera” Malaparte sovrappone la città mitica dell’adozione letteraria: Chateaubriand come nume, il sogno di una Francia “raffinatissima e intransigente”, l’attrazione per il cielo di Parigi e i colori che Schiaparelli cattura nelle stoffe. È un doppio registro: da un lato la capitale che l’ha formato; dall’altro la capitale che, nel ’47, non può più essere quella di prima.
Come è scritto: diario, teatro, pamphlet
La macchina stilistica
Il libro è una polifonia che mescola dialoghi, schegge liriche, notazioni giornalistiche. L’“io” è protagonista e maschera: Malaparte si mette in scena, spesso si contraddice, talvolta esaspera; ma conosce il mestiere della messa in scena. La prosa barocca e ferina che abbiamo in “Kaputt” o “La pelle” qui si fa più elusiva, ironica, capace di auto-sabotarsi con una posa da clown tragico. Il risultato – ha scritto NYRB nell’edizione inglese – è un modello di “ambigua riserva” e insieme di autoesibizione comica.
Verità, menzogna, letteratura
Che cosa c’è di vero in questo diario? I critici anglofoni hanno ricordato che l’autore “preferisce la bellezza alla verità”, e che spesso l’“io” malapartiano è un personaggio più che un semplice testimone. In questo senso il “Giornale di uno straniero a Parigi” continua a spiazzare: non è memoir puro, non è reportage, è autofinzione prima della parola. Se si accetta il patto, il libro mostra una fedeltà superiore: non ai fatti, ma al clima morale di quegli anni.
Ritratti e scene: cosa resta in memoria
Camus, il processo immaginario
L’episodio con Camus è il più citato perché condensa il senso di processo pubblico che lo scrittore avverte su di sé: la scena mentalmente ricostruita del plotone d’esecuzione dice insieme colpa e vittimismo, lucidità e melodramma. Il lettore può irritarsi; o riconoscere in quella posa la sincerità di un uomo che non rinuncia al teatro per spiegarsi.
Cocteau, il doppio
Con Jean Cocteau il tono è diverso: interlocutore amato e insieme limite di una certa estetica parigina – ipnotica, un po’ autoreferenziale – che Malaparte osserva con gratitudine e sospetto. L’incontro è cifra del suo stare a cavallo tra avanguardia e pamphlet, glamour e strada.
I cani, la notte, l’equivoco
Il tema dei cani – e dell’abbaiare – sconfina nel comico e nel surreale. Ma in controluce è un’allegoria della condizione di esule: l’animale come prossimo, il branco come comunità possibile, l’abbaio come lingua oltre i passaporti. Gli svizzeri lo considerano “indice di costumi licenziosi”; i francesi lo tollerano. La pagina, nella sua assurdità, racconta un’Europa che si riorganizza anche attraverso norme del comportamento.
Seconda patria, giudizio, memoria
Straniero in due patrie
Il nucleo emotivo del libro è la lacerazione identitaria: per la Francia Malaparte è (anche) l’italiano sospetto; per l’Italia è lo scrittore troppo francese. Straniero a Parigi, straniero a casa. In questo paradosso c’è una verità contemporanea: l’appartenenza oggi è spesso plurale e intermittente, e il giudizio politico-morale tende a semplificare biografie contraddittorie. Il diario non assolve e non confessa: espone.
Il processo al passato
La diffidenza degli intellettuali francesi – la si legge nello sguardo di Mauriac, nella freddezza di Camus – restituisce la complessità del dopoguerra: il passato non è un capitolo chiuso, ma un tribunale aperto. Che Malaparte se la cerchi o la subisca, la messa sotto esame è parte integrale della scrittura, che si fa autoritratto a gelatina: nitido e sfuggente.
La città come teatro morale
Il “Giornale di uno straniero a Parigi” è anche un libro sulla città: Parigi come dispositivo che rivela. Le strade, i ponti, i caffè, i teatri, ma pure le zone povere: qui Malaparte esercita l’arte del ritratto rapido, spesso crudele, a volte ricco di tenerezza; disegna tipi, misura costumi, registra trasformazioni. La critica accademica ha sottolineato proprio questa attenzione ai volti e alle silhouette dell’après-guerre, una galleria in cui il moralista incontra il reporter.
Una lingua che brucia: tra invettiva e incanto
L’apocalisse domestica
Il libro si apre (e di tanto in tanto si accende) con immagini apocalittiche: “Che è, che è, che brucia laggiù, che splende laggiù, che abbaglia laggiù, in fondo all’orizzonte? […] Non è una nuvola […] È la faccia di Dio. È la terribile faccia di Dio. È il bagliore fermo, immobile, immutabile, e triste, e cattivo, che è nella faccia di Dio”. Sono lampi retorici che restituiscono il modo malapartiano di trasfigurare il reale: non per ingannare, ma per misurare il trauma del Novecento con una lingua che sopporti l’eccesso.
Aforismi, scarti, crudeltà
A distanza di decenni, la prosa del “Giornale di uno straniero a Parigi” non ha perso mordente. Telerama ricordava come l’autore di “Kaputt” rientri a Parigi “dopo anni di prigione e deportazione” e dichiari: “Sono stato arrestato undici volte in vent’anni”. La posa dell’uomo perseguitato può irritare; ma il registro aforistico – rapido, fermo – è spesso irresistibile.
Ricezione e dibattito: un libro controverso, vivo
Francia e Stati Uniti: le riedizioni recenti
La Table Ronde ne ha tenuto viva la presenza nel catalogo francese; nel 2020 NYRB Classics l’ha proposto al pubblico anglofono (trad. Stephen Twilley, introduzione di Edmund White), generando un piccolo dibattito: tra chi lo ha letto come diario di costume e chi come autoritrattistica spietata, fra perplessità e entusiasmi. Alcuni lettori hanno faticato a entrare nel ritmo, ma riconosciuto la forza della scrittura dal vero; altri hanno notato la tensione continua fra mitopoiesi personale e realtà.
L’episodio-Camus visto dalla critica
Il New Yorker ha ripreso la scena del “processo immaginario” con Camus, leggendola come simbolo del gelo con cui l’ambiente esistenzialista accolse il ritorno di Malaparte. L’episodio non si discute per la sua “verità” fattuale, ma per la verità emotiva: racconta lo scarto fra l’autore e una capitale che non perdona.
Un classico per capire gli anni Quaranta (e noi)
“Giornale di uno straniero a Parigi” è un classico scomodo: non cerca assoluzioni, non chiede sconti, non mente sulla seduzione dell’io. È utile per leggere l’Europa del dopoguerra, l’ambivalenza delle élite culturali, il peso del giudizio. Ma è utile anche per oggi: in un tempo che chiede identità nette, Malaparte ci ricorda che la contraddizione è materia prima della letteratura.