La verità è morta? Galimberti racconta “Le disavventure della verità”
Galimberti traccia la genealogia della verità: dall’etica greca al dominio della tecnica, dove è “vero” solo ciò che ha successo nel suo nuovo saggio.
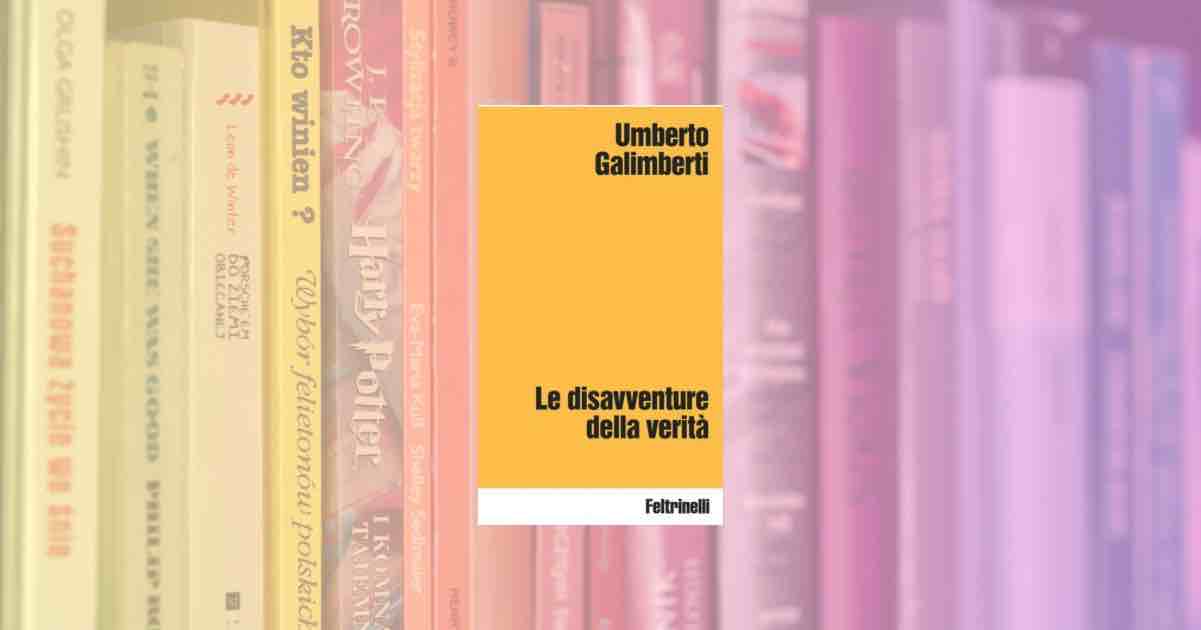
Umberto Galimberti torna su uno dei centri più scivolosi del nostro lessico di base — la verità — e lo fa con un libro breve, nitido, programmatico. Parla di quella verità che “non si insegna”, ma si apprende quasi per osmosi.
“Dire il vero è diventato un atto sovversivo”.
La promessa che ci offre è chiara: una genealogia per capire perché la “verità” è un percorso.
Ma che libro è, davvero?
“Le disavventure della verità”, edito Feltrinelli, collana Idee, non è un compendio scolastico e nemmeno un pamphlet umorale: si pone al prossimo quasi come una mappa che attraversa la storia della parola “verità” nella cultura occidentale. Dall’aletheia greca allo ’emet ebraico, da Platone alla scienza moderna, fino all’età della tecnica in cui “vero” tende a coincidere con “funziona”.
La scheda dell’editore e le principali librerie riassumono proprio questa architettura: un movimento storico-critico che traduce il problema filosofico in bussola civile.
Una genealogia più che una tesi
Galimberti non cerca il colpo di teatro: procede per decantazione storica. Mostra come, a ogni passaggio d’epoca, l’idea di verità venga ricalibrata: svelamento per i greci, affidabilità per la Bibbia ebraica, adeguazione intellettuale in chiave platonico-aristotelica, verificabilità con la scienza moderna, produttività nella civiltà tecnico-performativa. Le tappe sono note, ma il montaggio è utile — perché le mette in relazione con pratiche (politiche, mediatiche, tecnologiche) che tutti abitiamo.
La tesi che fa discutere: dall’aletheia all’efficacia
Galimberti lo aveva già formulato in altri contesti, e qui lo riprende in forma asciutta: “Nell’età della tecnica la verità cambia ancora: vero è ciò che ha successo”; è una frase che condensa un’intera antropologia: se contano gli effetti, allora verità e potere si sfiorano pericolosamente, perché chi dispone dei mezzi di produzione degli effetti dispone anche dei mezzi di produzione del “vero”.
Una categoria utile per leggere il presente
Il punto è meno teorico di quanto sembri. Pensiamo alla politica dei sondaggi, alle “metriche” social, alla comunicazione d’impresa, alle stesse piattaforme che regolano la visibilità dei contenuti: ciò che funziona (clicca, converte, sposta consensi) fa realtà. Il libro non demonizza il mezzo; prova, invece, a definire una soglia di vigilanza: se la verità diventa efficacia, il rischio è ridurre l’etica a ergonomia, la deliberazione a design, la discussione pubblica a gara di performatività.
Ed è qui che il tono si fa civile: Galimberti ci chiede di rianimare il pensiero critico proprio mentre tutto spinge a consumare evidenze preconfezionate. La scheda editoriale, in questo senso, parla di una “mappa per orientarsi nel presente” e di un libro che rimette in discussione abitudini consolidate.
Come è costruito il libro
Galimberti scrive in una lingua piana che non sacrifica il rigore. I capitoli sono brevi, spesso concentrati su un nodo semantico o su un passaggio di civiltà. La misura — 144 pagine — è un vincolo che diventa virtù: costringe a tenere il fuoco su ciò che serve per decidere (non solo “sapere”). Librerie e rivenditori insistono proprio su questa struttura “portatile”, pensata per il lettore colto, sì, ma non specialistico.
Il metodo: genealogia, esempi, lessico minimo
Non c’è apparato accademico ridondante: c’è una genealogia che si appoggia a esempi storici, biblici, scientifici, mediali; e c’è un lessico minimo restituito a uso civile. Il vantaggio è che il libro si presta a una lettura stratificata: può essere un’introduzione al problema, ma anche un pungolo per chi ha già frequentato Nietzsche e Foucault e vuole interrogare la loro eredità nell’ecosistema digitale.
Galimberti nel suo percorso: una coerenza al lavoro
Chi legge Galimberti da anni riconoscerà un filo. Dall’analisi dell’“ospite inquietante” (il nichilismo che attraversa i giovani) alla grande diagnosi di Psiche e techne sull’impatto della tecnica, fino ai libri di taglio più divulgativo, lo schema è coerente: mettere nomi condivisibili ai mutamenti che il linguaggio tende a nascondere. Anche la pagina autore Feltrinelli presenta Le disavventure della verità come tappa di una pedagogia della cittadinanza critica.
Il rapporto tra idee e vita, in controluce
In una recente intervista Galimberti ha ammesso, con spiazzante franchezza, che nella sua biografia le idee hanno sempre avuto il primato rispetto al mondo della vita. Lo si legga come un limite o come una confessione metodologica, aiuta a interpretare il tono del libro: non è confessionale, è normativo. Chiede disciplina dello sguardo, non empatia.
Venticinque secoli
Le epoche non sono capitoli stagni ma strumenti per leggere ciò che viviamo: la verità come svelamento è messa in risonanza con il bisogno di autenticità che attraversa le nostre biografie; la verità come affidabilità (’emet) dialoga con la crisi di fiducia nelle istituzioni; la verità come corrispondenza si confronta con le teorie della conoscenza; la verità come verificabilità interroga la scienza nell’era della pre-print culture; la verità come efficacia sfida l’immaginario della crescita infinita, delle dashboard, della reputazione a punteggio.
Nel tragitto, Galimberti smonta un riflesso pericoloso: mettere tutto sullo stesso piano e dire “post-verità”. Qui il termine c’è, ma non come etichetta; è il sintomo di una trasformazione più lunga, che riguarda le infrastrutture del vedere e del credere. La ricaduta più preziosa, per il lettore non specialista, è la demistificazione di un equivoco: non siamo bombardati solo da menzogne; siamo immersi in costruzioni di realtà che funzionano perché usano logiche di successo (visibilità, engagement, redditività). Sapere questo non ci rende immuni, ma ci sottrae all’ingenuità.
Questioni aperte
Chi arriva da studi specialistici potrebbe chiedere più bibliografia e più contesa con le scuole contemporanee (epistemologia analitica, cognitive science, teoria della testimonianza). Ma il progetto, qui, è un altro: offrire a un pubblico largo un criterio pratico di orientamento. Alcune pagine sulle piattaforme e sulla comunicazione politica, volutamente icastiche, sarebbero state ancora più forti se confrontate frontalmente con la letteratura tecnica (algoritmi di raccomandazione, modelli di persuasione computazionale, design dell’attenzione). Non è però un difetto “moralista”: è una scelta di registro. Galimberti non vuole inchiodare il lettore al capoverso di un paper: vuole equipaggiarlo per discutere in piazza — nel parlamento, nel consiglio di istituto, in famiglia, nel condominio digitale.
Un altro nodo è il rischio del declinismo (l’idea di un’inesorabile decadenza morale legata alla tecnica). A volte il traço si avverte, specie quando la tesi “vero = ciò che funziona” sembra chiudere ogni spiraglio di verità condivisa. Il testo, tuttavia, si salva da questa trappola proprio perché invita a riaprire la discussione sul come funzionano le nostre procedure di verità (scienza, tribunali, media, educazione). L’esito non è un “tanto vale”: è un compito.
La forza (politica) del sottotitolo che non c’è
Nel libro non c’è un sottotitolo esplicito, ma potremmo formularne uno: “Per una cittadinanza della verità”. Perché il punto di Galimberti non è fissare un dogma, è chiedere manutenzione. La verità non è un fondamento eterno che ci attende uguale a sé; è un lavoro: istituzioni, pratiche, conversazioni, spazi di ristabilimento delle evidenze, tempi di revisione. È qui che la formula iniziale (“la verità non si insegna, la si scopre”) suona meno paradossale e più operativa: scoprire significa togliere la coperta delle rappresentazioni che ci seducono, guardare gli effetti, risalire alla fonte.
Un libro che “fa spazio”
C’è poi un merito formale da sottolineare: Le disavventure della verità non chiude; apre. Non ci dice “ecco il vero, punto”. Mostra, invece, un campo di forze: che cosa accade alla verità quando cambia il supporto (dalla testimonianza orale al documento, al dato, al log di sistema), quando cambia il ritmo (dalla lentezza della verifica alla simultaneità del “live”), quando cambiando gli scopi cambiano anche i criteri (dal vero che consola al vero che funziona). È in questa grammatica mobile che il libro chiede di abitare.
Un confronto rapido: dove Galimberti conversa e diverge
Chi ha in mente le genealogie di Nietzsche o la critica della “volontà di verità” di Foucault riconoscerà la famiglia. Ma Galimberti rifila via l’accademia e porta giù il discorso. Dove Nietzsche scavava sotto i valori e Foucault mappava i regimi di verità, qui il focus è civico: come ci muoviamo in un ecosistema informativo dove la “verità” è promessa di servizio. L’avvicinamento alla cultura digitale è misurato, talvolta stringato; ma la diagnosi sull’efficacia rende leggibili fenomeni quotidiani (la viralità, il “dato” come totem, la retorica della soluzione).
Stile e contenuto
Quando si avventura nelle metafore (rappresentazione, scena, performance) lo fa per tenere il lettore vicino al banco: il discorso filosofico, qui, è un esercizio di educazione civica. Non troverete effetti speciali; troverete una prosa di servizio che si lascia citare dove serve e che, a tratti, nella sua asciuttezza, ricorda la migliore divulgazione italiana.
La “disavventura” del titolo è anche un invito alle istituzioni
- Scuola: ridare tempo al vaglio, non solo competenze di esposizione
- Media: distinguere informazione da intrattenimento d’opinione
- Tribunali: difendere le procedure come garanzia contro la spettacolarizzazione
- Scienza: proteggere le soglie di qualità in un ecosistema che premia la rapidità della pubblicazione
Se la verità si fa efficacia, la risposta non può essere nostalgica; dev’essere progettuale: riformare i dispositivi perché la produzione del vero resti controllabile e discutibile.