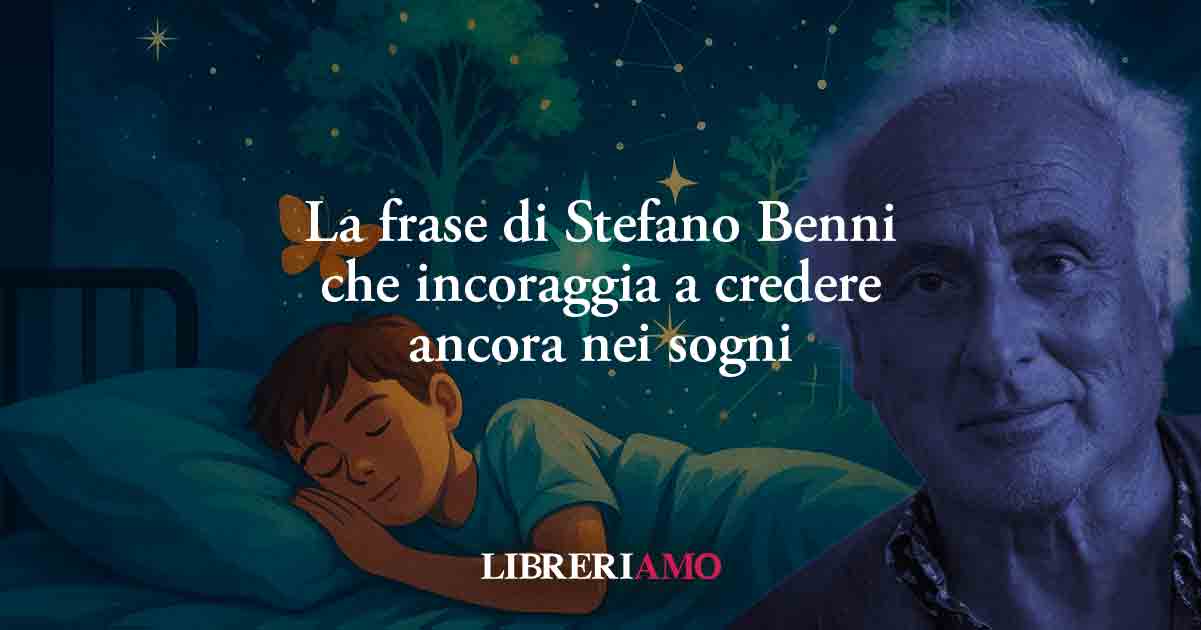C’è una frase di Stefano Benni che riesce a donare una riflessione profonda sulla vita, soprattutto quando tutto sembra andare verso il peggio, quando ciò che circonda sembra non voler mai reagire alla decadenza, alla crisi, al malaffare, alla distruzione, alla dissoluzione, alla corruzione dei valori e della morale.
Un invito semplice che, nello stile dello scrittore bolognese, offre ben due importanti lezioni di vita, ovvero avere la forza di credere sempre, ma allo stesso, tempo che ciò in cui si crede non arriva per caso, serve impegno, sacrificio, abnegazione, forza, volontà. Qualsiasi cambiamento o risultato no0n arriva mai per caso.
“Non bisogna mai mollare, dottore – disse l’infermiere. – Ci vuole un gran fisico per correre dietro ai sogni.“
La frase è contenuta nel capitolo 10 dal titolo “Satagius” del libro Elianto di Stefano Benni, pubblicato per la prima volta da Giangiacomo Feltrinelli Editore, nella collana “I Narratori”, nel 1996.
Proviamo a scoprire il contesto in cui vive questa splendida frase, la cui ultima parte vive anche anella quarta di copertina del libro ed è molto condivisa sul web e sui social.
Il contesto della frase di Stefano Benni
In Elianto, Stefano Benni intreccia con lucidità la satira e la fantasia visionaria, restituendo un ritratto grottesco e feroce della società contemporanea. Leggendo il romanzo oggi, a quasi trent’anni dalla sua pubblicazione, si ha l’impressione che i mali del mondo e del nostro Paese, in particolare, non siano mai cambiati: cinismo, corruzione, indifferenza restano sempre gli stessi.
L’ambientazione è quella di Villa Bacilla, clinica che riflette il volto malato proprio della nostra Italia. Qui domina il dottor Siliconi, incarnazione del potere cinico e corrotto, capace di piegare la scienza a interessi meschini, giustificando perfino la distruzione degli alberi e del paesaggio.
Accanto a lui troviamo il dottor Satagius, medico malinconico e stanco, simbolo di quella parte d’Italia che vede il degrado ma non ha più la forza di reagire, accettando passivamente la dissoluzione morale che lo circonda.
In questo scenario cupo emerge la voce sorprendente dell’infermiere Talete Fuschini, geniale per chiarezza e ironia. Con le sue battute spiazzanti, Talete è l’unico a ribaltare la rassegnazione. È lui a pronunciare la frase destinata a diventare un aforisma immortale, un’esortazione che rompe il cinismo e restituisce a Satagius, almeno per un istante, la possibilità di resistere alla decadenza che domina la clinica e, per metafora, l’intera società.
Elianto, il vero malato
Ma il cuore del romanzo è lui, Elianto, il ragazzo tredicenne che incarna la parte giovane e fragile dell’Italia, colpita da un male che la medicina non sa curare. Stefano Benni all’inizio del libro, nella presentazione dei personaggi, lo descrive così:
“Elianto ha tredici anni e fino a due anni prima era uno dei ragazzi più vivaci della contea. Poi i capogiri, la sonnolenza, i crampi. “Morbo Dolce” o “Morbo Solitario”, così lo definiscono i trattati dei medici. Ma ora non sente nulla. Né la febbre, né i dolori alla schiena, né l’arsura.”
Elianto è il simbolo di un’innocenza minacciata, di un’energia vitale che rischia di spegnersi. Il ragazzino è il futuro dell’Italia, il suo silenzio e il suo sonno diventano il contraltare della frase di Talete. Mentre il ragazzo sogna in un’altra dimensione, la realtà esterna continua a chiedere forza, resistenza e coraggio per non cedere alla decadenza.
La frase di Stefano Benni che spinge a credere ancora
Il suggerimento dell’infermiere Talete è insieme un invito a resistere e un richiamo alla realtà. Il suo valore sta proprio nell’ambivalenza. Riesce, infatti, ad accendere la speranza ma rifiuta l’illusione. Chiede fede nei sogni ma esige la fatica necessaria per sostenerli.
La frase di Stefano Benni è memorabile perché ricompone un’antinomia: sogno e realtà non sono avversari. Il sogno è il nome morale della realtà da costruire; la realtà è il luogo fisico in cui il sogno va allenato, giorno dopo giorno.
Talete lo dice con un sorriso che punge: non basta crederci, bisogna reggerlo. E proprio qui nasce la forza civile di Elianto: una letteratura che consola senza illudere, che incoraggia senza mentire.
Gli 8 motivi della forza della frase di Stefano Benni
1) L’incoraggiamento: “non bisogna mai mollare”
L’incipit della frase è un imperativo etico. In un ambiente come Villa Bacilla, dove dilagano cinismo, rassegnazione, interessi personali, persino la distruzione degli alberi come gesto di violenza simbolica contro l’ambiente e il patrimonio territoriale italiano, Talete introduce una voce controcorrente.
“Non mollare” significa non cedere all’indifferenza, non normalizzare l’anomalia, non considerare inevitabile ciò che è solo comodo per i forti.
Rivolto al dottor Satagius, l’invito ha un bersaglio preciso. Smontare quella passività pensosa e malinconica che lo ha reso spettatore degli eventi. Talete non parla a un eroe, parla a un uomo stanco, per questo la sua frase suona credibile e umana.
È la spinta gentile che prova a riaccendere in Satagius la volontà di incidere sulla realtà, a partire dal caso più urgente: Elianto, la vita giovane che rischia di spegnersi.
2) L’avvertimento realistico: “ci vuole un gran fisico”
Il cuore retorico sta qui. Talete sostituisce alla parola “anima” la parola “fisico”. È una mossa genia perché “materializza”, rendendola corporea, la speranza, la sottrae al sentimentalismo e la riporta nel terreno dell’azione.
Sognare, in questo contesto, non è il contrario del reale, è un lavoro. Come ogni lavoro, domanda allenamento, disciplina, ripetizione, fede, abnegazione.
La clinica, luogo del corpo e del limite, rende la metafora ancora più incisiva.
Per curare (gli altri e se stessi) non bastano le buone intenzioni. serve una tenuta emotiva e mentale pari a una maratona. Così Talete vaccina Satagius contro due rischi opposti, il cinismo (che deride i sogni) e il buonismo (che li idealizza senza pagarne il prezzo). La sua frase è una pedagogia della realtà: i sogni non si delegano, si reggono.
3) Il carisma della “saggezza operativa”, dell’uomo che vive il reale
Che questa frase venga dall’infermiere, e non dal primario, è coerente con la visione e il pensiero di Stefano Benni. Talete Fuschini incarna una saggezza operativa, nata nel contatto con il dolore, con i corpi, con le piccole riparazioni quotidiane. È l’uomo che convive con chi vive la privazione, che è vicino a chi subisce il male.
È l’opposto del dottor Siliconi, l’efficiente corruttore della scienza piegata al potere. Ed è il controcampo di Satagius, intellettuale, sapiente, scienziato “provato” che guarda molto e agisce poco.
In bocca a Talete la battuta diventa forma di resistenza civile. Esprime un modo di rimettere al centro il lavoro onesto, la cura, la manutenzione del bene comune. È un aforisma “dal basso” che smaschera l’ideologia dell’inevitabile.
4) Una spinta a reagire
La reazione di Satagius, il sospiro, la domanda personale, segnala che la frase ha toccato la difesa dell’abitudine. Non è un’adesione trionfale, ma l’avvio di qualcosa che tocca dentro.
Talete restituisce una grammatica del possibile. Prima l’ottimismo come “punturina” (il tono leggero), poi l’idea che serva un “gran fisico” (la serietà del compito). Ironia e verità entrano in risonanza e creano uno spazio d’azione.
5) Il sogno come compito, non come fuga
Nel capitolo, Elianto è la posta in gioco. Non è un sogno astratto. È un volto, un tredicenne ferito da un male che la scienza ufficiale non sa ancora “curare”. Mentre fuori si abbattono gli alberi e dentro si consuma la corruzione del senso, Elianto custodisce, persino nel sonno, un’energia di vita che chiama gli adulti a farsi carico del reale.
Qui la frase di Talete cambia punto di vista, da massima motivazionale diventa mandato etico. “Correre dietro ai sogni” significa assumere Elianto e ciò che rappresenta (giovinezza, futuro, innocenza) come compito condiviso. Non credere “in generale” nei sogni, ma tenere in braccio questo sogno concreto e fragile.
6) La clinica come metafora del Paese
Villa Bacilla è una metafora sociale, politica, esistenziale della nostra Italia. La distruzione degli alberi fuori dalla clinica e il malcostume dentro di essa rispecchiano cosa accade quotidianamente nel Paese, devastazione del vivente e devastazione della morale sono la stessa cosa.
In questo quadro, la frase di Stefano Benni, in bocca a Talete, offre un criterio di cittadinanza: non basta indignarsi (non mollare), occorre reggere la fatica lunga della cura (il gran fisico).
È un’etica del saper reagire guardando alla realtà e senza farsi coinvolgere dal “canto delle sirene” che può arrivare da chi viole sfruttare il problema per i propri interessi.
7) Per reagire serve ironia e disciplina
La forza della frase di Stefano Benni nasce quindi dal corto circuito linguistico: l’iperbole “atletica” applicata ai sogni.
La risata corta che strappa l’immagine (“correre dietro ai sogni”) apre uno spazio cognitivo nuovo, offre una visione del sogno come allenamento, la speranza come muscoli.
È la formula della sua poetica: leggerezza non evasiva, umorismo che non banalizza ma svela.
8) Attualità della frase di Stefano Benni
La frase parla oggi con la stessa urgenza di circa trent’anni fa. Oggi il degrado del patrimonio naturalistico e territoriale del Paese e non solo (gli alberi) è sempre e ancora più evidente. Anche la crisi etica e valoriale (Siliconi), la crisi identitaria (Satagius) evidenziano che il “non mollare” non basta senza il “gran fisico”, ovvero l’impegno.
L’infermiere Talete consegna una bussola per reagire e dare forza alla speranza lucida (niente ingenuità), grazie all’impegno costante (niente scorciatoie), e nella convinzione che i sogni hanno bisogno di tanta concretezza e realtà.