“Fantasmagoriana” Il libro maledetto che accese la fiamma di Frankestein
“Fantasmagoriana”, l’antologia gotica che ispirò Mary Shelley e John Polidori, torna in libreria per Nova Delphi con un’edizione critica a cura di Fabio Camilletti. Un classico del terrore che ha segnato la nascita del fantastico moderno.
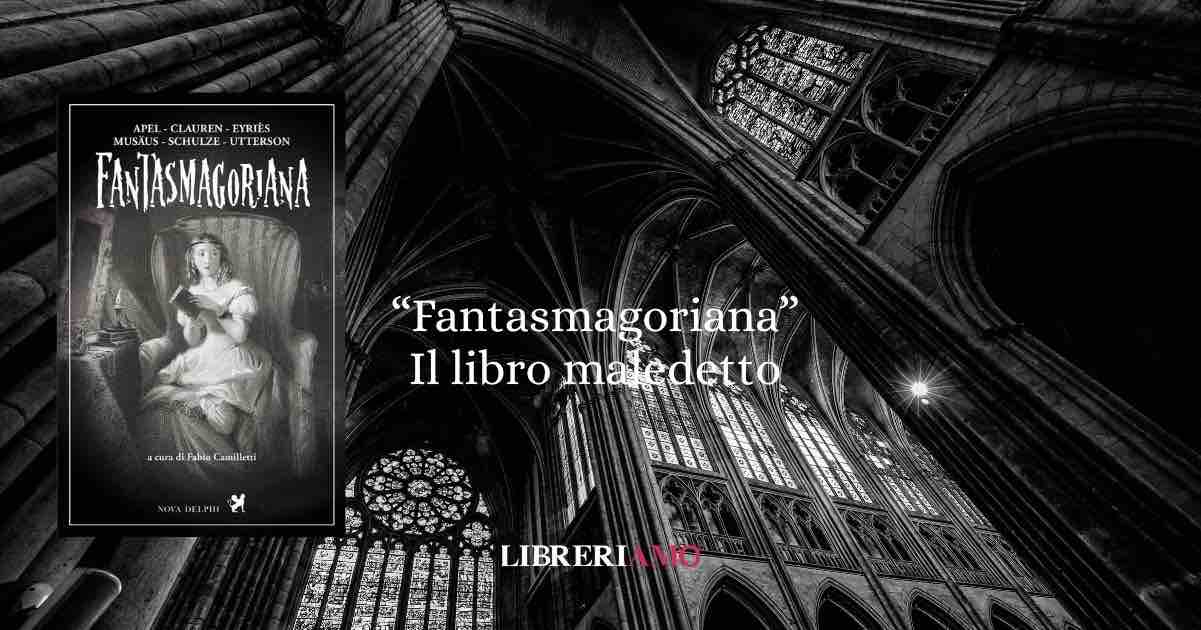
Nel cuore di un’estate fredda e perturbante, nell’anno senza estate del 1816, sulle rive del lago di Ginevra, un gruppo di giovani letterati si riunì in una villa destinata a entrare nel mito: Villa Diodati. In quella cornice, tra temporali, letture ad alta voce e spiriti evocati dal fuoco e dalla parola, Mary Shelley, Percy B. Shelley, Lord Byron, John Polidori e Claire Clairmont diedero vita a una delle pagine più celebri della storia della letteratura gotica, ispirandosi anche a Fantasmagoriana.
L’evento che accese la miccia? La lettura collettiva di un libro, fino ad allora poco noto, intitolato “Fantasmagoriana”.
Questo libro, Fantasmagoriana, divenne il catalizzatore di una creatività senza precedenti, portando a un confronto che avrebbe cambiato per sempre il panorama letterario.
“Fantasmagoriana” La raccolta di storie di fantasmi che trasformò una noiosa estate in svizzera nel capolavoro del terrore gotico, ispirando opere come Frankenstein.
Leggere “Fantasmagoriana” oggi non significa solo avvicinarsi a un classico dimenticato, ma compiere un viaggio alle radici della nostra immaginazione occidentale. I racconti contenuti nel volume parlano al lettore contemporaneo perché mettono in scena paure universali: il ritorno del passato, l’ignoto, il doppio, l’irrazionale. Ma lo fanno con una grazia narrativa e una cura stilistica che rende omaggio al piacere della parola e alla forza della letteratura.
Grazie al lavoro di Fabio Camilletti, “Fantasmagoriana” torna in libreria in una veste all’altezza del suo valore simbolico. E ci ricorda che i veri fantasmi non muoiono mai: si nascondono tra le pagine, pronti a tornare quando meno ce lo aspettiamo.
Il libro
Pubblicato anonimamente a Parigi nel 1812 dal geografo Benoît Eyriès, Fantasmagoriana è un’antologia di otto racconti dell’orrore di origine tedesca, tradotti in francese e ispirati direttamente agli spettacoli di “fantasmagorie”: giochi ottici di luci, fumi, proiezioni e suoni che simulavano apparizioni di spettri, anticipando le illusioni del futuro cinematografico.
Non un semplice libro, ma un dispositivo immaginifico, una macchina narrativa capace di risvegliare i fantasmi della mente, stimolando paure primordiali e desideri reconditi.
Come racconta Mary Shelley nella prefazione del suo Frankenstein, fu proprio la lettura di queste storie a scatenare tra i presenti un “giocoso desiderio di imitazione”. Il risultato? “Frankenstein o il moderno Prometeo” da una parte, “Il vampiro” di Polidori dall’altra. Due archetipi della narrativa fantastica moderna nati, in parte, sotto l’eco cupa e seducente di Fantasmagoriana.
Un progetto editoriale ambizioso e necessario
L’edizione italiana curata da Fabio Camilletti e pubblicata da Nova Delphi è la prima versione integrale del testo francese apparsa in Italia. Il volume non è solo una traduzione, ma un vero e proprio compendio critico, dotato di un ampio saggio introduttivo, di note esplicative e apparati che ne contestualizzano le origini, la fortuna e l’impatto sulla cultura europea.
Camilletti, germanista e studioso di cultura romantica, riesce nell’impresa non facile di restituire al lettore italiano tutta la ricchezza intertestuale del libro, evidenziando i legami tra la Ginevra letteraria di Byron, Shelley e Polidori e la Parigi di Gautier, Nodier, Dumas e Mérimée.
L’antologia include racconti di autori oggi poco noti al grande pubblico (Apel, Clauren, Musäus, Schulze, Utterson), ma che all’epoca erano tra i più apprezzati interpreti della narrativa del terrore. La forza di questi racconti non risiede solo nella trama, spesso semplice, ma nella capacità di evocare un’atmosfera inquietante e perturbante, che travalica i confini tra reale e immaginario, tra visibile e invisibile.
Un ponte tra folklore e psiche moderna
La lettura di “Fantasmagoriana” oggi ci permette di comprendere meglio come il fantastico ottocentesco abbia rielaborato il folklore europeo trasformandolo in mito moderno. Storie di castelli infestati, apparizioni, vendette post-mortem e sortilegi diventano metafore di angosce più profonde: la paura dell’ignoto, il rimorso, la colpa, la repressione sessuale, l’inconscio che fa irruzione nella quotidianità borghese.
In questo senso, “Fantasmagoriana” anticipa non solo la narrativa gotica inglese, ma anche le future riflessioni psicoanalitiche sul “perturbante”. Il libro è anche un documento fondamentale per comprendere il passaggio dalla cultura orale e popolare alla letteratura di consumo, e da lì alla nascita del genere horror come lo conosciamo oggi: seriale, codificato, influenzato da tecniche visive (come il teatro delle ombre e poi il cinema) e ossessionato dal confine tra illusione e realtà.
Un’estetica nera che affascina ancora
L’edizione Nova Delphi si distingue anche per la scelta iconografica e per la cura grafica, che restituiscono il fascino d’epoca del volume. La copertina, in perfetto stile vittoriano, con una giovane lettrice sorpresa dal fantasma di un racconto, evoca l’esperienza del lettore ottocentesco e rende omaggio al piacere del brivido domestico, all’intimità della lettura notturna, all’immaginazione che trasforma il quotidiano in mistero.
“Fantasmagoriana” invita a rallentare, a tornare a una paura più sottile e insinuante, fatta di attese, ombre e suggestioni. Un horror che non urla, ma sussurra. E proprio per questo, più potente.
Il titolo “Fantasmagoriana” deriva dagli spettacoli ottici settecenteschi chiamati “fantasmagorie”, antesignani del cinema horror. Mary Shelley, nella prefazione del suo Frankenstein, cita esplicitamente Fantasmagoriana come ispirazione per il celebre romanzo.
John Polidori, dopo quella vacanza, scrisse Il vampiro, racconto che influenzò profondamente la figura letteraria del vampiro moderno.
La nuova edizione italiana di Nova Delphi è la prima completa e criticamente annotata apparsa nel nostro paese. La raccolta fu pubblicata in forma anonima e solo in seguito attribuita a Benoît Eyriès, geografo e appassionato di folklore gotico.