Esistono manga di spessore?
Scopri se esistono manga di spessore e come questi racconti possono influenzare i lettori e il mondo della narrativa visiva.
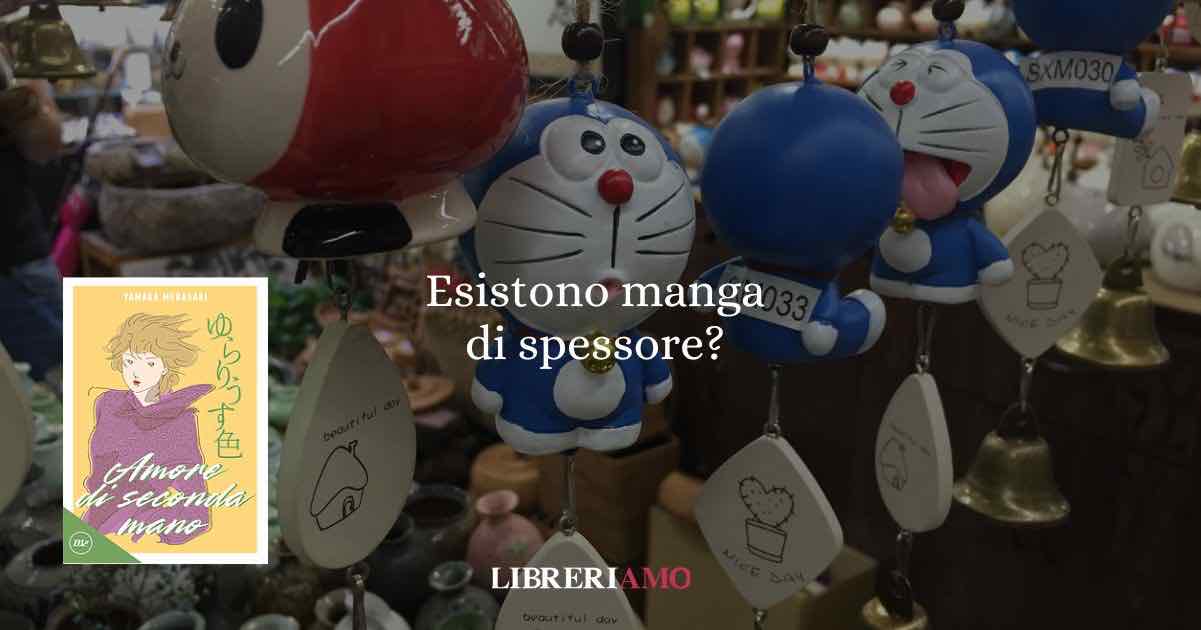
In un panorama narrativo dove l’amore è spesso idealizzato, Yamada Murasaki ci costringe a guardarlo da un’angolazione scomoda e raramente esplorata: quella delle donne che diventano “l’altra” , e che scoprono presto come anche questa posizione abbia le sue catene. I manga, in questo contesto, offrono una visione unica e profonda della condizione umana.
La raccolta “Amore di seconda mano” è un mosaico di storie brevi che parlano di amanti, di matrimoni visti come condanne, di desideri che si scontrano con ruoli imposti. Ogni storia, simile a un manga, invita a riflettere sulle relazioni moderne.
Emi, la protagonista del racconto principale, non è una femme fatale, né una vittima pura: è una donna che cerca di sopravvivere a una solitudine densa, fatta di letti sfatti e giornate d’ufficio prive di significato.
In questi racconti, i lettori possono rispecchiarsi, come in un manga, nelle sfide e nelle scelte delle protagoniste.
Accetta una relazione con un uomo sposato non per romanticismo, ma perché crede sia un compromesso gestibile, una forma di libertà rispetto all’idea di matrimonio come gabbia.
Eppure, anche in questa condizione secondaria, scopre che l’amore ha un prezzo: il lavoro emotivo di rassicurare, consolare, nascondere la propria frustrazione, mantenere sempre viva l’attrazione, assorbire i sensi di colpa dell’altro. Una fatica invisibile, che si intreccia a un senso di colpa interiorizzato e alla paura di non meritare di più.
Curiosità su Yamada Murasaki e il femminismo nei manga
Chi era Yamada Murasaki? Nata nel 1948 a Tokyo, Yamada Murasaki è stata una mangaka e illustratrice attiva dagli anni ’70, nota per le sue opere introspettive e per il suo approccio fortemente influenzato dal femminismo. È considerata una delle figure chiave del josei manga, il fumetto giapponese per un pubblico femminile adulto.
Il josei manga come spazio di libertà Negli anni ’70 e ’80: il josei diventa uno dei pochi ambiti in cui le autrici giapponesi possono affrontare senza censure temi come sessualità, solitudine, salute mentale e critica ai ruoli femminili. Yamada ne ha fatto un linguaggio personale, unendo lirismo e realismo crudo.
La prospettiva “scomoda” In Amore di seconda mano: Murasaki sceglie di raccontare la storia dal punto di vista “dell’altra donna”, l’amante, ribaltando lo stereotipo romantico e mettendo in primo piano la fatica emotiva e l’alienazione che spesso accompagnano questo ruolo.
Arte e minimalismo emotivo: Il tratto grafico di Yamada è essenziale e quasi silenzioso: pochi dettagli, grande spazio bianco, volti che comunicano emozioni sottili. Questo minimalismo visivo amplifica il senso di vuoto e sospensione delle storie.
Eredità e attualità: Yamada è considerata una pioniera per il modo in cui ha affrontato questioni di genere.
“Amore di seconda mano” resta un testo attuale per il suo sguardo spietato sulle dinamiche di potere nelle relazioni.
Esistono manga di spessore? La risposta è nell’universo femminista e tagliente di Yamada Murasaki
Leggerlo oggi significa confrontarsi con domande che non hanno perso urgenza: quanto del nostro tempo e delle nostre energie emotive dedichiamo a mantenere in piedi rapporti che ci svuotano?
Quanto il patriarcato continua a influenzare le nostre scelte, anche quando crediamo di esserne fuori? Con una prosa visiva essenziale e una lucidità disarmante, Murasaki offre uno specchio in cui riconoscere fragilità e desideri, ma anche la possibilità di immaginare un’uscita.
Yuko e l’eco di un disagio collettivo
In parallelo a Emi c’è Yuko, anche lei amante, anche lei intrappolata in una relazione che non la soddisfa. La sua storia si allarga alla memoria familiare, ai ricordi d’infanzia, mostrando come le ferite personali si innestino su una trama più ampia di condizionamenti sociali.
Yuko, come Emi, vive in bilico tra la volontà di affermare sé stessa e il richiamo costante ai ruoli femminili tradizionali: compagna accudente, donna silenziosa, custode del benessere emotivo altrui.
Yamada Murasaki: una voce scomoda e necessaria
Considerata una delle voci più acclamate del femminismo nei manga, Yamada Murasaki ha sempre unito lirismo e analisi sociale, disegnando protagoniste imperfette, vulnerabili e irriducibilmente vere.
Nei suoi lavori, il patriarcato non è un concetto astratto, ma un sistema concreto di aspettative e imposizioni che agisce sui corpi e sulle emozioni delle donne.
“Amore di seconda mano” è intriso di rabbia pacata, di quella lucidità che non ha bisogno di urlare per lasciare il segno. La scelta narrativa di affrontare il punto di vista “dell’altra” non è mai un tentativo di giustificazione, ma un’esplorazione radicale di una condizione sociale: un ruolo marginale che non offre davvero libertà, ma ripropone gli stessi meccanismi di controllo e colpa che si trovano all’interno del matrimonio.
Perché è una lettura attuale
Nonostante la storia sia ambientata in contesti giapponesi degli anni ’70-’80, la riflessione di Murasaki rimane attuale: Il lavoro emotivo femminile, spesso invisibile, continua a essere un tema urgente.
La solitudine delle donne in relazioni sbilanciate è ancora poco raccontata, soprattutto con la crudezza e l’introspezione che Yamada porta in scena.
La critica ai ruoli patriarcali come prigioni invisibili parla a generazioni diverse, ben oltre i confini culturali del Giappone.
Una trappola elegante
La potenza di Amore di seconda mano sta nel mostrare come anche ciò che appare come una scelta “fuori dal sistema” possa rivelarsi un’altra forma di intrappolamento.
È la condizione di chi pensa di aver trovato un rifugio ma, giorno dopo giorno, scopre che la porta è chiusa dall’interno. L’opera lascia addosso una sensazione persistente: la consapevolezza che la libertà non può esistere in ruoli già scritti da altri, e che la vera evasione è molto più complessa di quanto sembri.
Perché leggerlo oggi
“Amore di seconda mano” è molto più di una raccolta di racconti: è un invito a guardare nelle pieghe più intime delle relazioni, là dove il desiderio si intreccia con il compromesso, e la libertà promessa si rivela spesso una gabbia invisibile. Yamada Murasaki ci mostra che i ruoli imposti, anche quelli apparentemente scelti, possono diventare trappole emotive capaci di logorare giorno dopo giorno.