Ecologia letteraria: itinerario nella natura attraverso la letteratura
Un viaggio nella mente ecologica della letteratura attraverso “Ecologia letteraria” di Serenella Iovino, pioniera dell’ecocritica in Italia. Tra Primo Levi, Ortese, Pasolini e Giono, per leggere il mondo come una narrazione condivisa.
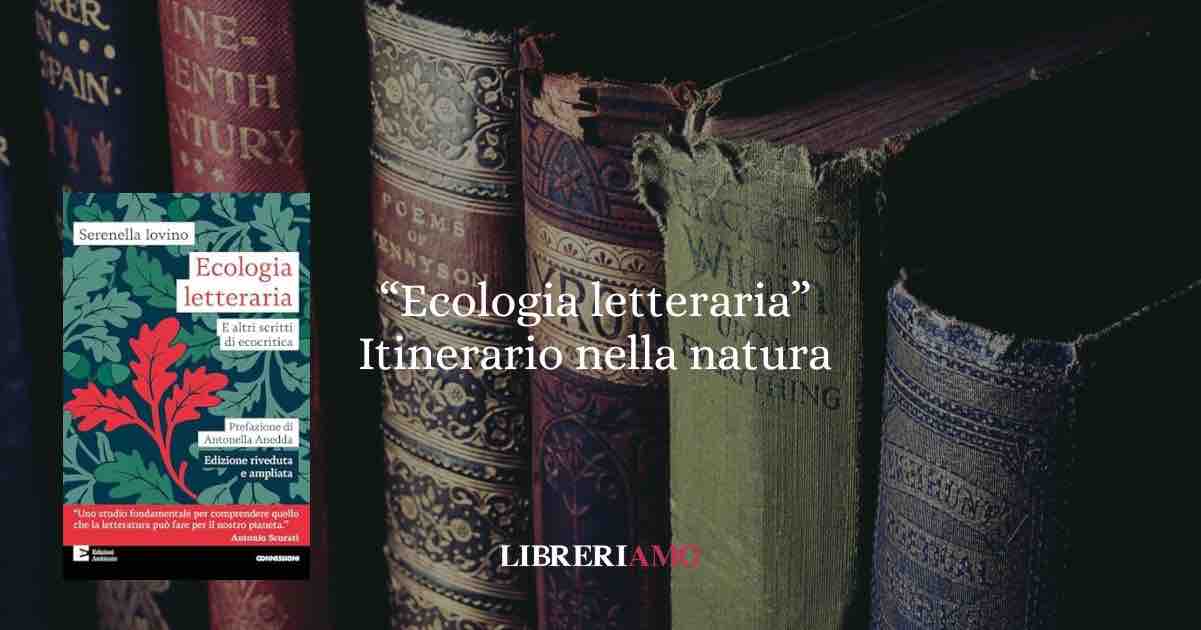
In un tempo segnato da crisi climatiche, estinzioni di massa e catastrofi ambientali, leggere diventa un atto di resistenza. Non solo perché ci permette di comprendere la realtà, ma perché ci insegna a immaginarla diversamente. È su questo presupposto che si fonda il pensiero di Serenella Iovino, tra le voci più autorevoli nel panorama delle Environmental Humanities internazionali, oggi James G. Hanes Distinguished Professor all’Università della North Carolina. Con “Ecologia letteraria” e altri scritti di eco-critica, edito da Edizioni Ambiente nella collana Connessioni, Iovino ci invita a esplorare la letteratura come una forma di pensiero ecologico.
Un luogo in cui le storie, i paesaggi, i corpi e i linguaggi si intrecciano per dar voce a ciò che è stato marginalizzato: il vivente, l’ambiente, le soggettività non umane. Questo volume, che raccoglie e aggiorna i saggi già pubblicati nel pionieristico Ecologia letteraria (2006), è oggi più attuale che mai, perché apre nuove strade nella comprensione del nostro tempo: l’Antropocene.
“Ecologia letteraria”: quando la natura parla attraverso le storie
Con questo volume, Serenella Iovino ci consegna uno strumento potente per cambiare sguardo. Leggere “ecologicamente” non significa solo parlare di alberi o animali, ma riconoscere le connessioni, i margini, le voci che abbiamo ignorato troppo a lungo. “Ecologia letteraria” non è un semplice libro: è un laboratorio di idee, un ponte tra saperi, una proposta per abitare il mondo con più consapevolezza. E oggi, più che mai, ne abbiamo bisogno.
Ecocritica: un lessico che prima non c’era
Quando “Ecologia letteraria” fu pubblicato per la prima volta nel 2006, in Italia non esisteva ancora una definizione condivisa per ciò che oggi chiamiamo “eco-critica”. Si trattava di un’area di studio emergente, che metteva in dialogo la letteratura, la filosofia, la politica e le scienze ambientali per riflettere su come le narrazioni influenzano, e sono influenzate, da la relazione tra esseri umani e natura.
Nel corso degli anni, Iovino ha contribuito a costruire questo lessico, posizionandosi come punto di riferimento imprescindibile. In questo nuovo volume, aggiornato e arricchito, l’autrice ripercorre i fondamenti teorici dell’ecocritica, ma li declina in chiave italiana e narrativa, con uno sguardo sempre attento alla giustizia ecologica, alle marginalità, e alla possibilità di pensare con il mondo, non solo su di esso.
Tra Anna Maria Ortese, Pasolini e Primo Levi: quattro letture eco-critiche
La seconda parte del libro: “Quattro letture eco-critiche”, è forse la sezione più affascinante per chi ama la letteratura. Iovino attraversa quattro autori in apparenza molto distanti, ma che hanno saputo raccontare la complessità ecologica del mondo con parole nuove e profondamente incarnate.
Anna Maria Ortese, con “L’Iguana”, viene riletta alla luce del “femminile trasversale”, in un saggio che mette al centro la figura dell’animale e dell’alieno, intesi come dispositivi di rottura e meraviglia.
Clarice Lispector, in “La passione secondo G.H”., diventa l’emblema della trascendenza sovversiva, dove l’umano si dissolve nel contatto con l’altro da sé, una blatta, dando vita a una mistica del non-umano.
Pier Paolo Pasolini, con la sua visione poetica e politica del paesaggio, viene esplorato come teorico di un’“ecologia della differenza”, in cui cultura e natura non sono antitetiche ma profondamente intrecciate.
Jean Giono, infine, è il cuore di un saggio sul “pluralismo arboreo”, dove l’autore mostra come i suoi romanzi contengano un’ecologia della speranza, in cui la terra parla, vive e resiste.
L’Antropocene come narrazione e responsabilità
Il libro si chiude con una sezione che ha il sapore della riflessione teorica e del manifesto: L’inquietudine, la speranza e il coraggio della narrazione, firmato da Scott Slovic, e i saggi dell’appendice, tra cui spiccano quelli dedicati a: Primo Levi, con un’analisi sorprendente sul “chewing gum” come metafora resistente e sulla semantica dell’umano in contesti di sopraffazione e distruzione.
L’arte e la cultura nell’Antropocene, dove Iovino riflette sulla produzione culturale come pratica geologica, capace di lasciare tracce, impatti, sedimentazioni; leggere l’ambiente e le sue storie, un vero e proprio invito alla lettura ecologica della realtà: non come semplice sfondo, ma come protagonista dei nostri racconti e delle nostre vite.
Il paesaggio come eredità: perché leggerlo oggi
“Ecologia letteraria” non è un saggio accademico nel senso tradizionale: è un’opera che si muove con grazia tra la filosofia, la critica letteraria, la poesia e l’attivismo, senza mai perdere chiarezza o profondità. Il suo valore sta nel riuscire a far pensare attraverso la bellezza, creando connessioni inedite tra testi e contesti, parole e corpi, soggetti umani e non umani.
Iovino ci propone una contro-narrazione fatta di empatia, ascolto e trasformazione. Come scrive nella quarta di copertina: “Abbiamo bisogno di dar voce ai soggetti marginalizzati, siano essi umani o non umani”.
L’autrice
Serenella Iovino ha vinto nel 2023 il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica e il Premio Green Book per Storie dell’Antropocene. Nel 2025 ha ricevuto il prestigioso “Seres Puentes Award” per il suo contributo agli studi ambientali nelle scienze umane, riconosciuto a livello internazionale. Scrive regolarmente per La Repubblica e il suo inserto culturale Robinson. È anche autrice di “Gli animali di Calvino” e “Paesaggio civile”.