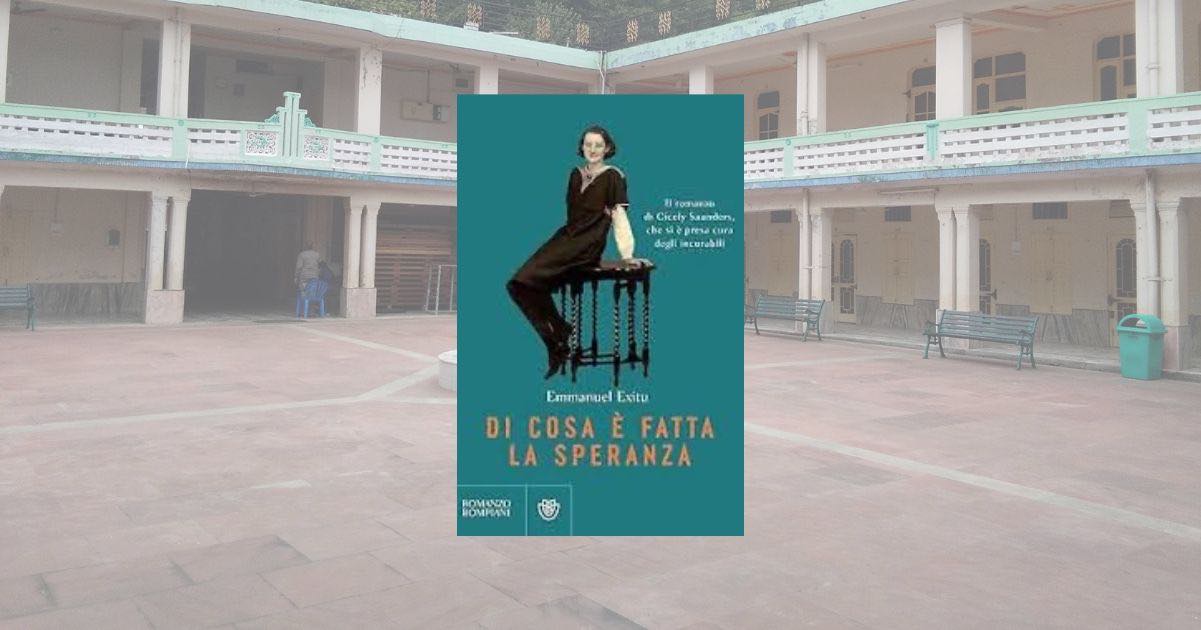Oggi parliamo di una donna, una giovane infermiera in formazione che alle 5:46 del 15 ottobre 1943 decide di lasciare Londra per raggiungere un ospedale di guerra: la storia di Cicely Saunders e della sua scoperta disarmante, che la porterà poi a rivoluzionare la medicina moderna di fronte a tutti coloro che pensavano fosse una perdita di tempo. Un personaggio realmente esistito, capace di cambiare la percezione collettiva della morte e di trasformare il modo in cui l’umanità guarda al dolore.
La vocazione di una donna coltivata nel dolore
“Di cosa è fatta la speranza” non parla semplicemente di una dottoressa che ha avuto un’idea, ma di una ragazza che si forma sul campo, tra corridoi spogli e notti insonni, assistendo giovani feriti e moribondi.
Cicely Saunders vede i suoi coetanei morire tra sofferenze indicibili, mentre i medici attorno a lei — incapaci di fare di più — si rassegnano a considerare quei malati terminali come dei “fallimenti”.
È un’esperienza che la segna per sempre: l’orrore di vite spezzate senza dignità la spinge a dedicarsi a una missione che durerà tutta la vita. Non guarire a ogni costo, ma curare sempre, anche quando non esiste più possibilità di guarigione.
È questa la scintilla che porterà Saunders a laurearsi in Medicina, e infine, nel 1967, a fondare il primo hospice moderno, un luogo che non è solo la “casa della morte”, ma uno spazio in cui vivere fino all’ultimo istante con dignità e umanità.
Il premio
La potenza narrativa di questa storia ha conquistato la giuria del Premio Comisso 2024, che lo ha scelto su trecento opere candidate. La motivazione parla di una “capacità di intrecciare storie e sentimenti, offrendo una riflessione profonda sulla natura umana”.
E, in effetti, il libro di Exitu si muove costantemente tra la precisione della cronaca e la vibrazione del romanzo, regalando al lettore l’impressione di trovarsi accanto a Cicely, nei reparti e negli studi che la videro nascere come pioniera.
Scrittura viva, empatia come farmaco
La recensione su Satisfiction coglie con forza il respiro emotivo del libro:
“Non ci sono parole… ma poi ti incastri. Rapisce, trascina… parole così pulsanti di vero da bucarti qualcosa dentro.”
Exitu non racconta soltanto: fa vivere. Le pagine sono attraversate dall’odore dei disinfettanti, dal rumore delle corsie, dalla tensione dei cuori che battono in attesa di un sollievo. È una scrittura che diventa farmaco simbolico, perché ci fa percepire quanto l’empatia sia una cura potente almeno quanto la medicina.
Una biografia elegante
Come ha scritto Alessandro Zaccuri, il romanzo è “scandito con l’eleganza di un romanzo classico e la precisione di una biografia interiore. La speranza si può scoprire assieme.”
Il risultato è un racconto che non si limita a celebrare una figura storica, ma che restituisce l’essenza di un cammino: la nascita delle cure palliative non come gesto tecnico, ma come atto d’amore. Dove la morte smette di essere solo un lutto privato o una sconfitta medica, e diventa esperienza comunitaria, condivisione, dignità.
Dalla tribuna alla vita che cura
Alessandria Today lo ha definito “un inno alla compassione e alla speranza… ci ricorda che la speranza può posarsi sull’anima anche nelle situazioni più difficili e illuminare l’ultimo respiro.”
Il riconoscimento è chiaro: Exitu non scrive per commuovere, ma per illuminare ciò che spesso resta invisibile nei protocolli sanitari, ossia il lato umano della cura, quella parte che non si misura con parametri clinici ma con la vicinanza, la voce, la presenza.
Modernità e attualità senza enfasi
Non mancano letture che hanno evidenziato la capacità del libro di parlare anche al presente. Stravagaria ha notato come il romanzo affronti un tema tanto delicato “senza rinunciare a toni briosi”, quasi a ricordarci che perfino nei momenti più bui il presente conserva lampi di leggerezza.
E ancora Città Nuova, in un commento personale e incisivo, ha scritto: “L’ho conosciuta viva, Cicely, e ora è parte di me. Mi chiedo se una biografia avrebbe lo stesso effetto.” È il segno che la scrittura di Exitu ha la forza di trasfigurare la storia in esperienza vissuta, al punto da farci sentire la protagonista come una presenza reale, parte della nostra memoria emotiva.
Una lettura importante
“Di cosa è fatta la speranza” non è solo biografia, non è solo romanzo: è un invito a riconoscere la dimensione umana della cura e della dignità, a recuperare l’empatia che in un mondo iper-sfruttato e accelerato rischia di sembrare inutile, ma che resta il farmaco più antico e più efficace.
Emmanuel Exitu ci racconta di una donna che ha saputo prendersi cura, restare accanto, accendere una luce anche dove la scienza non poteva guarire. È un libro che ci riguarda tutti, perché ognuno, prima o poi, si troverà ad affrontare la domanda su cosa sia davvero la speranza.