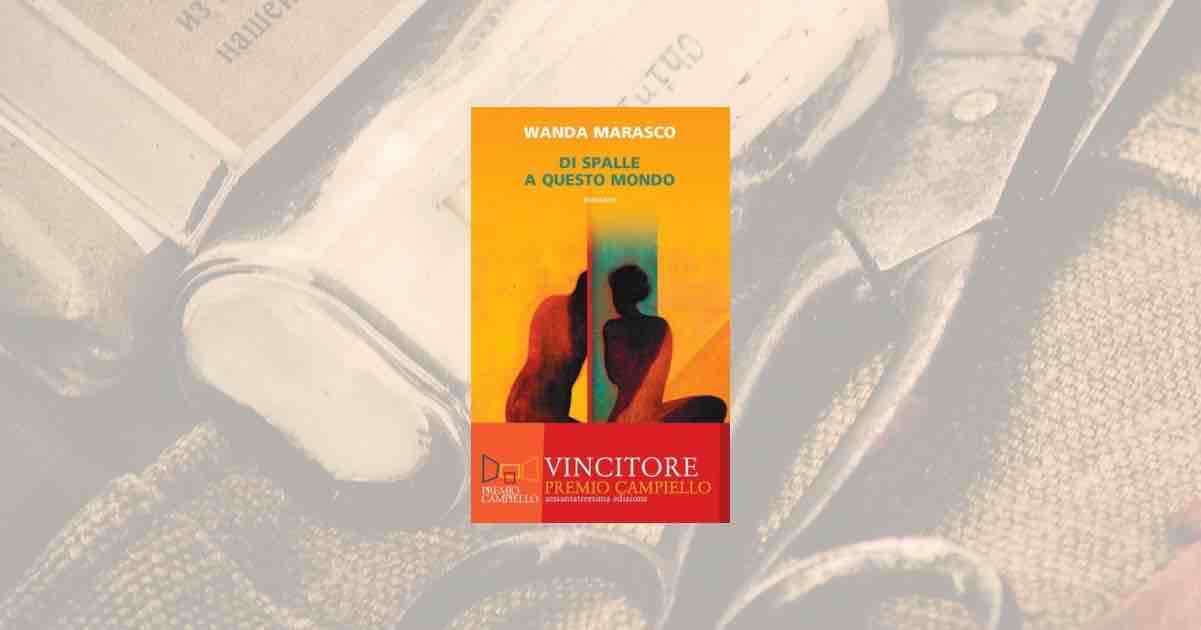Wanda Marasco si conferma una delle voci più raffinate della narrativa italiana contemporanea con “Di spalle a questo mondo” edito Neri Pozza (2025).
Il libro ha prima trionfato alla 63ª edizione del Premio Campiello, poi al Premio Costa Smeralda 2025, nella Sezione Narrativa. È entrato nella dozzina finalista del Premio Strega e ha ottenuto una menzione al Premio Internazionale Flaiano 2025, nella sezione Over 35; tutti riconoscimenti che non sorprendono, perché Marasco ha costruito un romanzo denso, potente, di straordinaria coerenza etica e linguistica, che affronta la storia come un corpo vivo, fatto di ferite e resurrezioni.
Di spalle a questo mondo ci sono Ferdinando Palasciano e Olga Vavilova
Al centro del romanzo ci sono Ferdinando Palasciano, chirurgo napoletano realmente esistito tra il 1815 e il 1891, e Olga Pavlova Vavilova, giovane moglie russa. Palasciano fu il primo a proclamare la neutralità dei feriti di guerra, gesto che aprì la strada alla futura Croce Rossa Internazionale.
Ma Marasco non si limita alla biografia del chirurgo: la trasforma in materia drammatica e visionaria. Ferdinando diventa un personaggio spezzato tra lucidità e follia, prigioniero della sua stessa etica; Olga, invece, è la voce che porta nella narrazione il principio della fragilità: una donna claudicante, segnata da una zoppia che diventa metafora del vivere.
“Non si guarisce dal male, si impara a starci dentro.”
(Wanda Marasco, “Di spalle a questo mondo”)
La lingua come atto di resistenza
La prosa di Marasco non accompagna, si oppone. Ogni frase è un’onda lunga che chiede di essere abitata.
È una lingua musicale e vischiosa, che fonde il dialetto napoletano alla dizione poetica, alternando ritmo e sospensione. Un narrato che rende il tutto più realistico, accompagnando il lettore in un mondo più vicino alla realtà che viene narrata. Come in tutta la sua produzione, l’autrice parte dal corpo per raggiungere il pensiero: il respiro del malato, la mano che trema, la parola che fatica a uscire.
È qui che il romanzo trova la sua forza etica: nella cura linguistica come forma di cura umana.
Napoli come organismo narrante
Napoli, nel romanzo, non è sfondo. È materia viva, teatrale, ambigua: dagli ospedali ai chiostri, dai vicoli umidi ai venti di via Toledo, la città partecipa alla narrazione come voce autonoma.
Marasco la ritrae come una creatura respirante, dove scienza e superstizione convivono, e dove la salvezza è sempre impura.
La città, con le sue pietre e la sua luce, è il vero laboratorio morale del libro: tutto nasce da lì, anche la domanda centrale del romanzo “Si può curare ciò che non vuole guarire?”.
Il dramma dell’imperfezione
La coppia Palasciano–Vavilova incarna due visioni opposte e complementari: lui, mosso da un’ossessione per la perfezione scientifica e lei, simbolo della imperfezione necessaria, della caduta che genera senso. Nel loro incontro si consuma una battaglia metafisica tra guarire e accettare, tra ideale e limite.
Quando Olga chiede: “Voi non credete che quando ci spezziamo è per sempre?”, Marasco tocca la ferita che riguarda ogni vita: la consapevolezza che la fragilità è irriducibile, e proprio per questo umana.
Palasciano, l’uomo che inventò la neutralità
Storicamente, Ferdinando Palasciano fu uno dei precursori della Croce Rossa. Nel 1848, durante l’insurrezione di Messina, disobbedì all’esercito borbonico pur di curare i nemici feriti. Arrestato e processato, trasformò la sua condanna in un atto politico di compassione universale.
In “Di spalle a questo mondo”, questo episodio è riletto come tragedia interiore. L’etica diventa follia, la coscienza si piega sotto il peso della colpa. Marasco evita ogni eroismo: ciò che le interessa è il costo del bene, il prezzo che si paga quando la morale è più grande della vita stessa.
Cosa scrive la stampa internazionale
Anche la stampa estera ha notato la forza di questo romanzo, soprattutto dopo la vittoria al Campiello:
- “The book chosen from among the five finalists by the Jury of Three Hundred Readers was “Di spalle a questo mondo”, by Wanda Marasco, an intense meditation on human imperfection and moral courage.”
“Il libro scelto tra i cinque finalisti dalla Giuria dei Trecento Lettori è Di spalle a questo mondo, di Wanda Marasco, un’intensa meditazione sull’imperfezione umana e sul coraggio morale.”
Fondazione Pirelli Newsroom (EN) - “Marasco obtained 86 votes… Her novel explores the act of care as a political gesture that transcends time and nationality.”
“Marasco ha ottenuto 86 voti… Il suo romanzo esplora l’atto della cura come gesto politico che trascende il tempo e la nazionalità.”
Italians in the World Magazine (EN) - “Costa Smeralda Award 2025: Fiction goes to Wanda Marasco for a story of healing and loss.”
“Premio Costa Smeralda 2025: la narrativa va a Wanda Marasco per una storia di guarigione e perdita.”
Unione Sarda International (EN) - A queste si aggiungono le riflessioni accademiche, come quelle della International Review of the Red Cross e della University of Chicago Press, che riprendono la figura di Palasciano come precursore dell’etica umanitaria moderna.
L’arte della cura
Il vero motore del libro è l’arte della cura, non la guarigione e neppure la pietà: è resistenza al disumano. Ferdinando e Olga curano animali, pazienti, bambini siciliani; ma, nel farlo, curano anche se stessi.
La malattia mentale del protagonista, lungi dall’essere condanna, diventa porta percettiva: un modo diverso di vedere il mondo, un’altra luce sulla realtà.
Come scrive Marasco, “l’abbandono, se accettato, è la forma più alta della conoscenza.” È una filosofia della debolezza fertile, che oppone al culto della performance la lentezza della compassione.
Lo stile: tra teatro e poesia
Ogni scena sembra costruita come una camera teatrale: i dialoghi hanno una musicalità antica, le descrizioni dei corpi ricordano la pittura sacra, e i pensieri dei personaggi oscillano tra lirismo e delirio.
Marasco unisce la lingua delle madri e dei medici, quella appresa nello studio e quella raccolta nei vicoli.
“La lingua della cura è anche la lingua della poesia.”
(Wanda Marasco)
Con pochi termini sontuosi, ma con una precisione chirurgica, l’autrice riesce a dare parola all’invisibile – a quella parte di noi che continua a tremare ogni giorno