“Cuore di cane”: Bulgakov, la censura sovietica e l’uomo nuovo
Quando Bulgakov scrisse “Cuore di cane” e criticò l’uomo nuovo sovietico sfidando la censura, tra fantascienza e critica politica. Un racconto sopravvissuto.
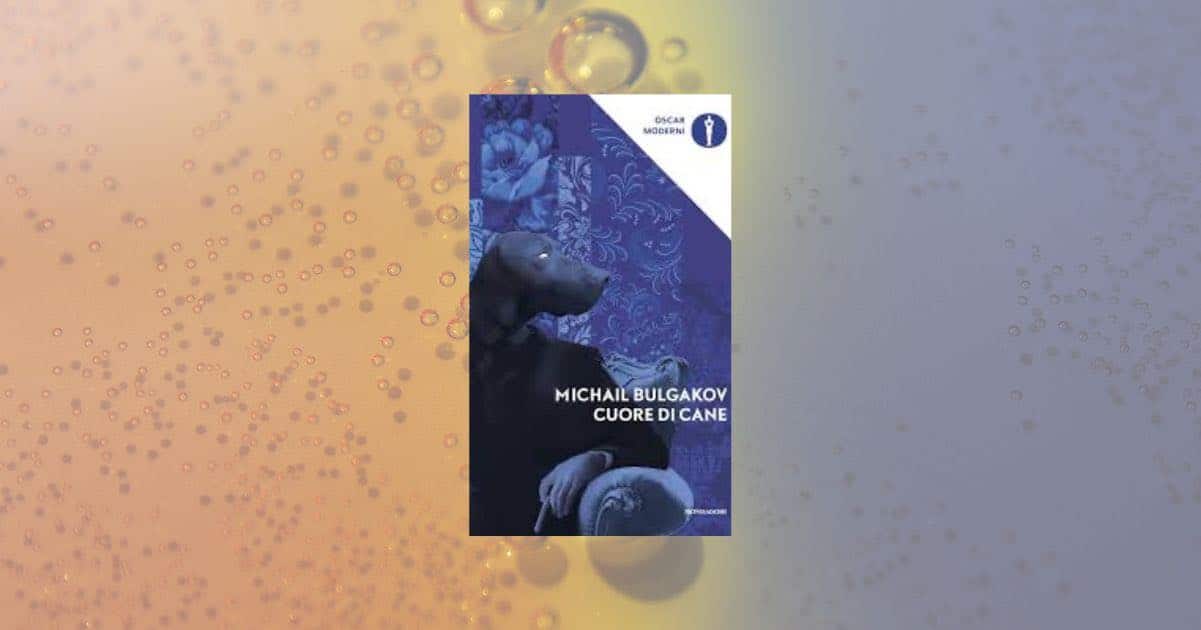
Per capire cosa si nasconde dietro “Cuore di cane”, il racconto di Bulgakov, bisogna tornare a dopo la Rivoluzione d’Ottobre (1917), quando il regime comunista si era imposto di plasmare una figura grandiosa sulle linee guida della propaganda: un uomo collettivista, razionale e disciplinato, dedito al lavoro, moralmente puro ed educato secondo la scienza marxista-leninista che potremmo considerare un po’ come una controparte del superuomo di Nietzsche.
Una “dedica” non proprio gradita
È a quest’uomo immaginario che Michail Bulgakov, nel 1925, dedica il suo “Cuore di cane”: un racconto che rimase a lungo nei cassetti di chi, come lui, quella propaganda non riusciva proprio a mandarla giù; e sopravvisse per miracolo, solo grazie al cosiddetto samizdat, la diffusione clandestina di copie dattiloscritte che circolavano di mano in mano, sfidando i divieti imposti dal regime.
Era un libro pericoloso, un’attacco diretto all’utopia sovietica, per questo venne immediatamente censurato e solo nel 1987, in piena ricostruzione, poté finalmente essere stampato in Unione Sovietica.
Un cane e uno scienziato: cosa può andare storto?
La trama è nota a tutti: un cane randagio di nome Sharik viene accolto dal professor Filipp Filippovič Preobraženskij, celebre chirurgo di Mosca, ma — per citare un bellissimo titolo — “I russi cono matti” e lo scienziato decide di sottoporre la povera bestiola a un esperimento inaudito: un trapianto d’ipofisi e ghiandole sessuali umane. Fa così ingresso nella narrazione un alcolizzato di nome Klim Čugunkin, uomo appena morto che sarà fulcro del racconto tanto quanto il nostro cane.
Di per sé la trama è abbastanza grottesca: un innesto in stile “Creatura” del Dr. Frankenstein, ma su un animale vivo e vegeto. L’orrore di Villa Diodati riproposto in un clima glaciale a puro scopo di critica…
Ma dall’operazione di Filipp Filippovič Preobraženskij non nasce un cadavere fatto di parti diverse: nasce un essere nuovo un “uomo nuovo”, che poco alla volta assume sembianze umane e diventa Šarikov: volgare, aggressivo, incapace di cultura. Da animale fedele a cane randagio, da creatura innocente a uomo mostruoso.
Una satira feroce
Negli anni della NEP (la Nuova Politica Economica), la Russia viveva una fase di apparente apertura, ma la censura restava implacabile. Bulgakov, medico prima che scrittore, conosceva bene le contraddizioni del regime: le sue opere teatrali venivano spesso vietate, e solo la protezione indiretta di Stalin gli permise di continuare a lavorare.
La prosa folle, la mente visionaria, la satira decisa e la penna ironica, Bulgakov fu sempre una spina nel fianco del potere. Non a caso, “Cuore di cane ” rimase nell’ombra per oltre sessant’anni.
Tra il comico e il grottesco
La forza del libro sta nella sua ambivalenza, tra scene che strappano un sorriso e altre estremamente inquietanti e tragiche. Questo il paradosso di Bulgakov: un autore che ha saputo usare la leggerezza per colpire in profondità. Non sorprende che la critica contemporanea lo legga ancora come un testo attuale. The Guardian, per esempio, ha scritto:
“This satire of life in the early years of the Soviet Union […] has not lost its provocative power.”
“Questa satira sulla vita nei primi anni dell’Unione Sovietica […] non ha perso la sua forza provocatoria.”
E sul sito Biblioklept si può leggere:
“Una parabola feroce sulla Rivoluzione russa, in cui il cane è il popolo russo, brutalizzato e sfruttato, e il trapianto è la rivoluzione stessa.”
Impianti ed espianti d’organi
Se guardiamo al panorama letterario contemporaneo, il libro di Bulgakov trova un curioso parallelo in “Povere creature” — “Poor Things” — di Alasdair Gray, pubblicato nel 1992 e adattato su pellicola nel 2024. Anche qui c’è un esperimento estremo: il dottor Baxter impianta il cervello di un feto vivo nel corpo della madre appena morta, dando vita a Bella Baxter, una donna nuova che non accetta i limiti della società patriarcale.
Anche in Bulgakov c’è un impianto, ma in un cane vivo, e gli organi che riceve sono di minor importanza rispetto a quello che ha dato vita a Bella Baxter. Sono organi espiantati da un uomo morto, Klim Čugunkin, che trasformano il cane umile dell’inizio in un mostro — come la Creatura di Shelley.
Due visioni opposte: da una parte, la scienza come fallimento e degenerazione; dall’altra, la scienza come occasione di rinascita e autodeterminazione. Šarikov è la caricatura di un sistema che tenta di plasmare l’uomo e lo rovina. Bella è l’allegoria di una seconda nascita, libera dagli schemi imposti, simbolo di emancipazione. In entrambi i casi, però, resta la stessa domanda: “Chi decide cosa significa essere umani?” Forse, la Creatura.
Un medico e uno scrittore
Bulgakov, nato a Kiev nel 1891 e morto a Mosca nel 1940, non vide mai il riconoscimento delle sue opere. Medico di formazione, scelse la letteratura e la satira come armi, pagando il prezzo della censura.
La sua fama arrivò solo postuma, con il tanto amato e conosciuto “Il Maestro e Margherita”, che lo consacrò come uno dei grandi del Novecento; tuttavia, “Cuore di cane” resta una delle sue opere critiche che andrebbero lette almeno una volta nella vita: irriverente, capace di svelare i paradossi di un regime che voleva rifare l’uomo e finì per distruggersi.