Cos’è lo slipstream? Un genere amato da scoprire
Slipstream: il genere letterario che scivola tra sogno e realtà. Da Ishiguro a Kelly Link, dove l’assurdo diventa la forma più vera del reale.
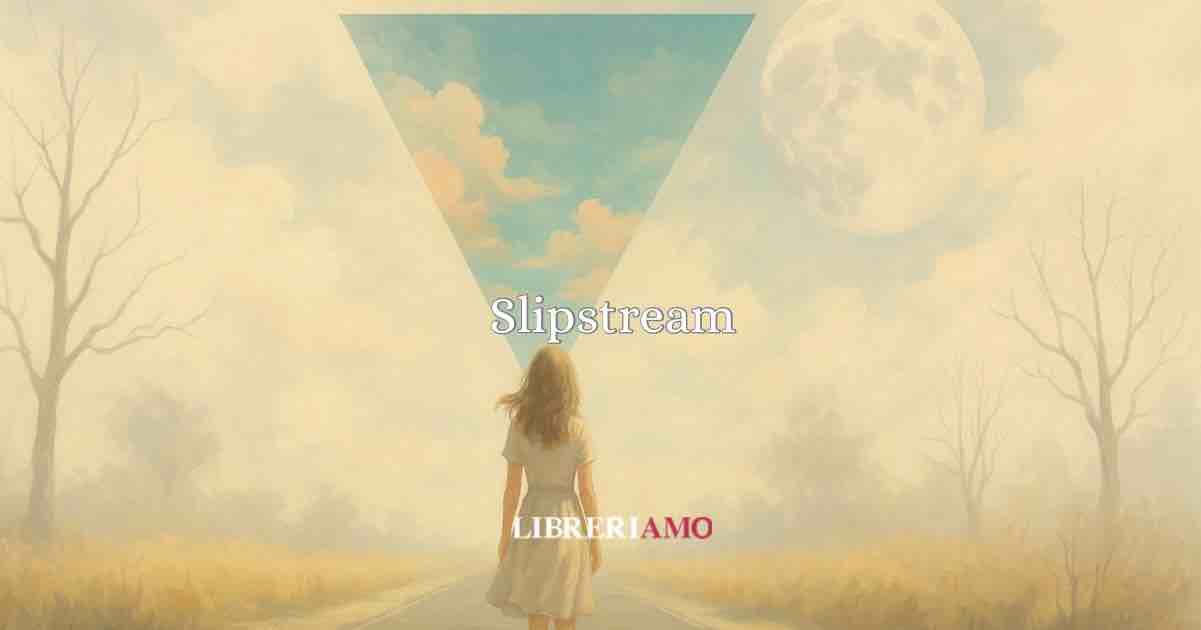
Esistono libri dalla difficile collocazione, che non appartengono a nessun genere, eppure a tutti un po’; che partono dal reale e finiscono in un altrove, come se all’improvviso si aprisse un varco e trascinasse la trama con sé.
In questa fascia si colloca lo slipstream, il genere “delle soglie”, dove le storie scivolano da un genere all’altro — superano la soglia, per l’appunto — fra il realistico e il fantastico, fra ciò che è possibile e ciò che non dovrebbe esserlo.
Un genere che non si lascia afferrare
Il termine compare per la prima volta nel 1989, quando Bruce Sterling lo usa per descrivere opere che “inducono nel lettore una sensazione di straniamento”, simile a quella della fantascienza, ma senza dipendere da regole scientifiche o mondi alternativi.
Dove la realtà scivola nell’assurdo
Lo slipstream è, in un certo senso, il “realismo magico postmoderno”: non ha bisogno di draghi o astronavi, ma di piccoli slittamenti che incrinano il reale e lo rendono inquietante, ironico o meraviglioso.
Da dove viene
L’idea di realtà “scivolosa” ha antenati illustri: Kafka, Borges, Calvino, Murakami; tuttavia, è negli anni ’90 che lo slipstream si afferma come etichetta vera e propria. Riviste come “Interzone” e “Asimov’s Science Fiction Magazine” iniziano a pubblicare autori che mescolano quotidiano e surreale, rifiutando l’etichetta di sci-fi o fantasy.
Da allora, il termine è diventato sinonimo di narrativa liminale, una frontiera tra letteratura di genere e letteratura alta.
Le caratteristiche
Non esistono regole formali per identificare lo slipstream, ma alcuni tratti sono ricorrenti:
- Lo straniamento: il mondo è riconoscibile ma leggermente deformato, come un riflesso in uno specchio d’acqua.
- L’ambiguità: non c’è mai una spiegazione definitiva per ciò che accade tutt’attorno.
- L’emotività sospesa: lo stupore convive con il disagio.
- Lo stile ibrido: prosa lirica e dettagli realistici convivono con elementi onirici o simbolici.
- La critica del reale: spesso i racconti slipstream sono allegorie della contemporaneità, dei media, dell’identità o della memoria.
Gli autori che l’hanno reso riconoscibile
Tra i nomi più rappresentativi troviamo Kelly Link, Jeff VanderMeer, Margaret Atwood, Ted Chiang, Haruki Murakami, George Saunders e Kazuo Ishiguro: tutti autori che non si riconoscono nei confini rigidi dei generi, ma che condividono una tensione comune, raccontare il nostro tempo attraverso l’assurdo, come se l’unico modo per dire la verità fosse distorcerla un po’.
“Non lasciarmi” di Kazuo Ishiguro
Forse il romanzo più emblematico dello slipstream. Pubblicato nel 2005, parte come un racconto intimo e nostalgico, ambientato in un collegio inglese, e si trasforma lentamente in una rivelazione terribile. La protagonista, Kathy, ripercorre i ricordi dell’adolescenza accanto agli amici Ruth e Tommy, in un luogo dove l’educazione è gentile e il destino, inconfessabile. Il romanzo procede come un sogno malinconico in cui il lettore scopre, quasi senza accorgersene, che la realtà non è come sembra: sotto la superficie di un dramma sentimentale si cela un mondo distopico.
Ishiguro non offre spiegazioni: il mistero resta sospeso, e proprio in questa sospensione si annida la forza del romanzo. “Non lasciarmi” non è né fantascienza né realismo, ma un territorio intermedio dove la normalità diventa metafora dell’etica, della memoria e della perdita.
“Ne succedono anche di più strane” di Kelly Link
Tra le scrittrici dell’ultima generazione, Kelly Link è già una certezza nel panorama della narrativa americana. Con “Ne succedono anche di più strane” (Donzelli, traduzione di Riccardo Duranti), porta in Italia una raccolta che rappresenta alla perfezione l’essenza dello slipstream: un realismo deformato, esilarante e inquieto, che cancella i confini tra il quotidiano e il surreale.
Le sue storie sono piccole detonazioni di fantasia: un bibliotecario si innamora di una ragazza il cui padre colleziona nasi finti; un defunto invia lettere alla moglie dimenticandone il nome; una donna impara a scomparire; sei aliene bionde invadono New York; la moglie di un ex dittatore raccoglie le scarpe delle vittime del marito. Ogni racconto è una variazione sull’assurdo, sospeso fra humour e crudeltà, dove l’invenzione non serve a fuggire dal reale ma a scoprire la verità attraverso la distorsione.
Con uno stile scintillante, Kelly Link mescola cultura pop, mito e ironia nera, trasformando il quotidiano in teatro dell’impossibile. I suoi personaggi svaniscono, gli oggetti parlano, la logica si incrina: non c’è mai un confine netto tra sogno e veglia, e proprio per questo le sue storie colpiscono come rivelazioni. In un mondo “allucinato e postmoderno”, la sua scrittura mostra che l’unico modo per raccontare la realtà è lasciarla scivolare un po’ più in là — proprio come fa lo slipstream.
“Lincoln nel Bardo” di George Saunders
Un romanzo monumentale e surreale sulla perdita, l’amore e l’umanità di un padre — che accade a essere il Presidente degli Stati Uniti.
Ambientato nel febbraio del 1862, “Lincoln nel Bardo” intreccia la tragedia personale di Abraham Lincoln — la morte del figlio undicenne Willie — con l’immensità della Guerra Civile americana. Il dolore privato del Presidente si riflette nella ferita collettiva della nazione: un paese lacerato, in bilico tra vita e morte, proprio come il limbo in cui si trovano le anime che popolano il romanzo. È in questo spazio sospeso, ispirato al “Bardo” del “Libro tibetano dei morti”, che Saunders costruisce la sua stupefacente invenzione narrativa.
Attraverso un coro di voci — defunti che ancora si credono vivi, spiriti vanitosi, saggi e ridicoli — il lettore entra in un aldilà brulicante di umanità, dove il tempo è liquido e la logica si piega alla memoria e al rimpianto. Willie Lincoln è l’innocente che non sa di essere morto; il padre, in visita notturna alla tomba, è il vivo che si comporta da morto, prigioniero della sua stessa disperazione. Intorno a loro, l’intera comunità dei trapassati vibra di un’energia teatrale, ironica, a tratti straziante.
Saunders fonde la ricerca storica con la visione poetica, l’umorismo con la pietà, in un’esperienza narrativa senza paragoni. Il romanzo — costruito come un collage di testimonianze, articoli e confessioni ultraterrene — diventa una meditazione sull’attaccamento, sulla compassione e sul mistero della coscienza. In una sola notte, tra i vivi e i morti, “Lincoln nel Bardo” racconta l’unica guerra che nessuno può vincere: quella contro la perdita.
Un’opera vertiginosa, premiata con il Booker Prize, che rilegge il lutto come esperienza collettiva e spirituale, in bilico tra la storia e il sogno.
“La città e la città” di China Miéville
Un noir filosofico e visionario dove la realtà si piega alle regole della percezione. China Miéville costruisce con “La città e la città” un’architettura narrativa di vertiginosa originalità: due città che occupano lo stesso spazio geografico, ma che vivono ignorandosi per legge.
Besźel e Ul Qoma sono gemelle siamesi urbane — separate non da muri ma da un atto di fede collettiva, una convenzione percettiva tanto rigida quanto assurda. Gli abitanti imparano sin da piccoli l’arte del non-vedere: evitare di riconoscere l’altro, anche quando cammina sullo stesso marciapiede. È un sistema politico e psicologico tanto sofisticato quanto inquietante, che diventa la chiave di lettura del romanzo e la sua metafora più potente.
La storia inizia come un giallo: l’ispettore Tyador Borlú indaga sull’omicidio di una giovane donna, ma presto l’indagine lo trascina oltre i confini (invisibili) delle due città. Insegue la verità tra strade che si intersecano e si negano, tra istituzioni burocratiche opache e un misterioso organismo chiamato Violazione, che punisce chi osa oltrepassare la soglia proibita. L’omicidio diventa così un viaggio iniziatico attraverso i limiti della percezione, della memoria e del potere.
Miéville fonde l’intelligenza del noir con la potenza concettuale della fantascienza distopica. Ogni pagina interroga ciò che scegliamo di vedere o ignorare, trasformando la topografia urbana in un dispositivo politico. La città e la città è un romanzo sull’identità, sul controllo e sulla cecità volontaria delle società moderne — un’allegoria lucidissima del nostro tempo.
Vincitore dei premi Locus, Arthur C. Clarke, British Science Fiction e World Fantasy, finalista al Nebula e ispiratore dell’omonima serie TV con David Morrissey, rimane una delle opere più geniali della narrativa speculativa contemporanea.
“L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio” di Haruki Murakami
Con la delicatezza ipnotica che lo contraddistingue, Haruki Murakami ci conduce nella mente di Tazaki Tsukuru, un uomo la cui vita è stata sospesa nel tempo da un trauma antico: l’abbandono improvviso e inspiegabile dei suoi amici più cari. Da allora, Tsukuru si è lasciato vivere come un’ombra, privo di colore e di forma, un essere “incolore” in un mondo che ha perso la sua musica.
Sedici anni dopo, però, qualcosa cambia: l’amore di una donna lo spinge a guardarsi dentro e a ripercorrere le strade della giovinezza. Ha bisogno di capire perché è stato escluso, e nel farlo inizia un pellegrinaggio fisico e spirituale attraverso il Giappone e la Finlandia. Ogni incontro con gli amici perduti riapre ferite ma anche varchi di luce, portando Tsukuru a confrontarsi con i limiti del perdono e della memoria.
Murakami intreccia realtà e simbolo, sogno e quotidiano, in una narrazione che alterna silenzi e rivelazioni, musica e introspezione. Come in un notturno di Liszt – cui il romanzo rende omaggio – la melodia di “L’incolore Tazaki Tsukuru” e i suoi anni di pellegrinaggio vibra di malinconia e speranza.
È un libro sulla solitudine e sull’identità, sull’amicizia che può salvarci o distruggerci, e sulla possibilità di rinascere dalle proprie assenze.