Cos’è la Metafiction contemporanea?
Con “Trust” di Hernán Díaz la metafiction torna protagonista: la letteratura si guarda allo specchio e riscopre la sincerità della finzione.
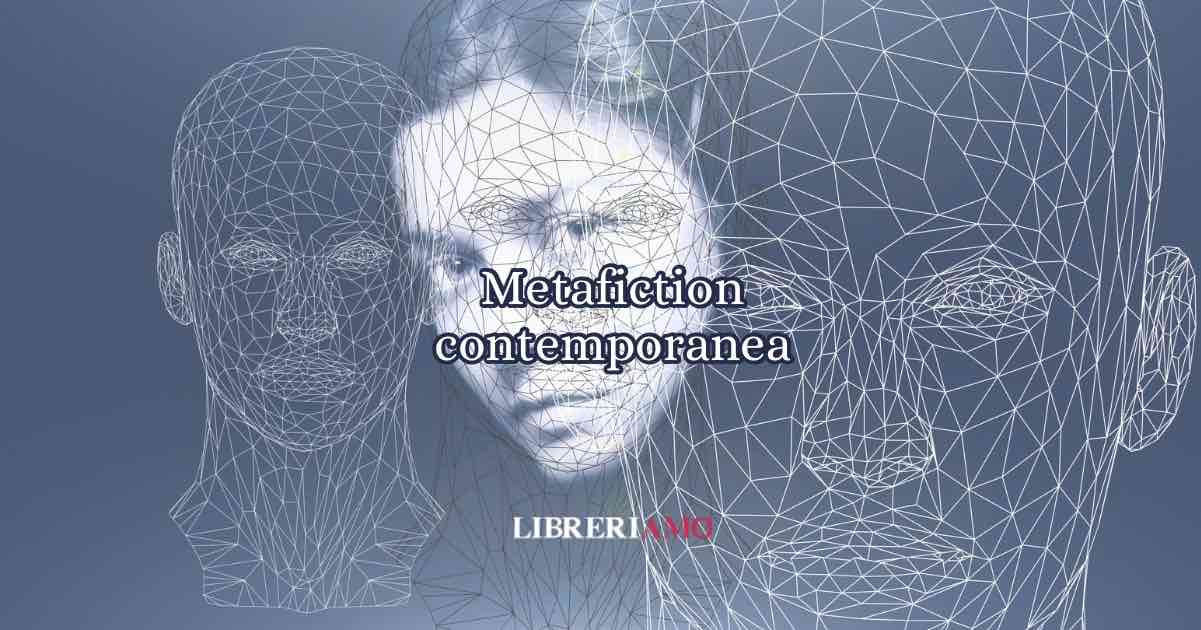
La metafiction è, in poche parole, quella narrativa consapevole di se stessa: il romanzo che mostra i propri meccanismi, che riflette — letteralmente — sul fatto di essere un’invenzione.
Il patto scrittore-lettore
Non è solo un gioco intellettuale dell’autore, ma un modo per interrogare la verità del racconto in un mondo dove le storie — politiche, mediatiche o digitali che siano — determinano la nostra percezione della realtà.
Insomma: noi che per leggere un romanzo dobbiamo “immedesimarci” con i protagonisti e cercare di calarci nelle loro storie il più possibile, addossando all’autore tutta la responsabilità dell’averci catturato o meno tra le pagine del libro, in questo tipo di narrativa sappiamo già cosa ci aspetta. Il classico patto di finzione narrativa tra scrittore e lettore non c’è proprio, non può rompersi. È una forma di sincerità. Dire al lettore “questa è una storia” non significa svuotarla; significa assumersi la responsabilità di come viene costruita la verità.
L’origine della metafiction
Negli anni Settanta, la metafiction era un esercizio postmoderno, spesso ironico e sperimentale; tuttavia, oggi è diventata una forma di onestà: un modo per dire al lettore “questa è una storia, ma dentro c’è la mia verità”. È così che il lettore accetta di diventare complice del gioco. Quando legge un libro di metafiction contemporanea, come di metafiction, il lettore si presta alla verità dello scrittore e inizia a giocare con lui.
Dall’autore onnisciente all’autore smascherato
Nel romanzo classico, lo scrittore restava invisibile; nella metafiction contemporanea, invece, entra in scena: annota dubbi, scelte, omissioni, e a volte dialoga con i propri personaggi in modo complice.
La voce narrativa diventa un personaggio essa stessa — ironica, fragile, autocritica — portando al suo contenuto continue modifiche che non sono fatte per inciampare nella narrazione, ma per ricordare a se stesso e al lettore che ogni storia è un costrutto; ed è proprio in questa consapevolezza che può nascondersi la forma più onesta di verità.
Un genere che nasce dal dubbio
La metafiction contemporanea risponde a una crisi: quella della fiducia nel linguaggio: dopo l’epoca delle grandi narrazioni, la letteratura ha imparato a dubitare delle proprie parole.
Il narratore non è più il onnisciente, ma un essere che scrive “sapendo di mentire”. Questo non toglie valore alla storia; anzi, la arricchisce, perché la spoglia dell’illusione di verità e la riporta alla sua natura originaria: un patto di fiducia tra chi scrive e chi legge.
Come la riconosci
Lo stile della metafiction contemporanea si riconosce da piccole incrinature nel tessuto narrativo: il narratore si interrompe, commenta ciò che sta scrivendo, anticipa che sta costruendo un artificio e invita a guardare dietro le quinte.
Spesso l’autore entra in scena, non più voce onnisciente ma personaggio vulnerabile. E poi compaiono libri dentro i libri: diari, manoscritti, articoli, che sembrano chiarire e invece complicano. In tutto questo, il linguaggio diventa protagonista: la prosa alterna lucidità analitica e fragilità emotiva, gioco e confessione. La finzione accetta di essere finzione — e proprio così diventa credibile.
Anche il linguaggio diventa protagonista: ogni parola pesa, perché il testo stesso si interroga sul proprio potere di rappresentare, di deformare, di creare mondi. La prosa alterna allora lucidità analitica e fragilità emotiva, gioco e confessione. È in questo equilibrio che la metafiction contemporanea trova la sua forza: nel trasformare la consapevolezza del falso in una nuova, sorprendente forma di sincerità.
I temi centrali
Tra i temi centrali della metafiction contemporanea c’è innanzitutto il rapporto con la verità: la pagina diventa un archivio di dossier, e-mail, ritagli, diari, atti legali, una macchina che imita la realtà per mostrarne le crepe. Invece di rassicurare, questi testi ci ricordano che ogni prova è costruita, che la verità è sempre un montaggio.
È un gesto politico, una presa di posizione nell’epoca delle fake news e dei deepfake: la letteratura non può più promettere oggettività, ma può offrire trasparenza dei dispositivi, cioè la consapevolezza di come si fabbrica il senso. Dentro questo orizzonte, l’autore non è più un demiurgo: si espone, si mette in discussione, sbaglia, si contraddice, entra nel testo e ne diventa materia viva.
Questa vulnerabilità non indebolisce la narrazione, la rende più umana e credibile, perché accetta la fallibilità di chi racconta. E infine c’è il lettore, che smette di essere spettatore e diventa co-autore: nessuna metafiction si lascia leggere passivamente. Chiede attenzione, pazienza, complicità. Ma in cambio restituisce la cosa più rara della narrativa contemporanea: la libertà di interpretare, di abitare la finzione come un territorio condiviso.
“Trust” di Hernán Díaz: il denaro come finzione perfetta
Romanzo-labirinto, “Trust” smonta e rimonta la storia di un magnate della finanza nella New York degli anni Venti. Non c’è una sola versione: quattro testi diversi — un romanzo fittizio, un manoscritto “autentico”, le memorie di un segretario e un’autobiografia — offrono prospettive incompatibili sullo stesso enigma: chi ha creato davvero quella ricchezza? E chi ha pagato il prezzo umano di quel mito?
Díaz non gioca per confondere: usa la forma a specchi per mostrare che la ricchezza è una narrazione capace di colonizzare la realtà. Ogni documento sembra una prova, ma si rivela una mossa retorica: un modo per manipolare fama, memoria, credito morale. Il piacere della lettura nasce proprio da questa danza tra indizi, lacune e correzioni. Il risultato è un romanzo elegante e affilato, dove la metafiction diventa un’indagine sul potere delle storie economiche: la Borsa, le biografie dei “self-made men”, le vite delle donne cancellate dagli archivi. Trust ci fa vedere che, nella modernità, il denaro è la finzione collettiva più efficace di tutte.