Cos’è il New Weird: quando il fantastico diventa organismo vivente
New Weird: città-organismo, ecologie mostruose, corpi ibridi. Da Miéville a VanderMeer, il fantastico che parla del nostro presente materiale.
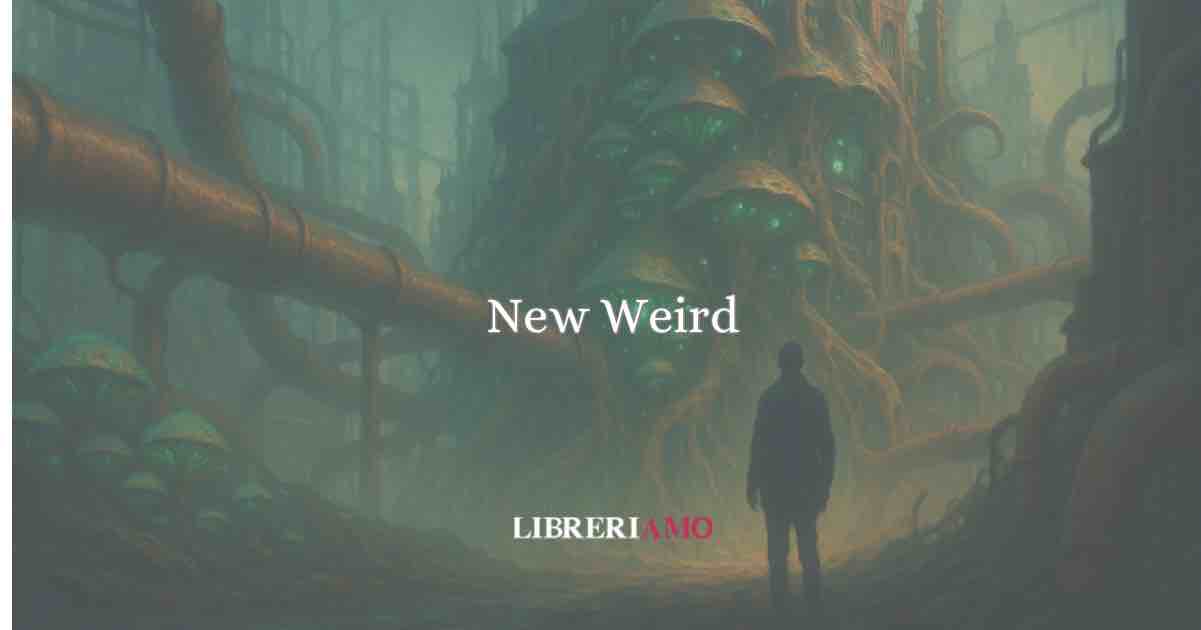
C’è un punto in cui fantasy, fantascienza e horror smettono di essere territori separati e si fondono in un unico ecosistema narrativo, un nuovo, viscerale e tangibile unicum. È qui che nasce il “New Weird” un genere fatto da città che sembrano creature, foreste che pensano, corpi ibridi, burocrazie allucinatorie, ecologie tossiche che si ribellano e ancora tanto altro… è un modo di scrivere il fantastico senza filtri; niente cornici rassicuranti a delinearne i limiti, niente magie “pulite”, niente bene contro male. Solo materia, politica, ambiente e desiderio, che si intrecciano in trame dove l’alterità è fisica prima di essere metafora.
Ma che cos’è davvero il New Weird e come nasce?
Definirlo è semplice e complicato allo stesso tempo. Semplice, perché possiamo dire: è la narrativa che, dai primi Duemila, riattualizza la weird fiction novecentesca — Lovecraft, Borges, M. R. James — e la mescola con sensibilità contemporanee. Complicato, perché il New Weird non ama essere chiusa in un recinto.
Prende dal fantasy la potenza del world-building, dallo sci-fi la curiosità verso scienza e tecnologia, dall’horror il turbamento, lo shock — e getta tutto in un frullatore.
Il suo lessico privilegiato non è la “magia” ma la biologia immaginaria: mutazioni, simbiosi, ibridazioni uomo-ambiente, città come organismi. Il tono è sensoriale e “umido”: si sente l’odore del metallo, della muffa, del sangue, del vento che spira nei cunicoli. E soprattutto: c’è sempre un sottotesto sociale. Non per predicare, ma per mostrare come i corpi — umani e non — vengano modellati da poteri economici, ecologici, coloniali.
Da dove arriva?
Ogni rivoluzione ha i suoi antenati. Per il New Weird, i precursori sono M. John Harrison con il ciclo di “Viriconium” — che smonta la mappa confortevole del fantasy—, tutta la tradizione lovecraftiana — l’indicibile, che però qui diventa materia viva —, Borges — con la sua logica del possibile/impossibile —, e la fantascienza più inquieta degli anni ’70 e ’80.
La svolta avviene tra fine Novanta e primi Duemila con China Miéville e Jeff VanderMeer, due poli stilistici diversi, entrambi decisivi. L’antologia/manifesto “The New Weird” curata da Ann & Jeff VanderMeer ha solo messo ordine a un movimento già in atto: un modo di raccontare il mondo come sistema vivente.
Le “regole” del New Weird
Nel New Weird la città non è un semplice sfondo: è un corpo vivo. L’urbanistica si comporta come una biologia – gallerie che paiono viscere, quartieri come tessuti, infrastrutture che respirano a tratti. È un mondo umido, pulsante, dove il meraviglioso non arriva dalla magia ma da scienze immaginarie: biotech che produce manufatti organici, mutazioni che sfidano ogni tassonomia, ibridi che costringono a rivedere cosa chiamiamo “umano”.
Anche i generi si sciolgono l’uno nell’altro. Un’indagine di polizia può scorrere dentro un noir industriale, sfociare nell’eco-horror e, senza avvisare, aprirsi alla fantapolitica. Niente gerarchie, niente recinti: la storia prende la forma del suo ecosistema. In questo paesaggio, il “mostro” smette di essere il male: è un’altra lingua che chiede di essere capita, spesso più innocente delle persone che lo temono. E la politica non è uno strato sopra il racconto: è materia. Si parla di lavoro sfruttato, di colonialità, di estrazione di risorse, di crisi climatica; la cornice non è mai neutrale perché i corpi—tutti i corpi—ne portano i segni.
La prosa segue questa fisicità. È densa, tattile, a volte barocca, a volte spigolosa, ma sempre corporalizzata: senti il metallo, la muffa, la pelle, il vento nei cunicoli. Leggere New Weird significa percepire il mondo sulla pelle prima ancora che capirlo con la testa.
I temi del New Weird parlano direttamente di noi: nell’era dell’Antropocene l’ambiente non è più uno sfondo immobile, ma risponde alle paure climatiche, all’inquinamento, alle specie in fuga, perfino alle simbiosi non consensuali, che diventano trama; è la natura che si riprende la parola e impone nuove regole ai corpi.
Quei corpi, spesso non normativi, sono al centro. Il “mostruoso” non serve a scioccare, ma a creare empatia con le identità queer, i disabili, e al “post-umano”. Entrano nel racconto per mostrarci che la differenza non è un errore di sistema: è la misura con cui il sistema va ripensato.
Anche la città smette di essere scenografia e rivela il suo doppio volto: macchina di estrazione che ti usa e ti contiene, ma anche organismo che produce (e consuma) valore.
E dietro le quinte agisce la colonialità: mondi invasi, risorse saccheggiate, culture tradotte e deformate. L’alterità non è più un esotismo da cartolina, è un contratto di forza che i romanzi mettono a nudo, chiedendoci da che parte stiamo.
Perché nasce
Il New Weird è figlio dell’epoca in cui la natura non è più sfondo ma controparte. Con l’Antropocene, l’ambiente è attore, e la narrativa lo riconosce: l’ecosistema non è decorazione, è soggetto, con volontà e agentività. Da qui la centralità di funghi, muffe, polveri, venti, città tossiche, animali “altri”. È anche una risposta alla stanchezza per il fantasy consolatorio: non più saghe cavalleresche, ma mondi di attrito, dove ogni passo apre un dilemma etico.
Due romanzi-simbolo
“Perdido Street Station” di China Miéville
Benvenuti a New Crobuzon, metropoli-mostro d’ispirazione vittoriana/industriale, dove caldaie e binari si innestano su un tessuto urbano multietnico e violento. Qui convivono umani e razze ibride (gli uomini-scarabeo, le garuda alate, i remade, corpi “ricuciti” come punizione). L’aria è spessa di fumo e di politiche spietate; la città è governata da un potere che mescola parlamento, polizia segreta, corporazioni, gang.
Isaac Dan der Grimnebulin, scienziato “eretico”, riceve un incarico impossibile da un garuda a cui hanno strappato le ali. Nel tentativo di restituirgli il volo, Isaac sperimenta con energie poco ortodosse e — complice una serie di scelte sbagliate e compromessi — finisce per liberare una creatura predatrice, bellissima e letale, capace di nutrirsi dei sogni degli abitanti. Da lì in poi la trama si trasforma in una caccia disperata attraverso i visceri della città: mercati clandestini, laboratori, teatri, quartieri operai, il fiume che porta via i rifiuti, i tetti percorsi dal vento.
Il cuore del romanzo, però, non è la “bestia” da fermare, ma New Crobuzon stessa: un organismo che reagisce, soffre, contratta, punisce; un laboratorio politico dove i diritti dei corpi sono moneta di scambio. Attorno a Isaac ruotano artisti in crisi, attivisti, criminali eleganti, sindacalisti: frammenti che compongono un mosaico urbano traboccante di vita. La scrittura di Miéville è densa, allusiva, di un barocco industriale che sa di metallo e sudore. Non c’è nostalgia: c’è materialismo visionario. Ed è questa miscela — politica + biologia + città-personaggio — a rendere “Perdido Street Station” l’emblema del New Weird.
“Annientamento” di Jeff VanderMeer
La Zona X è apparsa senza spiegazioni lungo una costa: un’area “contagiata” dove la realtà cambia, gli animali si comportano in modo diverso, le piante orchestrano geometrie impossibili, le strutture si svuotano e insieme si riempiono di qualcos’altro. L’agenzia governativa Southern Reach organizza spedizioni per capire; molte non tornano.
La protagonista — mai nominata, indicata come la biologa — parte con un piccolo gruppo tutto femminile. La missione ha un protocollo militare, ma ogni passo nella Zona disarticola il protocollo e ricompone i sensi: odori di salmastro e putrefazione, tracce luminose sulle pareti di un “tunnel” (o torre?) che sprofonda nel terreno, silenzi assoluti alternati a ronzii che sembrano respirare. La biologa tiene un diario. Scopre che le regole non valgono; o meglio: valgono altre regole, organiche, come se l’ecosistema avesse un’intelligenza propria.
“Annientamento” non offre spiegazioni rassicuranti: il mistero non si risolve, si metabolizza. VanderMeer porta l’orrore fuori dalla dimensione demoniaca e lo installa nel vivente: funghi che archiviano memoria, vegetazione che “scrive”, confini che reagiscono a chi li attraversa. È eco-horror e insieme romanzo di conoscenza: l’indagine scientifica diventa un’esperienza mistica. La lingua è ipnotica, rarefatta, fatta di registri sensoriali. L’effetto è quello di una trasformazione: la Zona X cambia i personaggi e, un po’, cambia anche il lettore.
Come si distingue da fantasy, grimdark e slipstream
- Dal fantasy classico: niente medioevo, niente missione salvifica. Il New Weird abita epoche industriali, urbane o post-naturali, e sostituisce la magia con scienze immaginarie. Il meraviglioso non è sacro: è biologico e spesso ripugnante, come la vita quando la guardi da vicino.
- Dal grimdark: condividono l’assenza di manicheismi e la crudeltà del mondo, ma il grimdark è un’etica del disincanto, una politica della sopravvivenza morale. Il New Weird si concentra sull’ecologia del mostruoso: corpi e ambienti che cambiano insieme, responsabilità verso l’alterità, critica dei sistemi (urbani, economici, coloniali) che modellano la materia.
- Dallo slipstream: lo slipstream deforma il reale in chiave psicologica e lascia il lettore nel dubbio (“È successo davvero?”). Il New Weird materializza l’impossibile: la città ha branchie, la foresta ha memoria, gli oggetti biologici hanno agency. Meno ambiguità ontologica, più fisicità.