Colum McCann torna con “Twist”, il capolavoro sommerso
Colum McCann scende sotto la superficie: Twist segue una nave che ripara i cavi sottomarini e un trio di vite in bilico. Connessioni, lavoro, perdita.
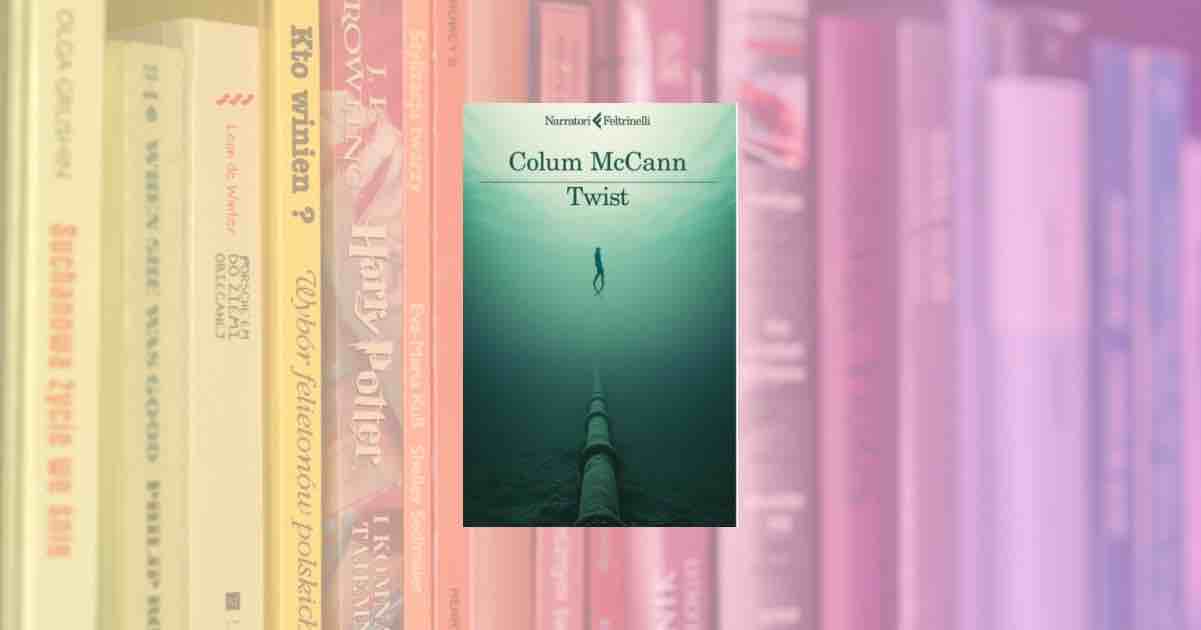
Colum McCann sceglie una storia scarna e fisica. Un giornalista irlandese, Anthony Fennell, si imbarca a Città del Capo su una nave di riparazione cavi, la Georges Lecointe. A bordo incontra John A. Conway, ingegnere apneista e capo missione, e Zanele, attrice sudafricana con una vita che non sta mai ferma. Da lì comincia un viaggio verso ovest e dentro le cose che non abbiamo mai voglia di guardare: la manutenzione di ciò che ci collega, le crepe che non si saldano.
Un giornalista in cerca di un pezzo: “Twist”
Fennell è l’occhio che registra. Viene mandato a raccontare come si riparano i cavi in fibra ottica posati sul fondo dell’oceano, quei tubi per cui scorrono le nostre parole, i pagamenti, le videochiamate. Scopre i tempi lenti del mare: si pesca il cavo con boe e argani, si porta a bordo, si “sbucciano” gli strati, si rifà la giunta, si cala di nuovo.
La vita di bordo diventa una scuola di pazienza, ma anche un detonatore: mentre la nave procede, emergono conti non tornati a terra – lutti, minacce, fallimenti – e il legame con Conway comincia a occupare tutto lo spazio narrativo.
Il carisma di Conway, la presenza di Zanele
Conway ha il magnetismo che fa spostare l’asse di un libro: competente, fisico, pieno di ombre. Zanele entra in scena con energia, e il romanzo le affida una traiettoria che pretende ascolto. In mezzo, Fennell: desidera capire, e nel capire è attratto, quasi fino all’emulazione. La dinamica – l’osservatore e l’uomo osservato – è una molla dichiarata da più critici, che hanno avvicinato Fennell a Nick Carraway davanti al suo Gatsby (“Il grande Gatsby” di Fitzgerald).
Le idee che attraversano il libro di Colum McCann
Connessione e fragilità
Le informazioni del pianeta corrono in tubi grandi come un braccio. McCann fa una cosa semplice e illuminante: porta la rete fuori dall’astrazione e la rimette nelle mani di chi la mantiene. È un romanzo pieno di dettagli tecnici – le giunzioni, i verricelli, la caccia al guasto – ma non si esaurisce lì: mostra quanto siamo dipendenti da un’infrastruttura reale e delicata. La critica inglese ha parlato di un testo “pieno di meraviglia” per il mondo naturale e “di rabbia” per la facilità con cui lo feriamo.
Riparazione e perdita
Saldare un cavo non significa guarire. È il filo più insistente del romanzo: la riparazione tecnica è possibile, ma le persone procedono con tempi irregolari. In varie presentazioni internazionali il libro è stato definito un racconto di “rottura e riparazione”; la prima si misura in metri e minuti, la seconda in giorni, mesi, forse anni.
Ecologia del fondo
Nelle pagine di mare convivono stupore e allarme: megattere, squali, crudezze della pesca industriale, fondali segnati. Qui “Twist” funziona molto: toglie l’audio alla retorica e fa parlare il paesaggio. Anche chi l’ha recensito in modo critico riconosce che nelle scene di bordo la scrittura è precisa, quasi da reportage.
Sguardo e potere
La nave parte da Città del Capo e opera al largo dell’Africa occidentale: il romanzo sa di muoversi su rotte cariche di storia. McCann ha discusso esplicitamente il tema nelle interviste, legando la vulnerabilità dei cavi alle ansie geopolitiche contemporanee. Ma il punto che resta addosso è un altro: cosa significa raccontare qualcuno che ammiri? Dove finisce il ritratto e dove comincia l’appropriazione?
Come è costruito
La voce
Quasi tutto passa dalla prima persona di Fennell. È una voce controllata, con lampi lirici e un’ironia che a tratti si concede, a tratti si nega. Kirkus Reviews ha parlato di “eleganza” nel mettere in scena una crisi che non chiede pietà; questo controllo formale è il pregio e, a volte, il freno del libro.
Il ritmo
La definizione che torna spesso è “teso e propulsivo”. Lo è nelle parti tecniche e nella lunga sezione della scomparsa di Conway, che spinge Fennell a uscire dal suo ruolo di testimone. Quando la storia si ferma in riflessioni molto generali – il senso della connessione, gli smarrimenti del nostro tempo – il ritmo si affloscia un po’. The New Yorker ha parlato di una meditazione “poetica ma vuota” in questi passaggi; il Washington Post di “prosa sentimentale” che velava intuizioni più pungenti.
La lingua
Nei momenti migliori, McCann “romanzerà” la manualità: il suono metallico delle attrezzature, la fatica dei turni, l’odore della sala cavi. Lì il libro brilla e non ha bisogno di spiegare. Il Guardian lo nota con chiarezza: l’invenzione narrativa sta nel farci toccare con mano una realtà che di solito ignoriamo.
I personaggi, tre modi di stare al mondo
Anthony Fennell
È un cronista che cerca di riacquistare passo: osserva, registra, desidera. La sua ammirazione per Conway gli restituisce slancio, ma lo espone al rischio di imitare invece di capire. Proprio questa ambivalenza è interessante: Fennell sa di essere imparziale solo fino a un certo punto, e la sua onestà non è un’arma, è un cantiere aperto.
John A. Conway
Capo missione, talento tecnico, apneista. È la figura che attiva il magnetismo del romanzo: affascina, irrita, sposta gli altri come marea. Quando sparisce, la storia deve reinventarsi: da inseguimento del carisma diventa ricerca, con un’energia nuova.
Zanele
Attrice, amante, città. Il libro le affida alcune tra le pagine più esposte, in cui l’autore interroga violenza e riscatto. Una parte della critica avrebbe voluto più densità e meno funzione allegorica; resta, comunque, una presenza che rompe la bolla maschile della nave e porta dentro la storia un altro ritmo.
Cosa funziona davvero
- L’ancoraggio materiale. Parlare di cavi sottomarini, e non solo di algoritmi, dà al romanzo una presa rara sul presente. Il Financial Times ha insistito su questo aspetto: dati, dipendenza tecnologica, connessioni che si spezzano e vanno cercate e riprese.
- Le scene di lavoro. Le manovre sul ponte, la giunta, la caduta in mare: qui Twist respira, e il lettore si sente a bordo.
- La figura del testimone. Fare il reporter significa anche accettare che il proprio sguardo può contaminare ciò che guarda. McCann non la risolve: la lascia vibrare.
“Enigmatico e attualissimo. Ingegnoso.” – The New York Times Book Review.
Dove zoppica (e perché non è un difetto incurabile)
- Le astrazioni generiche. Quando al posto della scena arrivano pagine teoriche sul nostro tempo, il magnete si indebolisce. È il punto su cui convergono le riserve di New Yorker e Washington Post.
- Zanele “idea” più che persona. In alcuni passaggi sembra chiamata a reggere tesi più che vita; è però anche vero che la sua traiettoria impone a Fennell di cambiare posto nel racconto.
Le parentele utili (per capire il gioco)
- Conrad, ma spostato. Non più il fiume, non più la selva: l’ombra sta sul fondo marino, dove corrono tubi che reggono il mondo. La citazione di Salman Rushdie – usata in bandella – lo dice con efficacia, senza bisogno di sovrainterpretare.
- Gatsby in coperta. L’assetto “narratore affascinato / uomo magnetico” aiuta a leggere le posture e a non cedere all’idolatria della figura di Conway.
- Il McCann che conosciamo. C’è il legame tra vite e il lavoro sul lutto che abbiamo amato in Apeirogon, ma il formato è più lineare, quasi cameristico.
Cosa ha detto la critica
“Another astounding novel from a fiction master.” – Kirkus Reviews, recensione con stella.
“Pieno di meraviglia… e di rabbia per ciò che facciamo alla natura.” – The Guardian.
“Meditazione poetica… che a volte resta senza presa sui personaggi.” – The New Yorker.
Il ventaglio è ampio: entusiasmi solidi, obiezioni nette. È un buon segno. I libri che restano, di solito, dividono.